
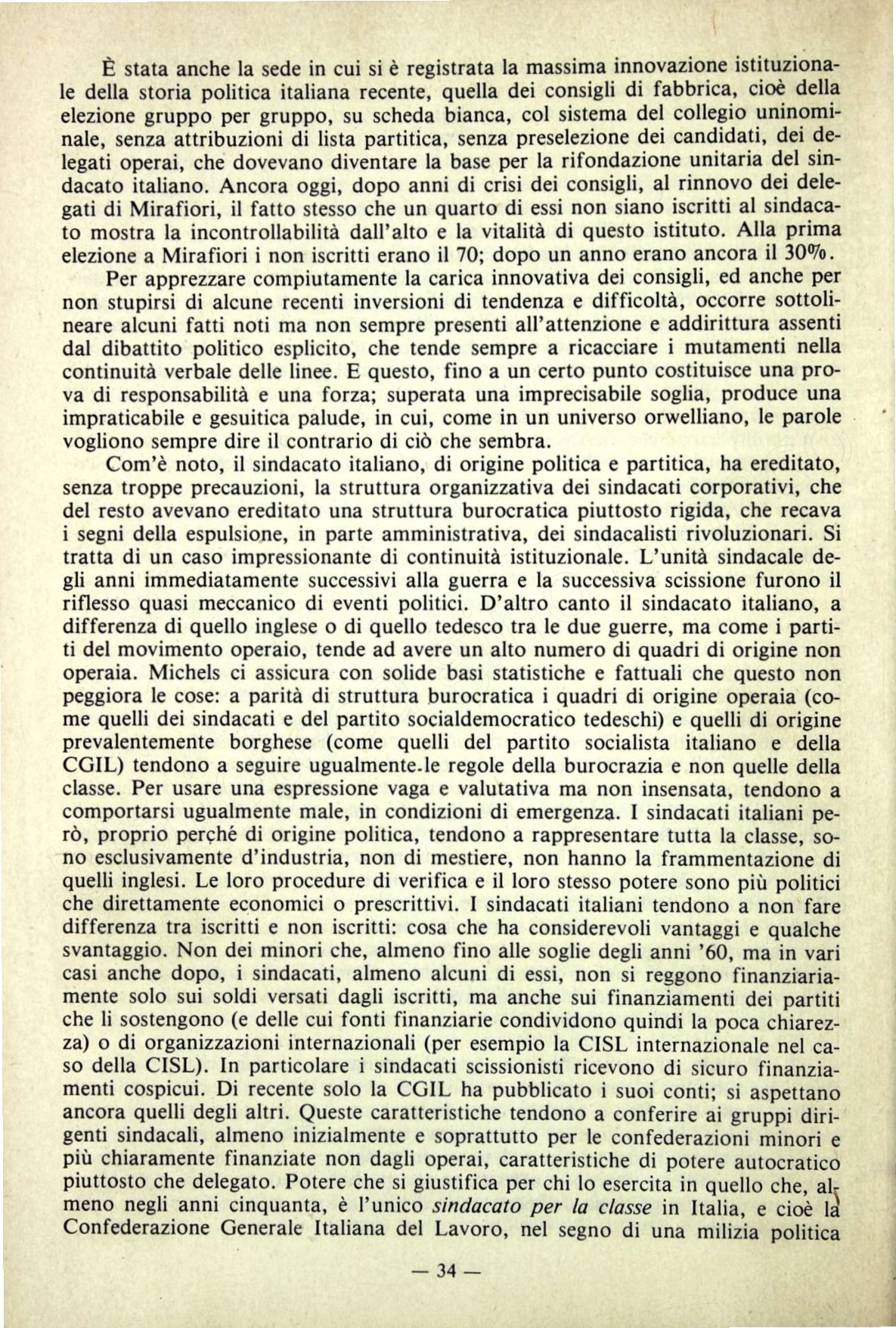
È stata anche la sede in cui si è registrata la massima innovazione istituziona-
le della storia politica italiana recente, quella dei consigli di fabbrica, cioè della
elezione gruppo per gruppo, su scheda bianca, col sistema del collegio uninomi-
nale, senza attribuzioni di lista partitica, senza preselezione dei candidati, dei de-
legati operai, che dovevano diventare la base per la rifondazione unitaria del sin-
dacato italiano. Ancora oggi, dopo anni di crisi dei consigli, al rinnovo dei dele-
gati di Mirafiori, il fatto stesso che un quarto di essi non siano iscritti al sindaca-
to mostra la incontrollabilità dall'alto e la vitalità di questo istituto. Alla prima
elezione a Mirafiori i non iscritti erano il 70; dopo un anno erano ancora il 30%.
Per apprezzare compiutamente la carica innovativa dei consigli, ed anche per
non stupirsi di alcune recenti inversioni di tendenza e difficoltà, occorre sottoli-
neare alcuni fatti noti ma non sempre presenti all'attenzione e addirittura assenti
dal dibattito politico esplicito, che tende sempre a ricacciare i mutamenti nella
continuità verbale delle linee. E questo, fino a un certo punto costituisce una pro-
va di responsabilità e una forza; superata una imprecisabile soglia, produce una
impraticabile e gesuitica palude, in cui, come in un universo orwelliano, le parole
vogliono sempre dire il contrario di ciò che sembra.
Com'è noto, il sindacato italiano, di origine politica e partitica, ha ereditato,
senza troppe precauzioni, la struttura organizzativa dei sindacati corporativi, che
del resto avevano ereditato una struttura burocratica piuttosto rigida, che recava
i segni della espulsione, in parte amministrativa, dei sindacalisti rivoluzionari. Si
tratta di un caso impressionante di continuità istituzionale. L'unità sindacale de-
gli anni immediatamente successivi alla guerra e la successivascissione furono il
riflesso quasi meccanico di eventi politici. D'altro canto il sindacato italiano, a
differenza di quello inglese o di quello tedesco tra le due guerre, ma come i parti-
ti del movimento operaio, tende ad avere un alto numero di quadri di origine non
operaia. Michels ci assicura con solide basi statistiche e fattuali che questo non
peggiora le cose: a parità di struttura burocratica i quadri di origine operaia (co-
mequelli dei sindacati e del partito socialdemocratico tedeschi) e quelli di origine
prevalentemente borghese (come quelli del partito socialista italiano e della
CGIL) tendono a seguire ugualmente-le regole della burocrazia e non quelle della
classe. Per usare una espressione vaga e valutativa ma non insensata, tendono a
comportarsi ugualmente male, in condizioni di emergenza. I sindacati italiani pe-
rò, proprio perché di origine politica, tendono a rappresentare tutta la classe, so-
noesclusivamente d'industria, non di mestiere, non hanno la frammentazione di
quelli inglesi. Le loro procedure di verifica e il loro stessopotere sono più politici
chedirettamente economici o prescrittivi. I sindacati italiani tendono a non fare
differenza tra iscritti e non iscritti: cosa che ha considerevoli vantaggi e qualche
svantaggio. Non dei minori che, almeno fino alle soglie degli anni '60, ma in vari
casi anche dopo, i sindacati, almeno alcuni di essi, non si reggono finanziaria-
mente solo sui soldi versati dagli iscritti, ma anche sui finanziamenti dei partiti
che li sostengono (e delle cui fonti finanziarie condividono quindi la poca chiarez-
za) o di organizzazioni internazionali (per esempio la CISL internazionale nel ca-
sodella CISL). In particolare i sindacati scissionisti ricevono di sicuro finanzia-
menti cospicui. Di recente solo la CGIL ha pubblicato i suoi conti; si aspettano
ancora quelli degli altri. Queste caratteristiche tendono a conferire ai gruppi diri-
genti sindacali, almeno inizialmente e soprattutto per le confederazioni minori e
più chiaramente finanziate non dagli operai, caratteristiche di potere autocratico
piuttosto che delegato. Potere che si giustifica per chi lo esercita in quello che, aly
meno negli anni cinquanta, è l'unico
sindacato per la classe
in Italia, e cioè là
Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nel segno di una milizia politica
—34
















