
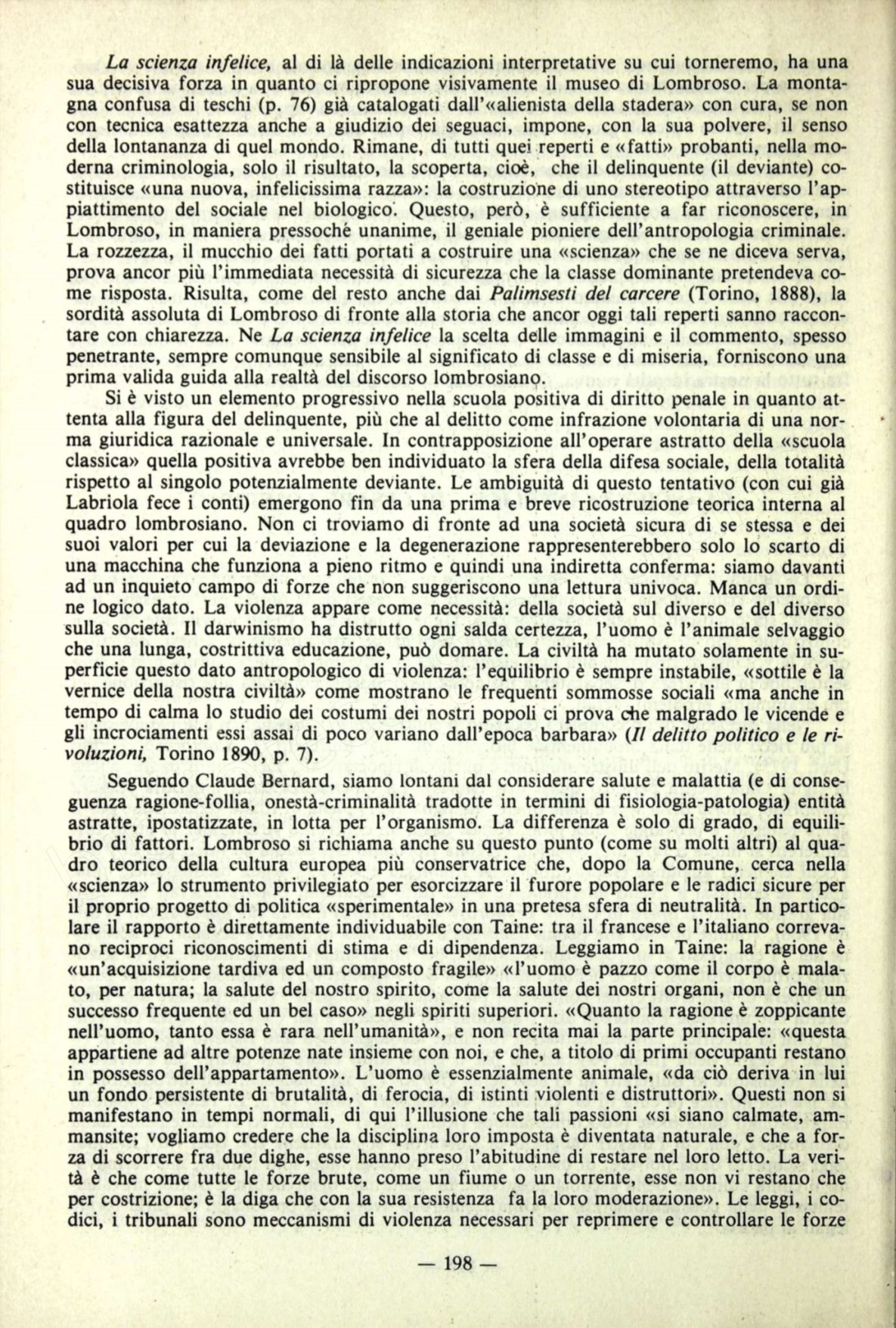
La scienza infelice,
al di là delle indicazioni interpretative su cui torneremo, ha una
suadecisiva forza in quanto ci ripropone visivamente il museo di Lombroso. La monta-
gna confusa di teschi (p. 76) già catalogati dall'«alienista della stadera» con cura, se non
con tecnica esattezza anche a giudizio dei seguaci, impone, con la sua polvere, i l senso
della lontananza di quel mondo. Rimane, di tutti quei reperti e «fatti» probanti, nella mo-
derna criminologia, solo il risultato, la scoperta, cioè, che il delinquente (il deviante) co-
stituisce «una nuova, infelicissima razza»: la costruzione di uno stereotipo attraverso l'ap-
piattimento del sociale nel biologico'. Questo, però, è sufficiente a far riconoscere, in
Lombroso, in maniera pressoché unanime, il geniale pioniere dell'antropologia criminale.
La rozzezza, il mucchio dei fatti portati a costruire una «scienza» che se ne diceva serva,
prova ancor più l'immediata necessità di sicurezza che la classe dominante pretendeva co-
me risposta. Risulta, come del resto anche dai
Palimsesti del carcere
(Torino, 1888), la
sordità assoluta di Lombroso di fronte alla storia che ancor oggi tali reperti sanno raccon-
tare con chiarezza. Ne
La scienza infelice
la scelta delle immagini e il commento, spesso
penetrante, sempre comunque sensibile al significato di classe e di miseria, forniscono una
prima valida guida alla realtà del discorso lombrosiano.
Si è visto un elemento progressivo nella scuola positiva di diritto penale in quanto at-
tenta alla figura del delinquente, più che al delitto come infrazione volontaria di una nor-
ma giuridica razionale e universale. In contrapposizione all'operare astratto della «scuola
classica» quella positiva avrebbe ben individuato la sfera della difesa sociale, della totalità
rispetto al singolo potenzialmente deviante. Le ambiguità di questo tentativo (con cui già
Labriola fece i conti) emergono fin da una prima e breve ricostruzione teorica interna al
quadro lombrosiano. Non ci troviamo di fronte ad una società sicura di se stessa e dei
suoi valori per cui la deviazione e la degenerazione rappresenterebbero solo lo scarto di
unamacchina che funziona a pieno ritmo e quindi una indiretta conferma: siamo davanti
ad un inquieto campo di forze che non suggeriscono una lettura univoca. Manca un ordi-
ne logico dato. La violenza appare come necessità: della società sul diverso e del diverso
sulla società. I l darwinismo ha distrutto ogni salda certezza, l'uomo è l'animale selvaggio
cheuna lunga, costrittiva educazione, può domare. La civiltà ha mutato solamente in su-
perficie questo dato antropologico di violenza: l'equilibrio è sempre instabile, «sottile è la
vernice della nostra civiltà» come mostrano le frequenti sommosse sociali «ma anche in
tempo di calma lo studio dei costumi dei nostri popoli ci prova die malgrado le vicende e
gli incrociamenti essi assai di poco variano dall'epoca barbara»
( I I delitto politico
e
le ri-
voluzioni,
Torino 1890, P. 7).
SeguendoClaude Bernard, siamo lontani dal considerare salute e malattia (e di conse-
guenza ragione-follia, onestà-criminalità tradotte in termini di fisiologia-patologia) entità
astratte, ipostatizzate, in lotta per l'organismo. La differenza è solo di grado, di equili-
brio di fattori. Lombroso si richiama anche su questo punto (come su molti altri) al qua-
dro teorico della cultura europea più conservatrice che, dopo la Comune, cerca nella
«scienza» lo strumento privilegiato per esorcizzare il furore popolare e le radici sicure per
il proprio progetto di politica «sperimentale» in una pretesa sfera di neutralità. In partico-
lare il rapporto è direttamente individuabile con Taine: tra il francese e l'italiano correva-
no reciproci riconoscimenti di stima e di dipendenza. Leggiamo in Taine: la ragione è
«un'acquisizione tardiva ed un composto fragile» «l'uomo è pazzo come il corpo è mala-
to, per natura; la salute del nostro spirito, come la salute dei nostri organi, non è che un
successofrequente ed un bel caso» negli spiriti superiori. «Quanto la ragione è zoppicante
nell'uomo, tanto essa è rara nell'umanità», e non recita mai la parte principale: «questa
appartiene ad altre potenze nate insieme con noi, e che, a titolo di primi occupanti restano
inpossesso dell'appartamento». L'uomo è essenzialmente animale, «da ciò deriva in lui
un fondo persistente di brutalità, di ferocia, di istinti violenti e distruttori». Questi non si
manifestano in tempi normali, di qui l'illusione che tali passioni «si siano calmate, am-
mansite; vogliamo credere che la disciplina loro imposta è diventata naturale, e che a for-
za di scorrere fra due dighe, essehanno preso l'abitudine di restare nel loro letto. La veri-
tà è che come tutte le forze brute, come un fiume o un torrente, esse non vi restano che
per costrizione; è la diga che con la sua resistenza f a la loro moderazione». Le leggi, i co-
dici, i tribunali sonomeccanismi di violenza necessari per reprimere e controllare le forze
198—
















