
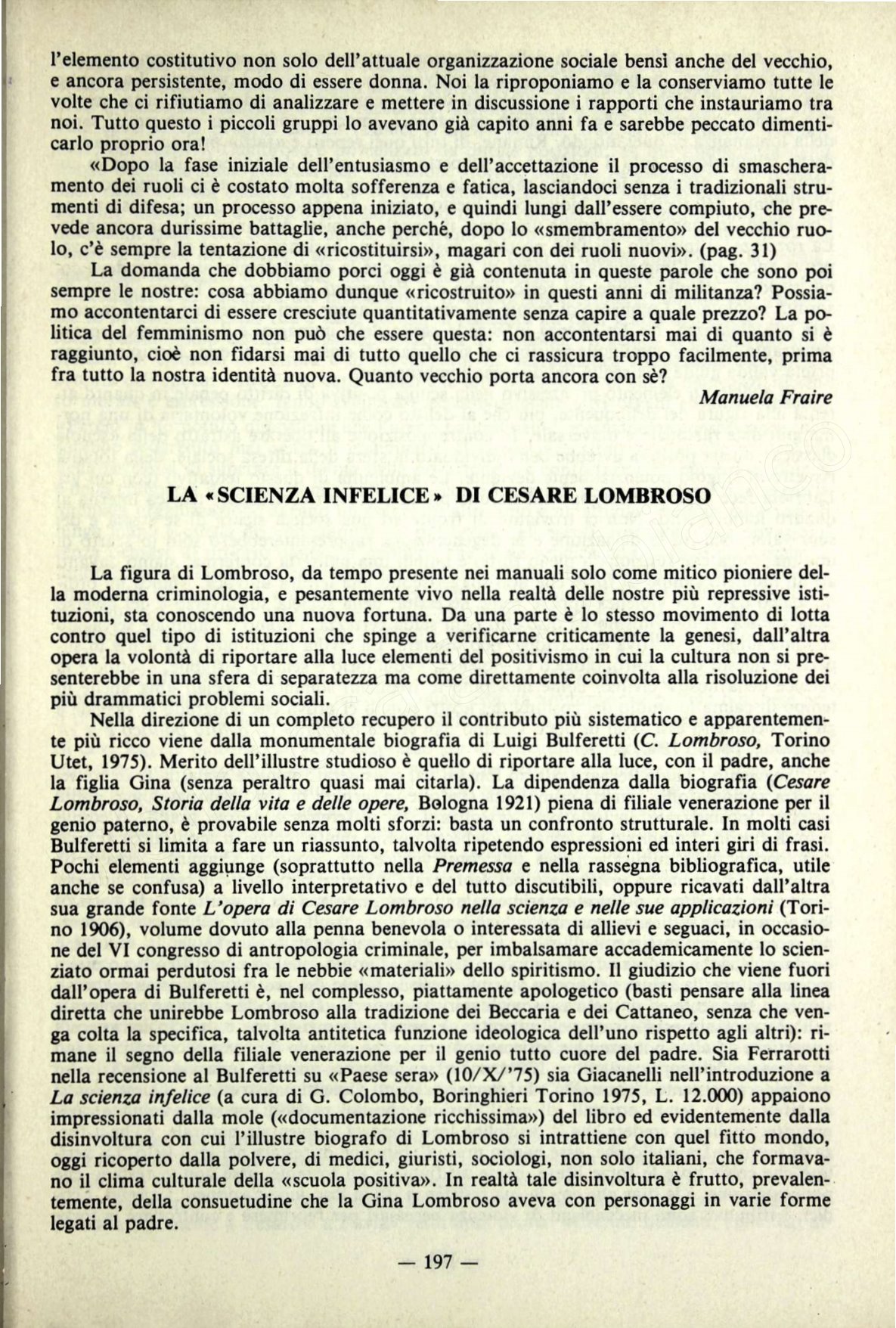
l'elemento costitutivo non solo dell'attuale organizzazione socialebensì anche del vecchio,
eancorapersistente, modo di esseredonna. Noi la riproponiamo e la conserviamo tutte le
volteche ci rifiutiamo di analizzare e mettere in discussione i rapporti che instauriamo tra
noi. Tutto questo i piccoli gruppi lo avevano già capito anni fa e sarebbepeccato dimenti-
carlo proprio ora!
«Dopo la fase iniziale dell'entusiasmo e dell'accettazione il processo di smaschera-
mentodei ruoli ci è costatomolta sofferenza e fatica, lasciandoci senza i tradizionali stru-
menti di difesa; un processoappena iniziato, e quindi lungi dall'essere compiuto, che pre-
vedeancoradurissime battaglie, ancheperché, dopo lo «smembramento» del vecchio ruo-
lo, c'è sempre la tentazione di «ricostituirsi», magari con dei ruoli nuovi». (pag. 31)
La domanda che dobbiamo porci oggi è già contenuta in queste parole che sono poi
sempre le nostre: cosa abbiamo dunque «ricostruito» in questi anni di militanza? Possia-
moaccontentarci di esserecresciutequantitativamentesenzacapire a qualeprezzo? La po-
litica del femminismo non può che esserequesta: non accontentarsi mai di quanto si è
raggiunto, cioè non fidarsi mai di tutto quello che ci rassicura troppo facilmente, prima
fra tutto la nostra identità nuova. Quanto vecchio porta ancora consè?
M a
n
u
e
l
a
Fraire
F.
•1
LA « SCIENZA INFELICE » D I CESARE LOMBROSO
La figura di Lombroso, da tempopresentenei manuali solocomemitico pioniere del-
lamoderna criminologia, e pesantemente vivo nella realtà delle nostre più repressive isti-
tuzioni, sta conoscendo una nuova fortuna. Da una parte è lo stessomovimento di lotta
contro quel tipo di istituzioni che spinge a verificarne criticamente la genesi, dall'altra
opera la volontà di riportare alla luce elementi del positivismo in cui la cultura non si pre-
senterebbe in una sfera di separatezzama comedirettamente coinvolta alla risoluzione dei
piùdrammatici problemi sociali.
Nella direzione di un completo recupero il contributo più sistematico e apparentemen-
te più ricco viene dalla monumentale biografia di Luigi Bulferetti
(C. Lombroso,
Torino
Utet, 1975). Merito dell'illustre studiosoè quello di riportare alla luce, con il padre, anche
la figlia Gina (senza peraltro quasi mai citarla). La dipendenza dalla biografia
(Cesare
Lombroso, Storia della vita
e
delle opere,
Bologna 1921) piena di filiale venerazione per il
geniopaterno, è provabile senzamolti sforzi: basta un confronto strutturale. In molti casi
Bulferetti si limita a fare un riassunto, talvolta ripetendoespressioni ed interi giri di frasi.
Pochi elementi aggiunge (soprattutto nella
Premessa
e nella rassegna bibliografica, utile
anchese confusa) a livello interpretativo e del tutto discutibili, oppure ricavati dall'altra
suagrande fonte L'opera di CesareLombroso nella scienza e nelle sueapplicazioni (Tori-
no1906), volume dovuto alla pennabenevola o interessata di allievi e seguaci, in occasio-
nedel VI congresso di antropologia criminale, per imbalsamareaccademicamente lo scien-
ziato ormai perdutosi fra le nebbie «materiali» dello spiritismo. Il giudizio cheviene fuori
dall'opera di Bulferetti è, nel complesso, piattamente apologetico (basti pensare alla linea
diretta che unirebbe Lombroso alla tradizione dei Beccaria e dei Cattaneo, senzache ven-
gacolta la specifica, talvolta antitetica funzione ideologica dell'uno rispetto agli altri): ri-
mane il segno della filiale venerazione per il genio tutto cuore del padre. Sia Ferrarotti
nellarecensione al Bulferetti su«Paesesera» (10/XP75) sia Giacanelli nell'introduzione a
La scienza infelice
(a cura di G. Colombo, Boringhieri Torino 1975, L. 12.000) appaiono
impressionati dalla mole («documentazione ricchissima») del libro edevidentemente dalla
disinvoltura con cui l'illustre biografo di Lombroso si intrattiene con quel fitto mondo,
oggi ricoperto dalla polvere, di medici, giuristi, sociologi, non solo italiani, che formava-
no il clima culturale della «scuola positiva». In realtà tale disinvoltura è frutto, prevalen-
temente, della consuetudine che la Gina Lombroso aveva con personaggi in varie forme
legati al padre.
—197
















