
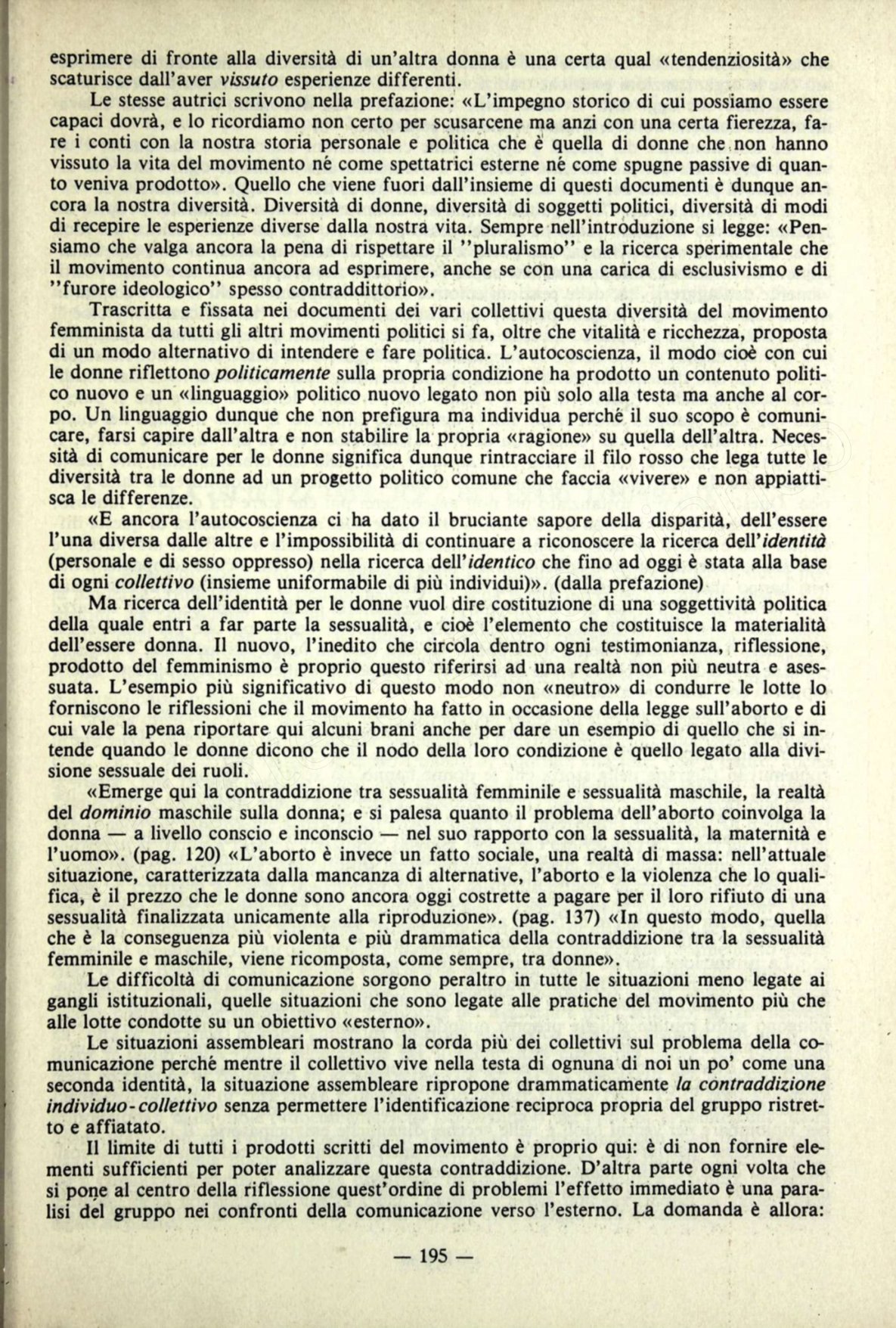
esprimere di fronte alla diversità di un'altra donna è una certa qual «tendenziosità» che
scaturiscedall'aver
vissuto
esperienze differenti.
Lestesseautrici scrivono nella prefazione: «L'impegno storico di cui possiamoessere
capaci dovrà, e lo ricordiamo non certo per scusarcenema anzi con una certa fierezza, fa-
re i conti con la nostra storia personale e politica che é quella di donne che non hanno
vissuto la vita del movimento né comespettatrici esternenécomespugnepassive di quan-
toveniva prodotto». Quello cheviene fuori dall'insieme di questi documenti è dunque an-
cora la nostra diversità. Diversità di donne, diversità di soggetti politici, diversità di modi
di recepire le esperienzediverse dalla nostra vita. Sempre nell'introduzione si legge: «Pen-
siamoche valga ancora la pena di rispettare il "pluralismo" e la ricerca sperimentale che
il movimento continua ancora ad esprimere, anchese con una carica di esclusivismo e di
"furore ideologico"spessocontraddittorio».
Trascritta e fissata nei documenti dei vari collettivi questa diversità del movimento
femminista da tutti gli altri movimenti politici si fa, oltre che vitalità e ricchezza, proposta
di unmodo alternativo di intendere e fare politica. L'autocoscienza, il modo cioè con cui
ledonne riflettono
politicamente
sulla propria condizione ha prodotto un contenuto politi-
conuovo e un «linguaggio» politico nuovo legatonon più solo alla testama anche al cor-
po. Un linguaggiodunque che non prefigura ma individua perché il suoscopo è comuni-
care, farsi capire dall'altra e non stabilire la propria «ragione» su quella dell'altra. Neces-
sità di comunicare per le donne significadunque rintracciare il filo rossoche lega tutte le
diversità tra le donne ad un progetto politico comuneche faccia «vivere» e non appiatti-
scale differenze.
«E ancora l'autocoscienza ci ha dato il bruciante sapore della disparità, dell'essere
l'una diversa dalle altre e l'impossibilità di continuare a riconoscere la ricerca
dell'identità
(personale e di sessooppresso) nella ricerca
dell'identico
che fino ad oggi è stata alla base
di ogni
collettivo
(insieme uniformabile di più individui)». (dalla prefazione)
Ma ricerca dell'identità per le donne vuol dire costituzione di una soggettività politica
della quale entri a far parte la sessualità, e cioè l'elemento che costituisce la materialità
dell'essere donna. I l nuovo, l'inedito che circola dentro ogni testimonianza, riflessione,
prodotto del femminismo è proprio questo riferirsi ad una realtà non più neutra e ases-
suata. L'esempio più significativo di questomodo non «neutro» di condurre le lotte lo
forniscono le riflessioni che il movimento ha fatto in occasionedella legge sull'aborto e di
cui vale la pena riportare qui alcuni brani anche per dare un esempio di quello che si in-
tendequando le donne dicono che il nodo della loro condizione è quello legato alla divi-
sionesessualedei ruoli.
«Emerge qui la contraddizione tra sessualità femminile e sessualitàmaschile, la realtà
del
dominio
maschile sulla donna; e si palesa quanto il problema dell'aborto coinvolga la
donna— a livello conscio e inconscio— nel suo rapporto con la sessualità, la maternità e
l'uomo». (pag. 120) «L'aborto è invece un fatto sociale, una realtà di massa: nell'attuale
situazione, caratterizzata dallamancanza di alternative, l'aborto e la violenzache lo quali-
fica, è il prezzo che le donnesonoancora oggi costrette a pagare per il loro rifiuto di una
sessualità finalizzata unicamente alla riproduzione». (pag. 137) «In questomodo, quella
cheè la conseguenza più violenta e più drammatica della contraddizione tra la sessualità
femminile emaschile, viene ricomposta, comesempre, tra donne».
Le difficoltà di comunicazionesorgono peraltro in tutte le situazioni meno legate ai
gangli istituzionali, quelle situazioni che sono legate alle pratiche del movimento più che
alle lotte condottesuun obiettivo «esterno».
Lesituazioni assemblearimostrano la corda più dei collettivi sul problema della co-
municazioneperchémentre il collettivo vive nella testa di ognuna di noi un po' come una
seconda identità, la situazioneassembleare ripropone drammaticamente
la contraddizione
individuo-collettivo
senzapermettere l'identificazione reciproca propria del gruppo ristret-
to e affiatato.
Il limite di tutti i prodotti scritti del movimento è proprio qui: è di non fornire ele-
menti sufficienti per poter analizzare questa contraddizione. D'altra parte ogni volta che
sipone al centro della riflessionequest'ordine di problemi l'effetto immediato è una para-
lisi del gruppo nei confronti della comunicazione verso l'esterno. La domanda è allora:
195
















