
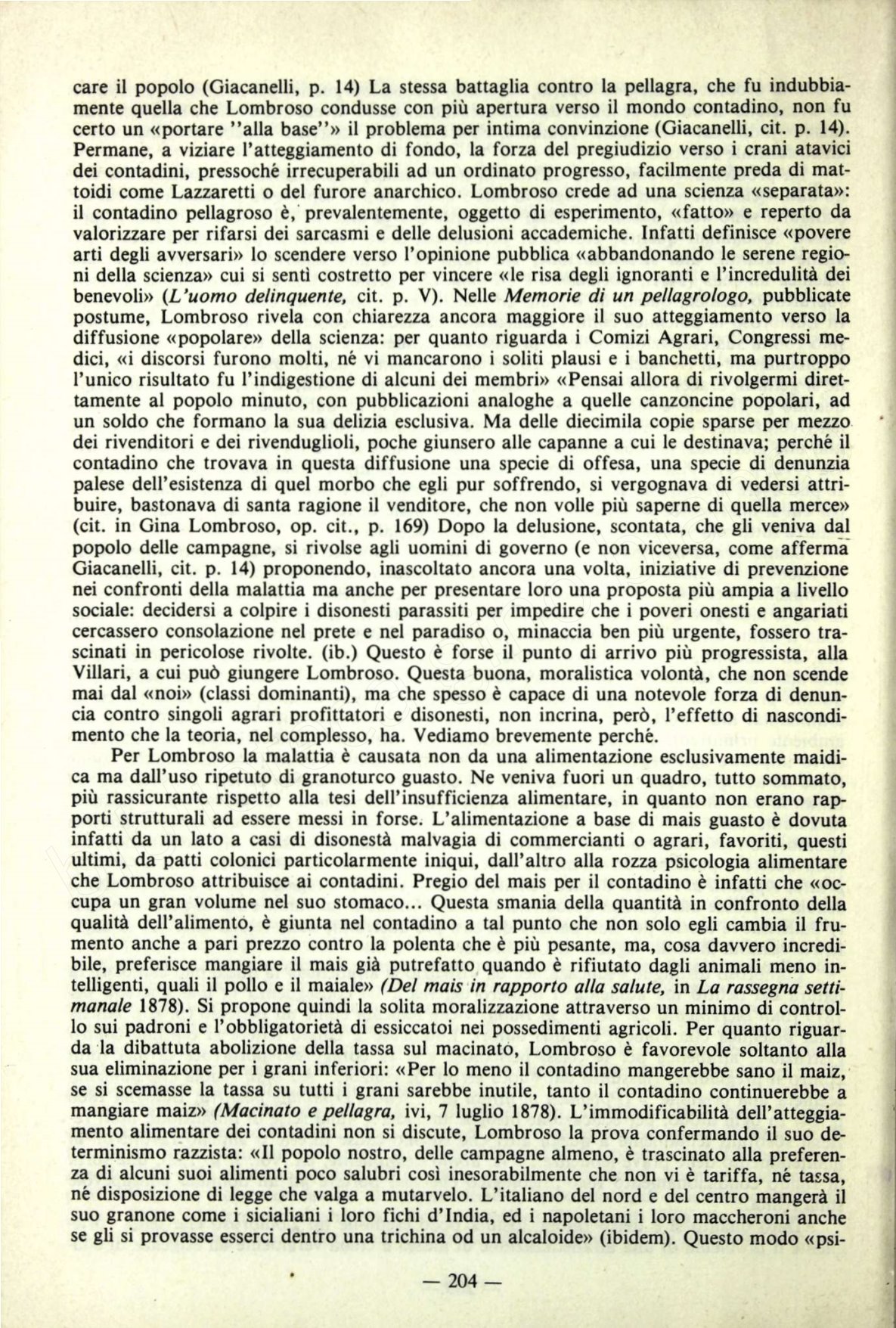
care il popolo (Giacanelli, p. 14) La stessa battaglia contro la pellagra, che fu indubbia-
mente quella che Lombroso condusse con più apertura verso il mondo contadino, non fu
certo un «portare "alla base"» il problema per intima convinzione (Giacanelli, cit. p. 14).
Permane, a viziare l'atteggiamento di fondo, la forza del pregiudizio verso i crani atavici
dei contadini, pressoché irrecuperabili ad un ordinato progresso, facilmente preda di mat-
toidi come Lazzaretti o del furore anarchico. Lombroso crede ad una scienza «separata»:
il contadino pellagroso è, prevalentemente, oggetto di esperimento, «fatto» e reperto da
valorizzare per rifarsi dei sarcasmi e delle delusioni accademiche. Infatti definisce «povere
arti degli avversari» lo scendere verso l'opinione pubblica «abbandonando le serene regio-
ni della scienza» cui si sentì costretto per vincere «le risa degli ignoranti e l'incredulità dei
benevoli» (L'uomo delinquente, cit. p. V). Nelle Memorie di un pellagrologo, pubblicate
postume, Lombroso rivela con chiarezza ancora maggiore il suo atteggiamento verso la
diffusione «popolare» della scienza: per quanto riguarda i Comizi Agrari, Congressi me-
dici, «i discorsi furono molti, né vi mancarono i soliti plausi e i banchetti, ma purtroppo
l'unico risultato fu l'indigestione di alcuni dei membri» «Pensai allora di rivolgermi diret-
tamente al popolo minuto, con pubblicazioni analoghe a quelle canzoncine popolari, ad
unsoldo che formano la sua delizia esclusiva. Ma delle diecimila copie sparse per mezzo
dei rivenditori e dei rivenduglioli, poche giunsero alle capanne a cui le destinava; perché il
contadino che trovava in questa diffusione una specie di offesa, una specie di denunzia
palesedell'esistenza di quel morbo che egli pur soffrendo, si vergognava di vedersi attri-
buire, bastonava di santa ragione il venditore, che non volle più saperne di quella merce»
(cit. in Gina Lombroso, op. cit., p. 169) Dopo la delusione, scontata, che gli veniva dal
popolo delle campagne, si rivolse agli uomini di governo (e non viceversa, come affermi
Giacanelli, cit. p. 14) proponendo, inascoltato ancora una volta, iniziative di prevenzione
nei confronti della malattia ma anche per presentare loro una proposta più ampia a livello
sociale: decidersi a colpire i disonesti parassiti per impedire che i poveri onesti e angariati
cercasseroconsolazione nel prete e nel paradiso o, minaccia ben più urgente, fossero tra-
scinati in pericolose rivolte. (ib.) Questo è forse il punto di arrivo più progressista, alla
Villari, a cui può giungere Lombroso. Questa buona, moralistica volontà, che non scende
mai dal «noi» (classi dominanti), ma chespessoè capace di una notevole forza di denun-
cia contro singoli agrari profittatori e disonesti, non incrina, però, l'effetto di nascondi-
mentoche la teoria, nel complesso, ha. Vediamo brevemente perché.
Per Lombroso la malattia è causata non da una alimentazione esclusivamente maidi-
cama dall'uso ripetuto di granoturco guasto. Ne veniva fuori un quadro, tutto sommato,
più rassicurante rispetto alla tesi dell'insufficienza alimentare, in quanto non erano rap-
porti strutturali ad esseremessi in forse. L'alimentazione a base di mais guasto è dovuta
infatti da un lato a casi di disonestà malvagia di commercianti o agrari, favoriti, questi
ultimi, da patti colonici particolarmente iniqui, dall'altro alla rozza psicologia alimentare
cheLombroso attribuisce ai contadini. Pregio del mais per il contadino è infatti che «oc-
cupa un gran volume nel suo stomaco... Questa smania della quantità in confronto della
qualità dell'alimento, è giunta nel contadino a tal punto che non solo egli cambia il fru-
mento anche a pari prezzo contro la polenta che è più pesante, ma, cosa davvero incredi-
bile, preferisce mangiare il mais già putrefatto quando è rifiutato dagli animali meno in-
telligenti, quali il pollo e il maiale» (Del mais in rapporto alla salute, in La rassegna setti-
manale
1878). Si propone quindi la solita moralizzazione attraverso un minimo di control-
lo sui padroni e l'obbligatorietà di essiccatoi nei possedimenti agricoli. Per quanto riguar-
da la dibattuta abolizione della tassa sul macinato, Lombroso è favorevole soltanto alla
suaeliminazione per i grani inferiori: «Per lo meno il contadinomangerebbe sano il maiz,
sesi scemasse la tassa su tutti i grani sarebbe inutile, tanto il contadino continuerebbe a
mangiare maiz»
(Macinato
e
pellagra,
ivi, 7 luglio 1878). L'immodificabilità dell'atteggia-
mento alimentare dei contadini non si discute, Lombroso la prova confermando il suo de-
terminismo razzista: «Il popolo nostro, delle campagne almeno, è trascinato alla preferen-
za di alcuni suoi alimenti poco salubri così inesorabilmente che non vi è tariffa, né tassa,
nédisposizione di legge che valga a mutarvelo. L'italiano del nord e del centromangerà il
suogranone come i sicialiani i loro fichi d'India, ed i napoletani i loro maccheroni anche
segli si provasseesserci dentro una trichina od un alcaloide» (ibidem). Questo modo «psi-
- 204 —
















