
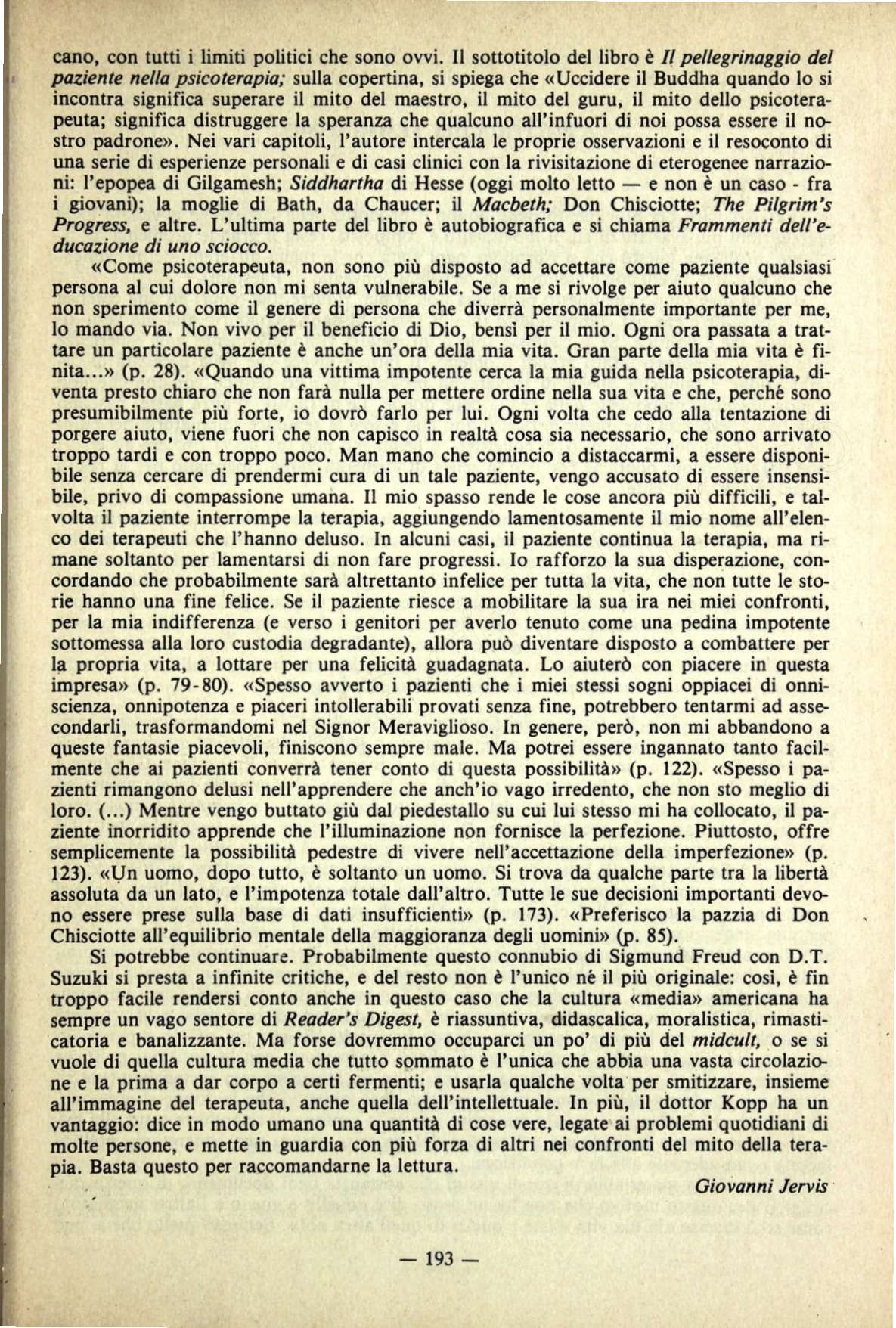
cano, con tutti i limiti politici che sono ovvi. I l sottotitolo del libro è I l
pellegrinaggio del
paziente nella psicoterapia;
sulla copertina, si spiega che «Uccidere il Buddha quando lo si
incontra significa superare i l mito del maestro, i l mito del guru, i l mito dello psicotera-
peuta; significa distruggere la speranza che qualcuno all'infuori di noi possa essere i l no-
stro padrone». Nei vari capitoli, l'autore intercala le proprie osservazioni e il resoconto di
una serie di esperienze personali e di casi clinici con la rivisitazione di eterogenee narrazio-
ni: l'epopea di Gilgamesh;
Siddhartha
di Hesse (oggi molto letto — e non è un caso - fra
i giovani); l a moglie di Bath, da Chaucer; i l
Macbeth;
Don Chisciotte;
The Pilgrim's
Progress,
e altre. L'ultima parte del libro è autobiografica e si chiama
Frammenti dell'e-
ducazione di uno sciocco.
«Come psicoterapeuta, non sono più disposto ad accettare come paziente qualsiasi
persona al cui dolore non mi senta vulnerabile. Se a me si rivolge per aiuto qualcuno che
non sperimento come i l genere di persona che diverrà personalmente importante per me,
lo mando via. Non vivo per i l beneficio di Dio, bensì per il mio. Ogni ora passata a trat-
tare un particolare paziente è anche un'ora della mia vita. Gran parte della mia vita è fi-
nita...» (p. 28). «Quando una vittima impotente cerca la mia guida nella psicoterapia, di-
venta presto chiaro che non farà nulla per mettere ordine nella sua vita e che, perché sono
presumibilmente più forte, io dovrò farlo per lui. Ogni volta che cedo alla tentazione di
porgere aiuto, viene fuori che non capisco in realtà cosa sia necessario, che sono arrivato
troppo tardi e con troppo poco. Man mano che comincio a distaccarmi, a essere disponi-
bile senza cercare di prendermi cura di un tale paziente, vengo accusato di essere insensi-
bile, privo di compassione umana. I l mio spasso rende le cose ancora più difficili, e tal-
volta il paziente interrompe la terapia, aggiungendo lamentosamente il mio nome all'elen-
co dei terapeuti che l'hanno deluso. In alcuni casi, i l paziente continua la terapia, ma ri-
mane soltanto per lamentarsi di non fare progressi. Io rafforzo la sua disperazione, con-
cordando che probabilmente sarà altrettanto infelice per tutta la vita, che non tutte le sto-
rie hanno una fine felice. Se i l paziente riesce a mobilitare la sua ira nei miei confronti,
per la mia indifferenza (e verso i genitori per averlo tenuto come una pedina impotente
sottomessa alla loro custodia degradante), allora può diventare disposto a combattere per
la propria vita, a lottare per una felicità guadagnata. Lo aiuterò con piacere in questa
impresa» (p. 79-80). «Spesso avverto i pazienti che i miei stessi sogni oppiacei di onni-
scienza, onnipotenza e piaceri intollerabili provati senza fine, potrebbero tentarmi ad asse-
condarli, trasformandomi nel Signor Meraviglioso. In genere, però, non mi abbandono a
queste fantasie piacevoli, finiscono sempre male. Ma potrei essere ingannato tanto facil-
mente che ai pazienti converrà tener conto di questa possibilità» (p. 122). «Spesso i pa-
zienti rimangono delusi nell'apprendere che anch'io vago irredento, che non sto meglio di
loro. (...) Mentre vengo buttato giù dal piedestallo su cui lui stesso mi ha collocato, i l pa-
ziente inorridito apprende che l'illuminazione non fornisce la perfezione. Piuttosto, offre
semplicemente la possibilità pedestre di vivere nell'accettazione della imperfezione»
(p.
123). «Un uomo, dopo tutto, è soltanto un uomo. Si trova da qualche parte tra la libertà
assoluta da un lato, e l'impotenza totale dall'altro. Tutte le sue decisioni importanti devo-
no essere prese sulla base di dati insufficienti» (p. 173). «Preferisco la pazzia di Don
Chisciotte all'equilibrio mentale della maggioranza degli uomini» (p. 85).
Si potrebbe continuare. Probabilmente questo connubio di Sigmund Freud con D.T.
Suzuki si presta a infinite critiche, e del resto non è l'unico né il più originale: così, è fin
troppo facile rendersi conto anche in questo caso che la cultura «media» americana ha
sempre un vago sentore di
Reader's Digest,
è riassuntiva, didascalica, moralistica, rimasti-
catoria e banalizzante. Ma forse dovremmo occuparci un po' di più del
midcult,
o se si
vuole di quella cultura media che tutto sommato è l'unica che abbia una vasta circolazio-
ne e la prima a dar corpo a certi fermenti; e usarla qualche volta per smitizzare, insieme
all'immagine del terapeuta, anche quella dell'intellettuale. I n più, i l dottor Kopp ha un
vantaggio: dice in modo umano una quantità di cose vere, legate ai problemi quotidiani di
molte persone, e mette in guardia con più forza di altri nei confronti del mito della tera-
pia. Basta questo per raccomandarne la lettura.
Giovanni Jervis
193
















