
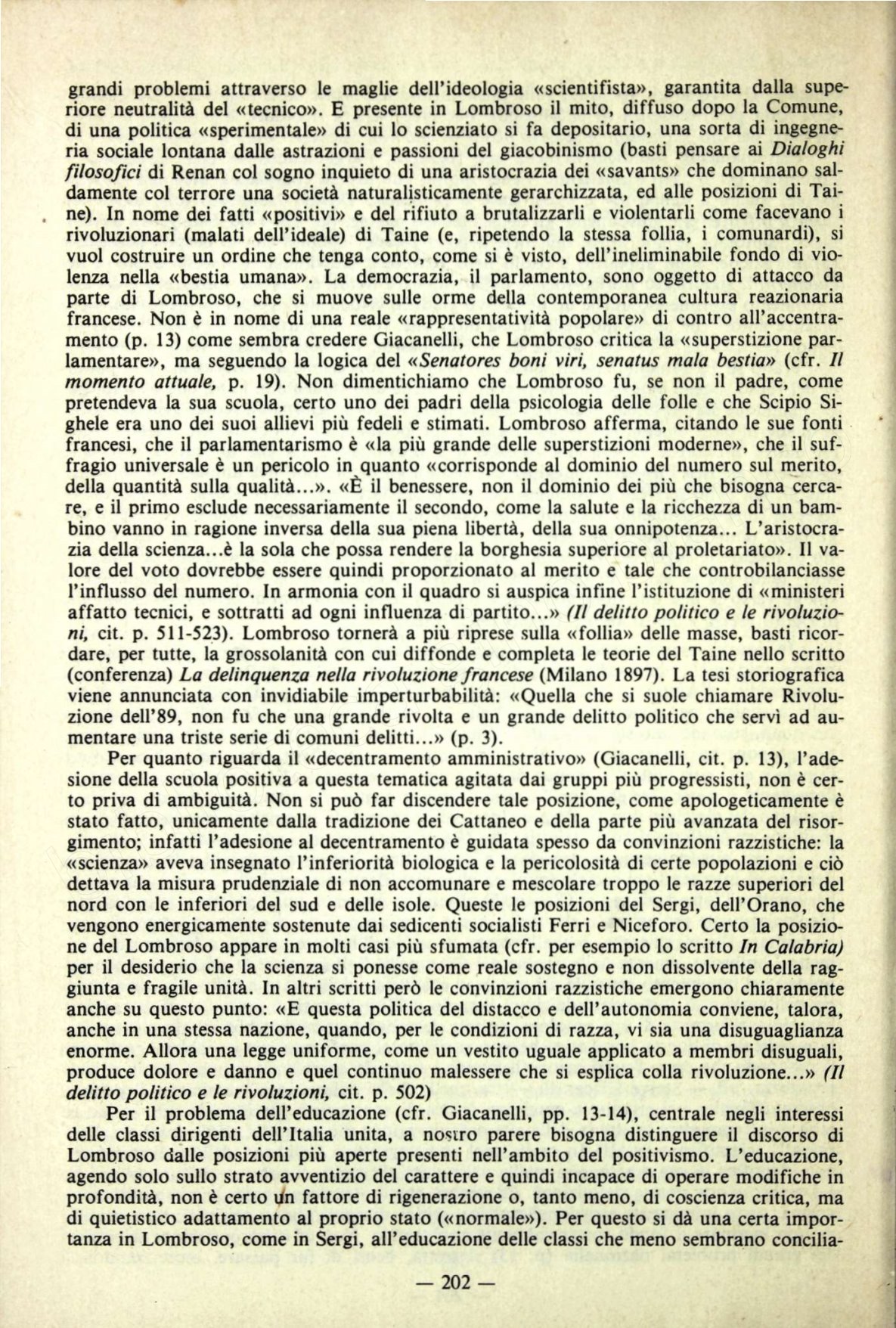
grandi problemi attraverso le maglie dell'ideologia «scientifista», garantita dalla supe-
riore neutralità del «tecnico». E presente in Lombroso il mito, diffuso dopo la Comune,
di una politica «sperimentale» di cui lo scienziato si fa depositario, una sorta di ingegne-
ria sociale lontana dalle astrazioni e passioni del giacobinismo (basti pensare ai
Dialoghi
filosofici
di Renan col sogno inquieto di una aristocrazia dei «savants» che dominano sal-
damente col terrore una società naturalisticamente gerarchizzata, ed alle posizioni di Tai-
ne). In nome dei fatti «positivi» e del rifiuto a brutalizzarli e violentarli come facevano i
rivoluzionari (malati dell'ideale) di Taine (e, ripetendo la stessa follia, i comunardi), si
vuol costruire un ordine che tenga conto, come si è visto, dell'ineliminabile fondo di vio-
lenza nella «bestia umana». La democrazia, i l parlamento, sono oggetto di attacco da
parte di Lombroso, che si muove sulle orme della contemporanea cultura reazionaria
francese. Non è in nome di una reale «rappresentatività popolare» di contro all'accentra-
mento (p. 13) come sembra credere Giacanelli, che Lombroso critica la «superstizione par-
lamentare», ma seguendo la logica del «Senatores boni viri, senatus mala bestia» (cfr. I l
momento attuale,
p. 19). Non dimentichiamo che Lombroso fu, se non il padre, come
pretendeva la sua scuola, certo uno dei padri della psicologia delle folle e che Scipio Si-
ghele era uno dei suoi allievi più fedeli e stimati. Lombroso afferma, citando le sue fonti
francesi, che il parlamentarismo è «la più grande delle superstizioni moderne», che il suf-
fragio universale è un pericolo in quanto «corrisponde al dominio del numero sul merito,
della quantità sulla qualità...». «È il benessere, non il dominio dei più che bisogna cerca-
re, e il primo escludenecessariamente il secondo, come la salute e la ricchezza di un bam-
bino vanno in ragione inversa della sua piena libertà, della sua onnipotenza... L'aristocra-
zia della scienza...è la sola chepossa rendere la borghesia superiore al proletariato». I l va-
lore del voto dovrebbe essere quindi proporzionato al merito e tale che controbilanciasse
l'influsso del numero. In armonia con il quadro si auspica infine l'istituzione di «ministeri
affatto tecnici, e sottratti ad ogni influenza di partito...»
(Il delitto politico
e
le rivoluzio-
ni,
cit. p. 511-523). Lombroso tornerà a più riprese sulla «follia» dellemasse, basti ricor-
dare, per tutte, la grossolanità con cui diffonde e completa le teorie del Taine nello scritto
(conferenza)
La delinquenza nella rivoluzione francese
(Milano 1897). La tesi storiografica
viene annunciata con invidiabile imperturbabilità: «Quella che si suole chiamare Rivolu-
zione dell'89, non fu che una grande rivolta e un grande delitto politico che servì ad au-
mentare una triste serie di comuni delitti...» (p. 3).
Per quanto riguarda il «decentramento amministrativo» (Giacanelli, cit. p. 13), l'ade-
sione della scuola positiva a questa tematica agitata dai gruppi più progressisti, non è cer-
to priva di ambiguità. Non si può far discendere tale posizione, come apologeticamente è
stato fatto, unicamente dalla tradizione dei Cattaneo e della parte più avanzata del risor-
gimento; infatti l'adesione al decentramento è guidata spesso da convinzioni razzistiche: la
«scienza» aveva insegnato l'inferiorità biologica e la pericolosità di certe popolazioni e ciò
dettava la misura prudenziale di non accomunare emescolare troppo le razze superiori del
nord con le inferiori del sud e delle isole. Queste le posizioni del Sergi, dell'Orano, che
vengonoenergicamente sostenute dai sedicenti socialisti Ferri e Niceforo. Certo la posizio-
nedel Lombroso appare in molti casi più sfumata (cfr. per esempio lo scritto
In Calabria)
per il desiderio che la scienza si ponesse come reale sostegno e non dissolvente della rag-
giunta e fragile unità. In altri scritti però le convinzioni razzistiche emergono chiaramente
anche su questo punto: «E questa politica del distacco e dell'autonomia conviene, talora,
anche in una stessa nazione, quando, per le condizioni di razza, vi sia una disuguaglianza
enorme. Allora una legge uniforme, come un vestito uguale applicato a membri disuguali,
produce dolore e danno e quel continuomalessere che si esplica colla rivoluzione...»
( I I
delitto politico e le rivoluzioni, cit. p. 502)
Per il problema dell'educazione (cfr. Giacanelli, pp. 13-14), centrale negli interessi
delle classi dirigenti dell'Italia unita, a nostro parere bisogna distinguere il discorso di
Lombroso dalle posizioni più aperte presenti nell'ambito del positivismo. L'educazione,
agendosolo sullo strato avventizio del carattere e quindi incapace di operare modifiche in
profondità, non è certo tin fattore di rigenerazione o, tanto meno, di coscienza critica, ma
di quietistico adattamento al proprio stato («normale»). Per questo si dà una certa impor-
tanza in Lombroso, come in Sergi, all'educazione delle classi chemeno sembrano concilia-
- 202 —
















