
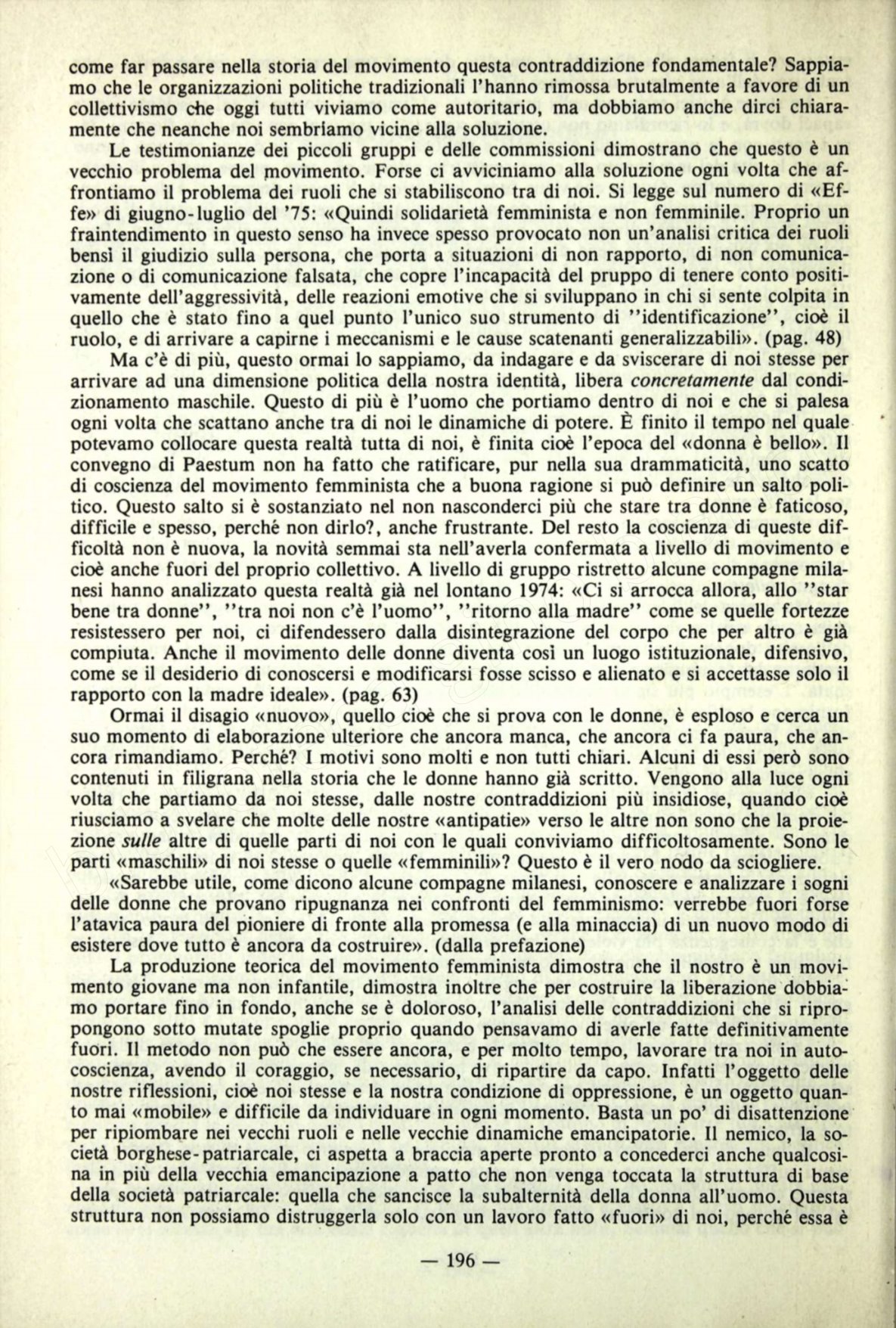
come far passare nella storia del movimento questa contraddizione fondamentale? Sappia-
moche le organizzazioni politiche tradizionali l'hanno rimossa brutalmente a favore di un
collettivismo che oggi tutti viviamo come autoritario, ma dobbiamo anche dirci chiara-
menteche neanche noi sembriamo vicine alla soluzione.
Le testimonianze dei piccoli gruppi e delle commissioni dimostrano che questo è un
vecchio problema del movimento. Forse ci avviciniamo alla soluzione ogni volta che af-
frontiamo il problema dei ruoli che si stabiliscono tra di noi. Si legge sul numero di «Ef-
fe» di giugno- luglio del '75: «Quindi solidarietà femminista e non femminile. Proprio un
fraintendimento in questosenso ha invecespessoprovocato non un'analisi critica dei ruoli
bensi il giudizio sulla persona, che porta a situazioni di non rapporto, di non comunica-
zione o di comunicazione falsata, che copre l'incapacità del pruppo di tenere conto positi-
vamente dell'aggressività, delle reazioni emotive che si sviluppano in chi si sente colpita in
quello che è stato fino a quel punto l'unico suo strumento di "identificazione", cioè il
ruolo, e di arrivare a capirne i meccanismi e le cause scatenanti generalizzabili». (pag. 48)
Ma c'è di più, questo ormai lo sappiamo, da indagare e da sviscerare di noi stesse per
arrivare ad una dimensione politica della nostra identità, libera
concretamente
dal condi-
zionamentomaschile. Questo di più è l'uomo che portiamo dentro di noi e che si palesa
ogni volta che scattano anche tra di noi le dinamiche di potere. E finito il tempo nel quale
potevamo collocare questa realtà tutta di noi, è finita cioè l'epoca del «donna è bello». I l
convegno di Paestum non ha fatto che ratificare, pur nella sua drammaticità, uno scatto
di coscienza del movimento femminista che a buona ragione si può definire un salto poli-
tico. Questo salto si è sostanziato nel non nasconderci più che stare tra donne è faticoso,
difficile e spesso, perché non dirlo?, anche frustrante. Del resto la coscienza di queste dif-
ficoltà non è nuova, la novità semmai sta nell'averla confermata a livello di movimento e
cioèanche fuori del proprio collettivo. A livello di gruppo ristretto alcune compagne mila-
nesi hanno analizzato questa realtà già nel lontano 1974: «Ci si arrocca allora, allo "star
bene tra donne", "tra noi non c'è l'uomo", "ritorno alla madre" come se quelle fortezze
resistessero per noi, ci difendessero dalla disintegrazione del corpo che per altro è già
compiuta. Anche il movimento delle donne diventa così un luogo istituzionale, difensivo,
comese il desiderio di conoscersi e modificarsi fossescisso e alienato e si accettasse solo il
rapporto con la madre ideale». (pag. 63)
Ormai il disagio «nuovo», quello cioè che si prova con le donne, è esploso e cerca un
suomomento di elaborazione ulteriore che ancora manca, che ancora ci fa paura, che an-
cora rimandiamo. Perché? I motivi sono molti e non tutti chiari. Alcuni di essi però sono
contenuti in filigrana nella storia che le donne hanno già scritto. Vengono alla luce ogni
volta che partiamo da noi stesse, dalle nostre contraddizioni più insidiose, quando cioè
riusciamo a svelare che molte delle nostre «antipatie» verso le altre non sono che la proie-
zione
sulle
altre di quelle parti di noi con le quali conviviamo difficoltosamente. Sono le
parti «maschili» di noi stesse o quelle «femminili»? Questo è il vero nodo da sciogliere.
«Sarebbe utile, come dicono alcune compagnemilanesi, conoscere e analizzare i sogni
delle donne che provano ripugnanza nei confronti del femminismo: verrebbe fuori forse
l'atavica paura del pioniere di fronte alla promessa (e alla minaccia) di un nuovo modo di
esisteredove tutto è ancora da costruire». (dalla prefazione)
La produzione teorica del movimento femminista dimostra che il nostro è un movi-
mento giovane ma non infantile, dimostra inoltre che per costruire la liberazione dobbia-
mo portare fino in fondo, anche se è doloroso, l'analisi delle contraddizioni che si ripro-
pongono sotto mutate spoglie proprio quando pensavamo di averle fatte definitivamente
fuori. I l metodo non può che essere ancora, e per molto tempo, lavorare tra noi in auto-
coscienza, avendo il coraggio, se necessario, di ripartire da capo. Infatti l'oggetto delle
nostre riflessioni, cioè noi stesse e la nostra condizione di oppressione, è un oggetto quan-
to mai «mobile» e difficile da individuare in ogni momento. Basta un po' di disattenzione
per ripiombare nei vecchi ruoli e nelle vecchie dinamiche emancipatorie. I l nemico, la so-
cietàborghese- patriarcale, ci aspetta a braccia aperte pronto a concederci anche qualcosi-
na in più della vecchia emancipazione a patto che non venga toccata la struttura di base
della società patriarcale: quella che sancisce la subalternità della donna all'uomo. Questa
struttura non possiamo distruggerla solo con un lavoro fatto «fuori» di noi, perché essa è
196
















