
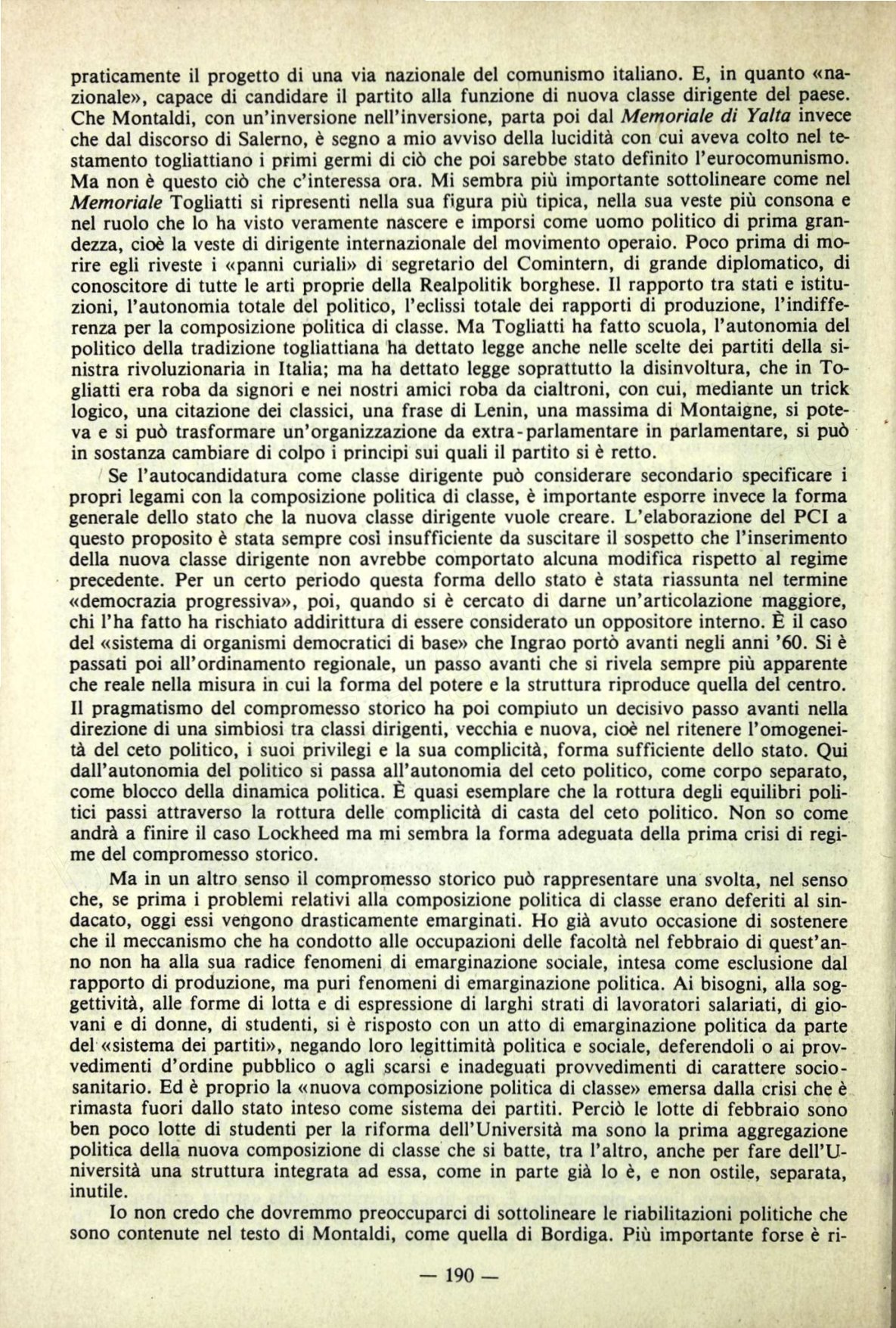
praticamente il progetto di una via nazionale del comunismo italiano. E, in quanto «na-
zionale», capace di candidare il partito alla funzione di nuova classe dirigente del paese.
Che Montaldi, con un'inversione nell'inversione, parta poi dal
Memoriale di Yalta
invece
che dal discorso di Salerno, è segno a mio avviso della lucidità con cui aveva colto nel te-
stamento togliattiano i primi germi di ciò che poi sarebbe stato definito l'eurocomunismo.
Ma non è questo ciò che c'interessa ora. Mi sembra più importante sottolineare come nel
Memoriale
Togliatti si ripresenti nella sua figura più tipica, nella sua veste più consona e
nel ruolo che lo ha visto veramente nascere e imporsi come uomo politico di prima gran-
dezza, cioè la veste di dirigente internazionale del movimento operaio. Poco prima di mo-
rire egli riveste i «panni curiali» di segretario del Comintern, di grande diplomatico, di
conoscitore di tutte le arti proprie della Realpolitik borghese. I l rapporto tra stati e istitu-
zioni, l'autonomia totale del politico, l'eclissi totale dei rapporti di produzione, l'indiffe-
renza per la composizione politica di classe. Ma Togliatti ha fatto scuola, l'autonomia del
politico della tradizione togliattiana ha dettato legge anche nelle scelte dei partiti della si-
nistra rivoluzionaria in Italia; ma ha dettato legge soprattutto la disinvoltura, che in To-
gliatti era roba da signori e nei nostri amici roba da cialtroni, con cui, mediante un trick
logico, una citazione dei classici, una frase di Lenin, una massima di Montaigne, si pote-
va e si può trasformare un'organizzazione da extra- parlamentare in parlamentare, si può
in sostanza cambiare di colpo i principi sui quali il partito si è retto.
Sel'autocandidatura come classe dirigente può considerare secondario specificare i
propri legami con la composizione politica di classe, è importante esporre invece la forma
generale dello stato che la nuova classe dirigente vuole creare. L'elaborazione del PCI a
questoproposito è stata sempre così insufficiente da suscitare il sospetto che l'inserimento
della nuova classe dirigente non avrebbe comportato alcuna modifica rispetto al regime
precedente. Per un certo periodo questa forma dello stato è stata riassunta nel termine
«democrazia progressiva», poi, quando si è cercato di darne un'articolazione maggiore,
chi l'ha fatto ha rischiato addirittura di essereconsiderato un oppositore interno. E il caso
del «sistema di organismi democratici di base» che Ingrao portò avanti negli anni '60. Si è
passati poi all'ordinamento regionale, un passo avanti che si rivela sempre più apparente
che reale nella misura in cui la forma del potere e la struttura riproduce quella del centro.
Il pragmatismo del compromesso storico ha poi compiuto un decisivo passo avanti nella
direzione di una simbiosi tra classi dirigenti, vecchia e nuova, cioè nel ritenere l'omogenei-
tà del ceto politico, i suoi privilegi e la sua complicità, forma sufficiente dello stato. Qui
dall'autonomia del politico si passa all'autonomia del ceto politico, come corpo separato,
comeblocco della dinamica politica. E quasi esemplare che la rottura degli equilibri poli-
tici passi attraverso la rottura delle complicità di casta del ceto politico. Non so come
andrà a finire il caso Lockheed ma mi sembra la forma adeguata della prima crisi di regi-
medel compromesso storico.
Ma in un altro senso il compromesso storico può rappresentare una svolta, nel senso
che, se prima i problemi relativi alla composizione politica di classe erano deferiti al sin-
dacato, oggi essi vengono drasticamente emarginati. Ho già avuto occasione di sostenere
che il meccanismo che ha condotto alle occupazioni delle facoltà nel febbraio di quest'an-
no non ha alla sua radice fenomeni di emarginazione sociale, intesa come esclusione dal
rapporto di produzione, ma puri fenomeni di emarginazione politica. Ai bisogni, alla sog-
gettività, alle forme di lotta e di espressione di larghi strati di lavoratori salariati, di gio-
vani e di donne, di studenti, si è risposto con un atto di emarginazione politica da parte
del «sistema dei partiti», negando loro legittimità politica e sociale, deferendoli o ai prov-
vedimenti d'ordine pubblico o agli scarsi e inadeguati provvedimenti di carattere socio-
sanitario. Ed è proprio la «nuova composizione politica di classe» emersa dalla crisi che è
rimasta fuori dallo stato inteso come sistema dei partiti. Perciò le lotte di febbraio sono
benpoco lotte di studenti per la riforma dell'Università ma sono la prima aggregazione
politica della nuova composizione di classe che si batte, tra l'altro, anche per fare dell'U-
niversità una struttura integrata ad essa, come in parte già lo è, e non ostile, separata,
inutile.
Io non credo che dovremmo preoccuparci di sottolineare le riabilitazioni politiche che
sonocontenute nel testo di Montaldi, come quella di Bordiga. Più importante forse è ri-
190
















