
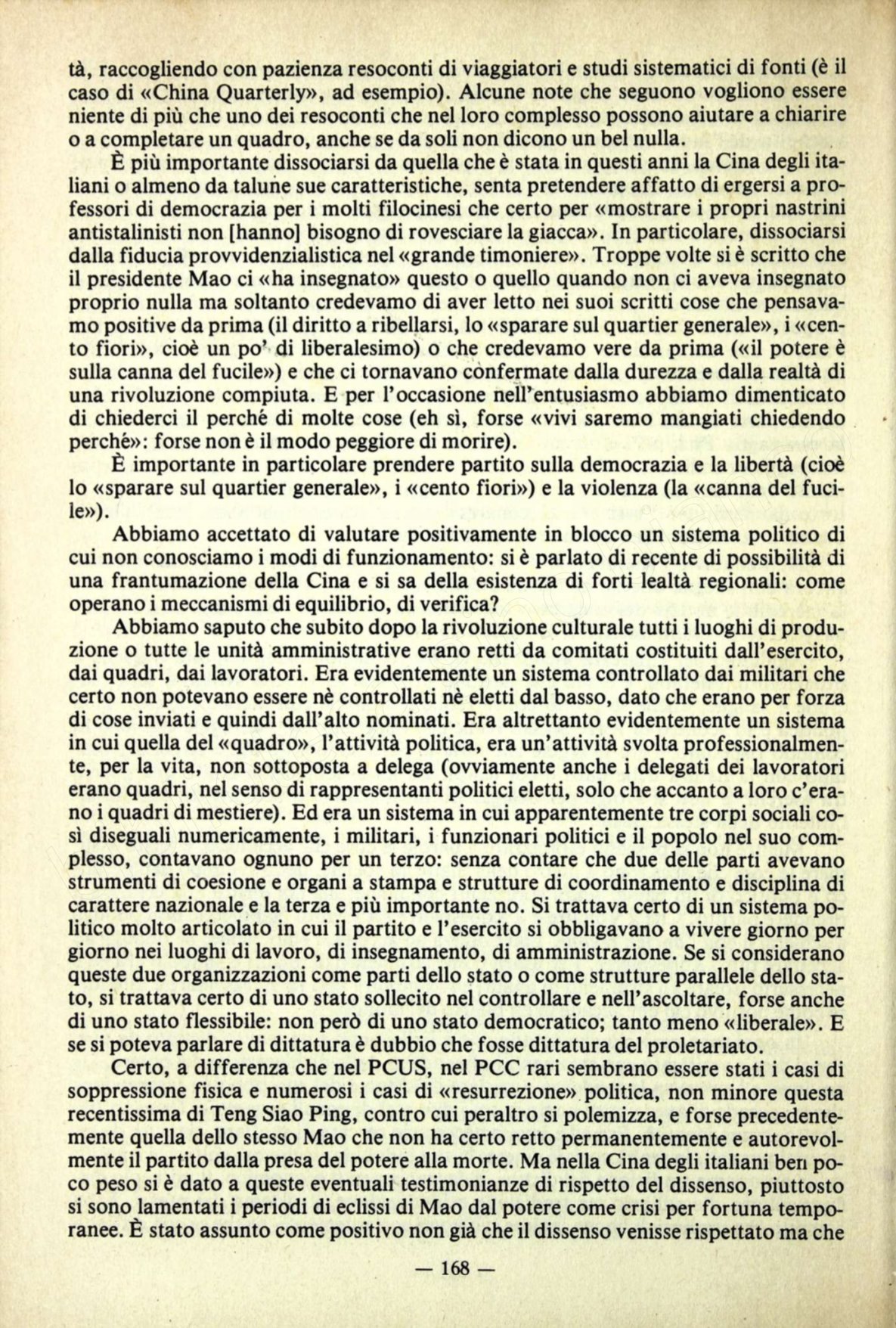
tà, raccogliendoconpazienza resoconti di viaggiatori estudi sistematici di fonti (è il
casodi «China Quarterly», ad esempio). Alcune note cheseguonovoglionoessere
niente di piùcheunodei resoconti chenel lorocomplessopossonoaiutare a chiarire
oacompletareunquadro, anchesedasoli nondiconounbel nulla.
t più importantedissociarsi da quellacheèstata inquesti anni la Cina degli ita-
liani oalmenoda talunesuecaratteristiche, sentapretendere affatto di ergersi a pro-
fessori di democrazia per i molti filocinesi checerto per «mostrare i propri nastrini
antistalinisti non [hanno] bisogno di rovesciare la giacca». In particolare, dissociarsi
dalla fiducia provvidenzialisticanel «grande timoniere». Troppe volte sièscrittoche
il presidente Mao ci «ha insegnato»questo o quello quando non ci aveva insegnato
proprio nullama soltantocredevamo di aver letto nei suoi scritti cosechepensava-
mopositiveda prima (il diritto a ribellarsi, lo «spararesul quartier generale», i «cen-
to fiori», cioè un po' di liberalesimo) o checredevamovere da prima («il potere è
sullacannadel fucile») echeci tornavano confermate dalla durezzae dalla realtà di
una rivoluzione compiuta. E per l'occasione nell'entusiasmo abbiamo dimenticato
di chiederci il perché di molte cose (eh sì, forse «vivi saremomangiati chiedendo
perché»: forsenonè il modopeggioredi morire).
È importante in particolare prendere partito sulla democrazia e la libertà (cioè
lo «sparare sul quartier generale», i «cento fiori») e la violenza (la «canna del fuci-
le»).
Abbiamo accettato di valutare positivamente in blocco un sistema politico di
cui nonconosciamo i modi di funzionamento: si èparlato di recente di possibilità di
una frantumazione della Cina e si sa della esistenza di forti lealtà regionali: come
operano imeccanismi di equilibrio, di verifica?
Abbiamosaputochesubitodopo la rivoluzione culturale tutti i luoghi di produ-
zione o tutte le unità amministrative erano retti da comitati costituiti dall'esercito,
dai quadri, dai lavoratori. Era evidentementeunsistemacontrollato dai militari che
certononpotevanoesserenè controllati nè eletti dal basso, datocheeranoper forza
dicose inviati e quindi dall'alto nominati. Era altrettanto evidentemente unsistema
incui quella del «quadro», l'attività politica, era un'attività svoltaprofessionalmen-
te, per la vita, non sottoposta a delega (ovviamente anche i delegati dei lavoratori
eranoquadri, nel sensodi rappresentanti politici eletti, solocheaccantoa loro c'era-
no i quadri di mestiere). Ed eraunsistema in cui apparentemente tre corpi sociali co-
sìdiseguali numericamente, i militari, i funzionari politici e il popolo nel suocom-
plesso, contavanoognuno per un terzo: senza contare che due delle parti avevano
strumenti di coesioneeorgani a stampae strutture di coordinamentoedisciplina di
caratterenazionalee la terzaepiù importante no. Si trattava certo di unsistemapo-
liticomolto articolato in cui il partito e l'esercito si obbligavano a vivere giorno per
giornonei luoghi di lavoro, di insegnamento, di amministrazione. Sesi considerano
questedueorganizzazioni comeparti dello statoocomestrutture parallele dello sta-
to, si trattava certo di unostatosollecitonel controllare enell'ascoltare, forseanche
di uno stato flessibile: nonperò di uno statodemocratico; tantomeno «liberale». E
sesi poteva parlare di dittaturaèdubbiochefossedittatura del proletariato.
Certo, a differenza che nel PCUS, nel PCC rari sembranoesserestati i casi di
soppressione fisica enumerosi i casi di «resurrezione» politica, non minore questa
recentissimadi TengSiaoPing, contro cui peraltro si polemizza, e forseprecedente-
mentequella dellostessoMao chenon ha certo rettopermanentementee autorevol-
mente il partito dallapresadel potere allamorte. Ma nella Cina degli italiani benpo-
copesosi è dato a questeeventuali testimonianze di rispetto del dissenso, piuttosto
sisono lamentati i periodi di eclissi di Mao dal poterecomecrisi per fortuna tempo-
ranee. È statoassuntocomepositivonongiàche il dissensovenisserispettatomache
168
















