
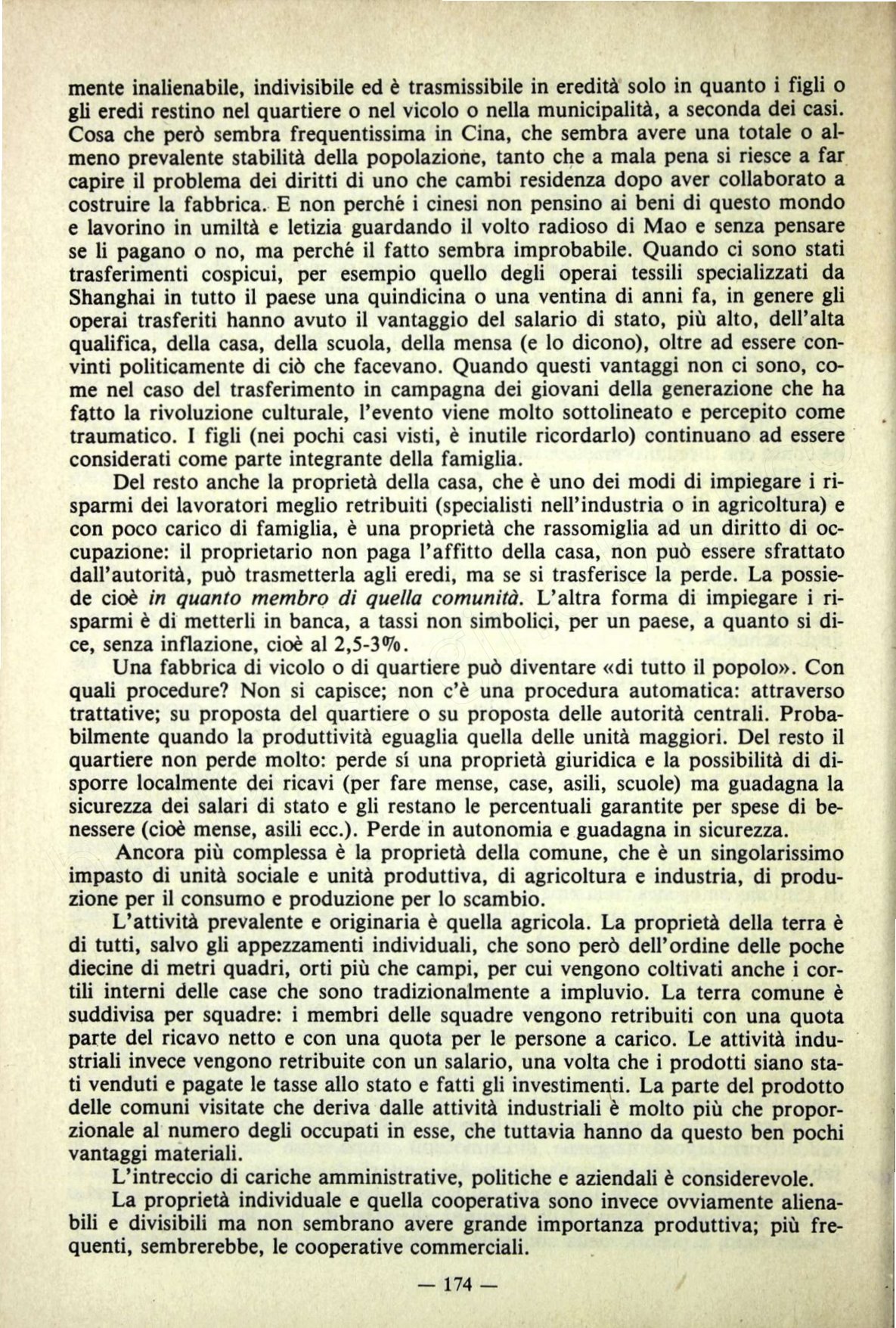
mente inalienabile, indivisibile ed è trasmissibile in eredità solo in quanto i figli o
gli eredi restino nel quartiere o nel vicolo o nella municipalità, a seconda dei casi.
Cosache però sembra frequentissima in Cina, che sembra avere una totale o al-
menoprevalente stabilità della popolazione, tanto che a mala pena si riesce a far
capire il problema dei diritti di uno che cambi residenza dopo aver collaborato a
costruire la fabbrica. E non perché i cinesi non pensino ai beni di questomondo
elavorino in umiltà e letizia guardando il volto radioso di Mao e senzapensare
se li pagano o no, ma perché il fatto sembra improbabile. Quando ci sono stati
trasferimenti cospicui, per esempio quello degli operai tessili specializzati da
Shanghai in tutto il paese una quindicina o una ventina di anni fa, in genere gli
operai trasferiti hanno avuto il vantaggio del salario di stato, più alto, dell'alta
qualifica, della casa, della scuola, dellamensa (e lo dicono), oltre ad esserecon-
vinti politicamente di ciò che facevano. Quando questi vantaggi non ci sono, co-
menel caso del trasferimento in campagna dei giovani della generazione che ha
fatto la rivoluzione culturale, l'evento viene molto sottolineato e percepito come
traumatico. I figli (nei pochi casi visti, è inutile ricordarlo) continuano ad essere
considerati come parte integrante della famiglia.
Del restoanche la proprietà della casa, che è uno dei modi di impiegare i ri-
sparmi dei lavoratori meglio retribuiti (specialisti nell'industria o in agricoltura) e
conpoco carico di famiglia, è una proprietà che rassomiglia ad un diritto di oc-
cupazione: il proprietario non paga l'affitto della casa, non può essere sfrattato
dall'autorità, può trasmetterla agli eredi, ma se si trasferisce la perde. La possie-
decioè
in quanto membro di quella comunità.
L'altra forma di impiegare i ri-
sparmi è di metterli in banca, a tassi non simbolici, per un paese, a quanto si di-
ce,senza inflazione, cioè al 2,5-3%.
Una fabbrica di vicolo o di quartiere può diventare «di tutto il popolo». Con
quali procedure? Non si capisce; non c'è una procedura automatica: attraverso
trattative; su proposta del quartiere o su proposta delle autorità centrali. Proba-
bilmente quando la produttività eguaglia quella delle unità maggiori. Del resto il
quartiere non perdemolto: perde si una proprietà giuridica e la possibilità di di-
sporre localmente dei ricavi (per fare mense, case, asili, scuole) ma guadagna la
sicurezza dei salari di stato e gli restano le percentuali garantite per spese di be-
nessere(cioèmense, asili ecc.). Perde in autonomia e guadagna in sicurezza.
Ancora più complessa è la proprietà della comune, che è un singolarissimo
impasto di unità sociale e unità produttiva, di agricoltura e industria, di produ-
zioneper il consumo e produzione per lo scambio.
L'attività prevalente e originaria è quella agricola. La proprietà della terra è
di tutti, salvo gli appezzamenti individuali, che sono però dell'ordine delle poche
diecine di metri quadri, orti più che campi, per cui vengono coltivati anche i cor-
tili interni delle case che sono tradizionalmente a impluvio. La terra comune è
suddivisa per squadre: i membri delle squadre vengono retribuiti con una quota
parte del ricavo netto e con una quota per le persone a carico. Le attività indu-
striali invecevengono retribuite con un salario, una volta che i prodotti siano sta-
ti venduti e pagate le tasse allo stato e fatti gli investimenti. La parte del prodotto
delle comuni visitate che deriva dalle attività industriali è molto più che propor-
zionale al numero degli occupati in esse, che tuttavia hanno da questo ben pochi
vantaggi materiali.
L'intreccio di cariche amministrative, politiche e aziendali è considerevole.
La proprietà individuale e quella cooperativa sono invece ovviamente aliena-
bili e divisibili ma non sembrano avere grande importanza produttiva; più fre-
quenti, sembrerebbe, le cooperative commerciali.
174
















