
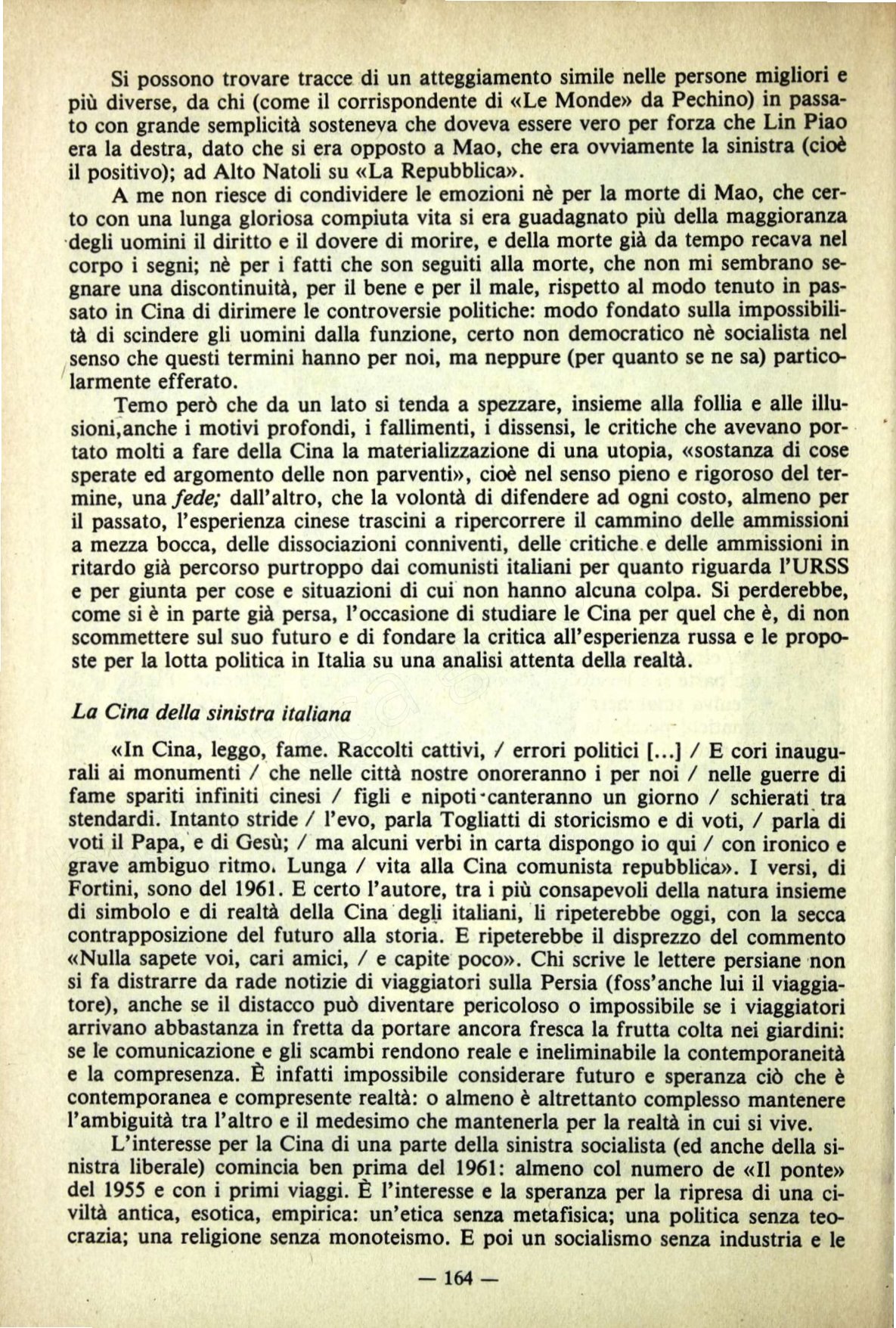
Si possono trovare tracce di un atteggiamento simile nelle persone migliori e
più diverse, da chi (come il corrispondente di «Le Monde» da Pechino) in passa-
to con grande semplicità sosteneva che doveva essere vero per forza che Lin Piao
era la destra, dato che si era opposto a Mao, che era ovviamente la sinistra (cioè
il positivo); ad Alto Natoli su «La Repubblica».
A me non riesce di condividere le emozioni nè per la morte di Mao, che cer-
to con una lunga gloriosa compiuta vita si era guadagnato più della maggioranza
degli uomini il diritto e il dovere di morire, e della morte già da tempo recava nel
corpo i segni; nè per i fatti che son seguiti alla morte, che non mi sembrano se-
gnare una discontinuità, per il bene e per il male, rispetto al modo tenuto in pas-
sato in Cina di dirimere le controversie politiche: modo fondato sulla impossibili-
tà di scindere gli uomini dalla funzione, certo non democratico nè socialista nel
sensoche questi termini hanno per noi, ma neppure (per quanto se ne sa) partico-
larmente efferato.
Temo però che da un lato si tenda a spezzare, insieme alla follia e alle illu-
sioni,anche i motivi profondi, i fallimenti, i dissensi, le critiche che avevano por-
tato molti a fare della Cina la materializzazione di una utopia, «sostanza di cose
sperate ed argomento delle non parventi», cioè nel senso pieno e rigoroso del ter-
mine, una
fede;
dall'altro, che la volontà di difendere ad ogni costo, almeno per
il passato, l'esperienza cinese trascini a ripercorrere il cammino delle ammissioni
amezza bocca, delle dissociazioni conniventi, delle critiche e delle ammissioni in
ritardo già percorso purtroppo dai comunisti italiani per quanto riguarda l'URSS
eper giunta per cose e situazioni di cui non hanno alcuna colpa. Si perderebbe,
come si è in parte già persa, l'occasione di studiare le Cina per quel che è, di non
scommettere sul suo futuro e di fondare la critica all'esperienza russa e le propo-
steper la lotta politica in Italia su una analisi attenta della realtà.
La Cina della sinistra italiana
«In Cina, leggo, fame. Raccolti cattivi, / errori politici L . ] / E cori inaugu-
rali ai monumenti / che nelle città nostre onoreranno i per noi / nelle guerre di
fame spariti infiniti cinesi / figli e nipoti -canteranno un giorno / schierati tra
stendardi. Intanto stride / l'evo, parla Togliatti di storicismo e di voti, / parla di
voti il Papa, e di Gesù; / ma alcuni verbi in carta dispongo io qui / con ironico e
grave ambiguo ritmo. Lunga / vita alla Cina comunista repubblica». I versi, di
Fortini, sono del 1961. E certo l'autore, tra i più consapevoli della natura insieme
di simbolo e di realtà della Cina degli italiani, l i ripeterebbe oggi, con la secca
contrapposizione del futuro alla storia. E ripeterebbe il disprezzo del commento
«Nulla sapete voi, cari amici, / e capite poco». Chi scrive le lettere persiane non
si fa distrarre da rade notizie di viaggiatori sulla Persia (foss'anche lui il viaggia-
tore), anche se il distacco può diventare pericoloso o impossibile se i viaggiatori
arrivano abbastanza in fretta da portare ancora fresca la frutta colta nei giardini:
sele comunicazione e gli scambi rendono reale e ineliminabile la contemporaneità
e la compresenza. È infatti impossibile considerare futuro e speranza ciò che è
contemporanea e compresente realtà: o almeno è altrettanto complessomantenere
l'ambiguità tra l'altro e il medesimo chemantenerla per la realtà in cui si vive.
L'interesse per la Cina di una parte della sinistra socialista (ed anche della si-
nistra liberale) comincia ben prima del 1961: almeno col numero de «Il ponte»
del 1955 e con i primi viaggi. È l'interesse e la speranza per la ripresa di una ci-
viltà antica, esotica, empirica: un'etica senza metafisica; una politica senza teo-
crazia; una religione senza monoteismo. E poi un socialismo senza industria e le
164
















