
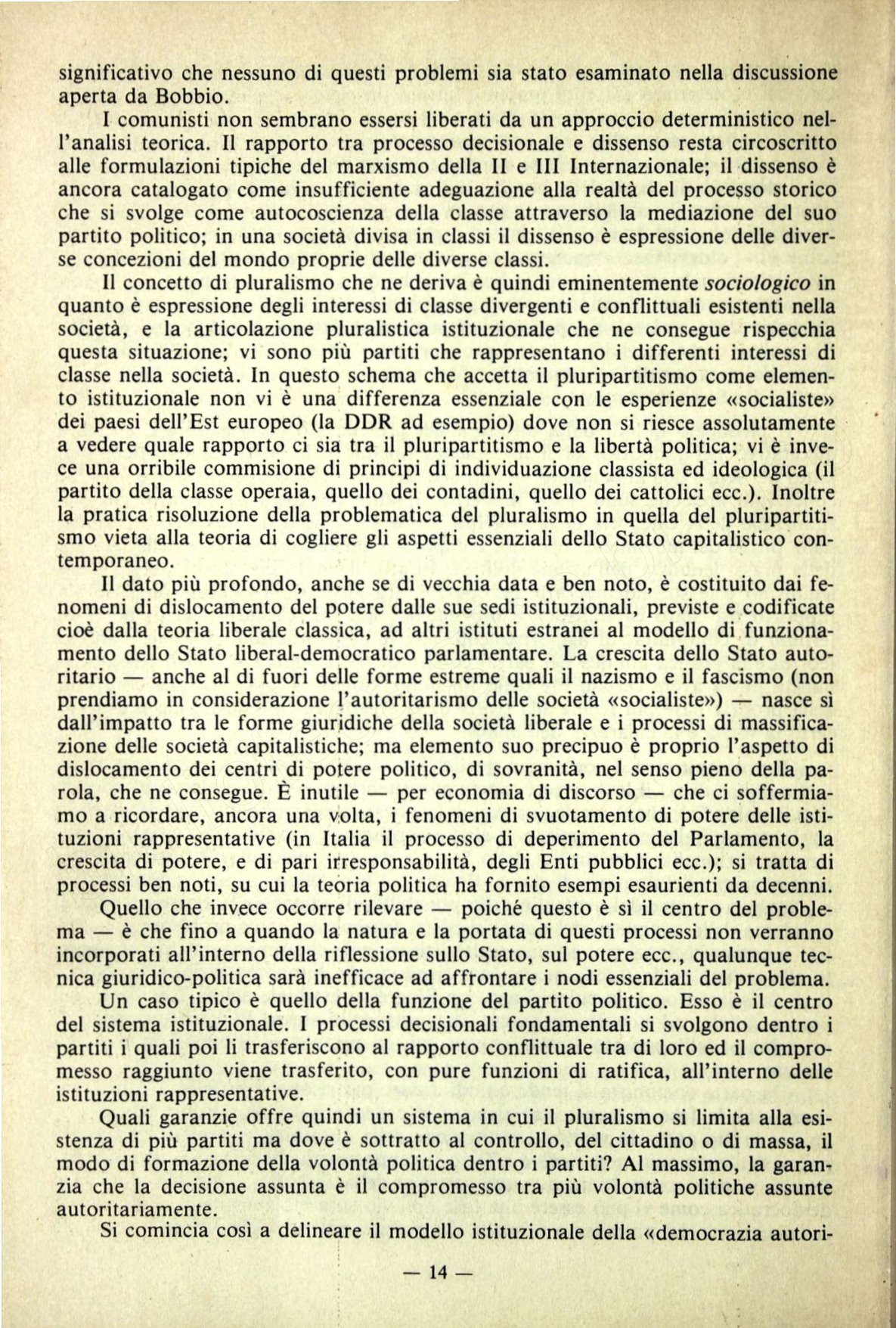
significativo che nessuno di questi problemi sia stato esaminato nella discussione
aperta da Bobbio.
I comunisti non sembranoessersi liberati da un approccio deterministico nel-
l'analisi teorica. I l rapporto tra processo decisionale e dissenso resta circoscritto
alle formulazioni tipiche del marxismo della I I e I I I Internazionale; i l dissenso è
ancora catalogato come insufficiente adeguazione alla realtà del processo storico
che si svolge come autocoscienza della classe attraverso la mediazione del suo
partito politico; in una società divisa in classi il dissenso è espressione delle diver-
seconcezioni del mondo proprie delle diverse classi.
Il concetto di pluralismo che ne deriva è quindi eminentemente
sociologico
in
quanto è espressione degli interessi di classe divergenti e conflittuali esistenti nella
società, e la articolazione pluralistica istituzionale che ne consegue rispecchia
questa situazione; vi sono più partiti che rappresentano i differenti interessi di
classe nella società. In questo schema che accetta il pluripartitismo come elemen-
to istituzionale non vi è una differenza essenziale con le esperienze «socialiste»
dei paesi dell'Est europeo (la DDR ad esempio) dove non si riesce assolutamente
avedere quale rapporto ci sia tra il pluripartitismo e la libertà politica; vi è inve-
ceuna orribile commisione di principi di individuazione classista ed ideologica (il
partito della classe operaia, quello dei contadini, quello dei cattolici ecc.). Inoltre
la pratica risoluzione della problematica del pluralismo in quella del pluripartiti-
smo vieta alla teoria di cogliere gli aspetti essenziali dello Stato capitalistico con-
temporaneo.
Il dato più profondo, anche se di vecchia data e ben noto, è costituito dai fe-
nomeni di dislocamento del potere dalle sue sedi istituzionali, previste e codificate
cioè dalla teoria liberale classica, ad altri istituti estranei al modello di funziona-
mento dello Stato liberal-democratico parlamentare. La crescita dello Stato auto-
ritario — anche al di fuori delle forme estreme quali il nazismo e il fascismo (non
prendiamo in considerazione l'autoritarismo delle società «socialiste») — nasce sì
dall'impatto tra le forme giuridiche della società liberale e i processi di massifica-
zione delle società capitalistiche; ma elemento suo precipuo è proprio l'aspetto di
dislocamento dei centri di potere politico, di sovranità, nel senso pieno della pa-
rola, che ne consegue. È inutile — per economia di discorso — che ci soffermia-
mo a ricordare, ancora una volta, i fenomeni di svuotamento di potere delle isti-
tuzioni rappresentative (in Italia il processo di deperimento del Parlamento, la
crescita di potere, e di pari irresponsabilità, degli Enti pubblici ecc.); si tratta di
processi ben noti, su cui la teoria politica ha fornito esempi esaurienti da decenni.
Quello che invece occorre rilevare — poiché questo è sì il centro del proble-
ma — è che fino a quando la natura e la portata di questi processi non verranno
incorporati all'interno della riflessione sullo Stato, sul potere ecc., qualunque tec-
nica giuridico-politica sarà inefficace ad affrontare i nodi essenziali del problema.
Un caso tipico è quello della funzione del partito politico. Esso è il centro
del sistema istituzionale. I processi decisionali fondamentali si svolgono dentro i
partiti i quali poi li trasferiscono al rapporto conflittuale tra di loro ed il compro-
messo raggiunto viene trasferito, con pure funzioni di ratifica, all'interno delle
istituzioni rappresentative.
Quali garanzie offre quindi un sistema in cui il pluralismo si limita alla esi-
stenza di più partiti ma dove è sottratto al controllo, del cittadino o di massa, il
modo di formazione della volontà politica dentro i partiti? Al massimo, la garan-
zia che la decisione assunta è il compromesso tra più volontà politiche assunte
autoritariamente.
Si comincia così a delineare il modello istituzionale della «democrazia autori-
- 1 4
















