
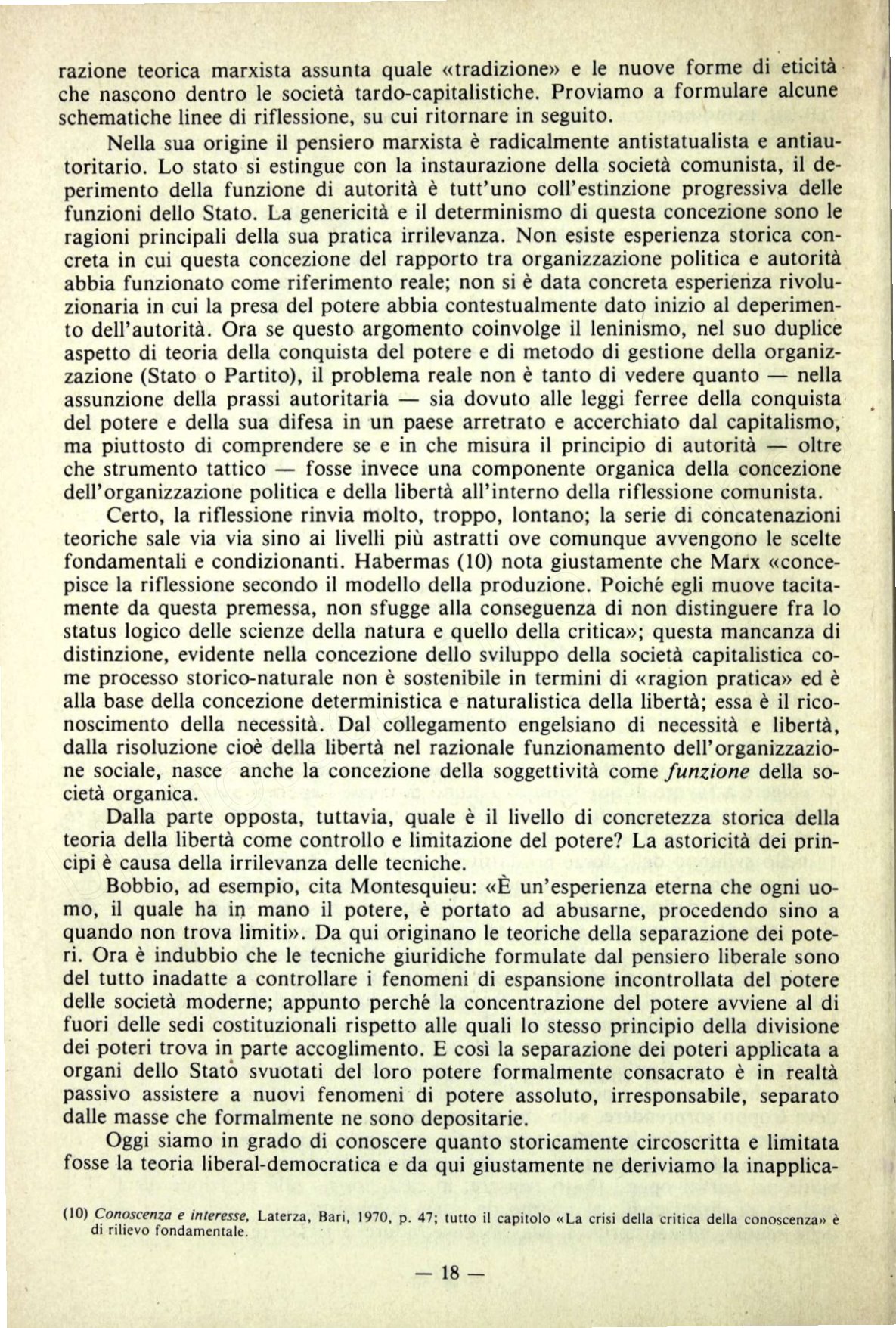
razione teorica marxista assunta quale «tradizione» e le nuove forme di eticità
chenascono dentro le società tardo-capitalistiche. Proviamo a formulare alcune
schematiche linee di riflessione, su cui ritornare in seguito.
Nella sua origine il pensiero marxista è radicalmente antistatualista e antiau-
toritario. Lo stato si estingue con la instaurazione della società comunista, il de-
perimento della funzione di autorità è tutt'uno coll'estinzione progressiva delle
funzioni dello Stato. La genericità e il determinismo di questa concezione sono le
ragioni principali della sua pratica irrilevanza. Non esiste esperienza storica con-
creta in cui questa concezione del rapporto tra organizzazione politica e autorità
abbia funzionato come riferimento reale; non si è data concreta esperienza rivolu-
zionaria in cui la presa del potere abbia contestualmente dato inizio al deperimen-
to dell'autorità. Ora se questo argomento coinvolge il leninismo, nel suo duplice
aspetto di teoria della conquista del potere e di metodo di gestione della organiz-
zazione (Stato o Partito), il problema reale non è tanto di vedere quanto — nella
assunzione della prassi autoritaria — sia dovuto alle leggi ferree della conquista
del potere e della sua difesa in un paese arretrato e accerchiato dal capitalismo,
ma piuttosto di comprendere se e in che misura il principio di autorità — oltre
chestrumento tattico — fosse invece una componente organica della concezione
dell'organizzazione politica e della libertà all'interno della riflessione comunista.
Certo, la riflessione rinvia molto, troppo, lontano; la serie di concatenazioni
teoriche sale via via sino ai livelli più astratti ove comunque avvengono le scelte
fondamentali e condizionanti. Habermas (10) nota giustamente che Marx «conce-
pisce la riflessione secondo il modello della produzione. Poiché egli muove tacita-
mente da questa premessa, non sfugge alla conseguenza di non distinguere fra lo
status logico delle scienze della natura e quello della critica»; questa mancanza di
distinzione, evidente nella concezione dello sviluppo della società capitalistica co-
meprocesso storico-naturale non è sostenibile in termini di «ragion pratica» ed è
alla base della concezione deterministica e naturalistica della libertà; essa è il rico-
noscimento della necessità. Dal collegamento engelsiano di necessità e libertà,
dalla risoluzione cioè della libertà nel razionale funzionamento dell'organizzazio-
nesociale, nasce anche la concezione della soggettività come
funzione
della so-
cietà organica.
Dalla parte opposta, tuttavia, quale è il livello di concretezza storica della
teoria della libertà come controllo e limitazione del potere? La astoricità dei prin-
cipi è causa della irrilevanza delle tecniche.
Bobbio, ad esempio, cita Montesquieu: «È un'esperienza eterna che ogni uo-
mo, i l quale ha in mano i l potere, è portato ad abusarne, procedendo sino a
quando non trova limiti». Da qui originano le teoriche della separazione dei pote-
ri. Ora è indubbio che le tecniche giuridiche formulate dal pensiero liberale sono
del tutto inadatte a controllare i fenomeni di espansione incontrollata del potere
delle società moderne; appunto perché la concentrazione del potere avviene al di
fuori delle sedi costituzionali rispetto alle quali lo stesso principio della divisione
dei poteri trova in parte accoglimento. E così la separazione dei poteri applicata a
organi dello Statò svuotati del loro potere formalmente consacrato è in realtà
passivoassistere a nuovi fenomeni di potere assoluto, irresponsabile, separato
dallemasseche formalmente ne sono depositarie.
Oggi siamo in grado di conoscere quanto storicamente circoscritta e limitata
fosse la teoria liberal-democratica e da qui giustamente ne deriviamo la inapplica-
(10)
Conoscenza
e
interesse,
Laterza, Bari, 1970, p. 47; tutto il capitolo «La crisi della critica della conoscenza» è
di rilievo fondamentale.
18—
















