
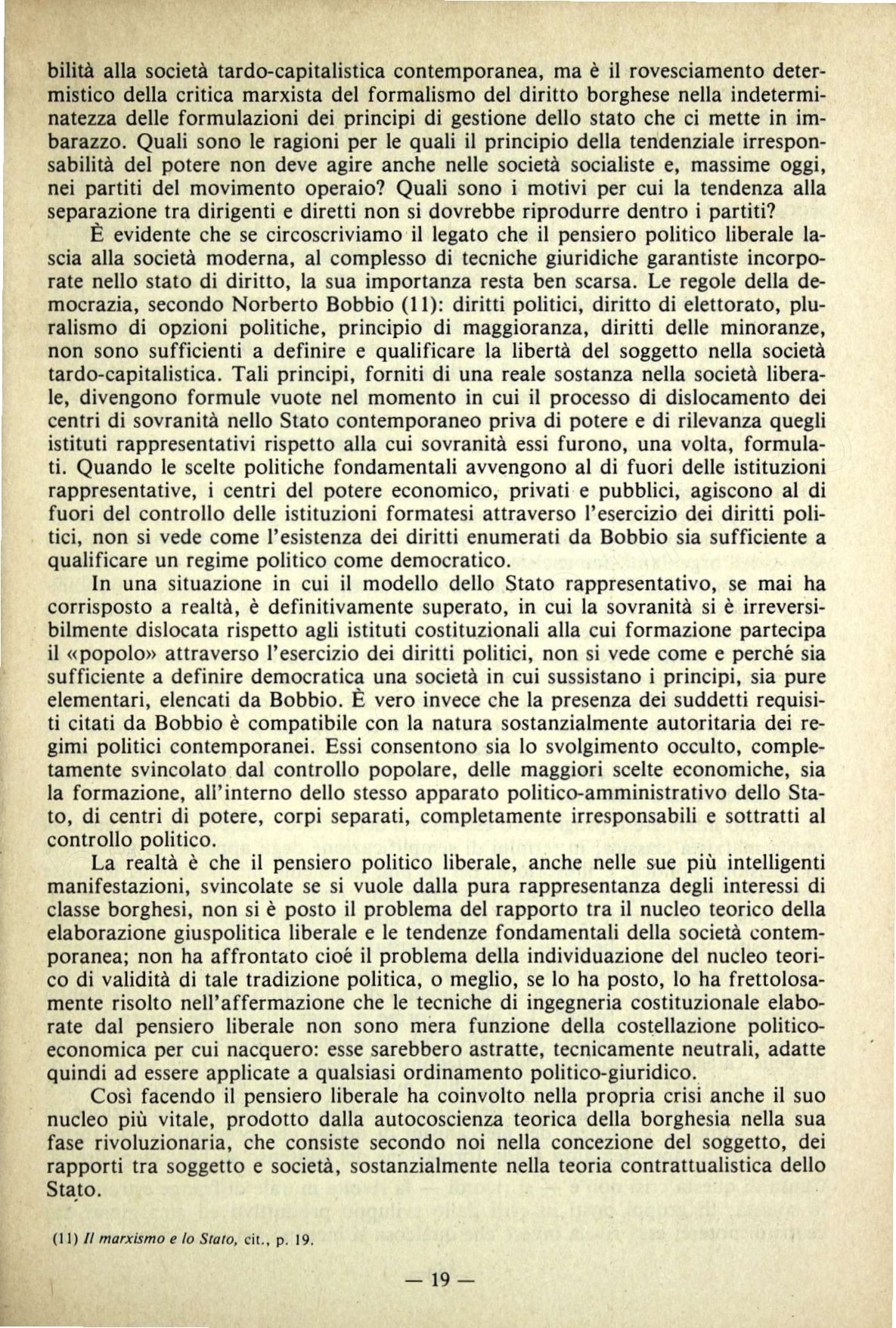
bilità alla società tardo-capitalistica contemporanea, ma è il rovesciamento deter-
mistico della critica marxista del formalismo del diritto borghese nella indetermi-
natezza delle formulazioni dei principi di gestione dello stato che ci mette in im-
barazzo. Quali sono le ragioni per le quali il principio della tendenziale irrespon-
sabilità del potere non deve agire anche nelle società socialiste e, massime oggi,
nei partiti del movimento operaio? Quali sono i motivi per cui la tendenza alla
separazione tra dirigenti e diretti non si dovrebbe riprodurre dentro i partiti?
È evidente che se circoscriviamo il legato che il pensiero politico liberale la-
scia alla società moderna, al complesso di tecniche giuridiche garantiste incorpo-
rate nello stato di diritto, la sua importanza resta ben scarsa. Le regole della de-
mocrazia, secondo Norberto Bobbio (11): diritti politici, diritto di elettorato, plu-
ralismo di opzioni politiche, principio di maggioranza, diritti delle minoranze,
non sono sufficienti a definire e qualificare la libertà del soggetto nella società
tardo-capitalistica. Tali principi, forniti di una reale sostanza nella società libera-
le, divengono formule vuote nel momento in cui il processo di dislocamento dei
centri di sovranità nello Stato contemporaneo priva di potere e di rilevanza quegli
istituti rappresentativi rispetto alla cui sovranità essi furono, una volta, formula-
ti. Quando le scelte politiche fondamentali avvengono al di fuori delle istituzioni
rappresentative, i centri del potere economico, privati e pubblici, agiscono al di
fuori del controllo delle istituzioni formatesi attraverso l'esercizio dei diritti poli-
tici, non si vede come l'esistenza dei diritti enumerati da Bobbio sia sufficiente a
qualificare un regime politico come democratico.
In una situazione in cui i l modello dello Stato rappresentativo, se mai ha
corrisposto a realtà, è definitivamente superato, in cui la sovranità si è irreversi-
bilmente dislocata rispetto agli istituti costituzionali alla cui formazione partecipa
il «popolo» attraverso l'esercizio dei diritti politici, non si vede come e perché sia
sufficiente a definire democratica una società in cui sussistano i principi, sia pure
elementari, elencati da Bobbio. È vero invece che la presenza dei suddetti requisi-
ti citati da Bobbio è compatibile con la natura sostanzialmente autoritaria dei re-
gimi politici contemporanei. Essi consentono sia lo svolgimento occulto, comple-
tamente svincolato dal controllo popolare, delle maggiori scelte economiche, sia
la formazione, all'interno dello stesso apparato politico-amministrativo dello Sta-
to, di centri di potere, corpi separati, completamente irresponsabili e sottratti al
controllo politico.
La realtà è che il pensiero politico liberale, anche nelle sue più intelligenti
manifestazioni, svincolate se si vuole dalla pura rappresentanza degli interessi di
classeborghesi, non si è posto il problema del rapporto tra il nucleo teorico della
elaborazione giuspolitica liberale e le tendenze fondamentali della società contem-
poranea; non ha affrontato cioè il problema della individuazione del nucleo teori-
co di validità di tale tradizione politica, o meglio, se lo ha posto, lo ha frettolosa-
mente risolto nell'affermazione che le tecniche di ingegneria costituzionale elabo-
rate dal pensiero liberale non sono mera funzione della costellazione politico-
economica per cui nacquero: esse sarebbero astratte, tecnicamente neutrali, adatte
quindi ad essere applicate a qualsiasi ordinamento politico-giuridico.
Così facendo il pensiero liberale ha coinvolto nella propria crisi anche il suo
nucleo più vitale, prodotto dalla autocoscienza teorica della borghesia nella sua
fase rivoluzionaria, che consiste secondo noi nella concezione del soggetto, dei
rapporti tra soggetto e società, sostanzialmente nella teoria contrattualistica dello
Stato.
(11) Il marxismo e Io Stato, cit., p. 19.
19
















