
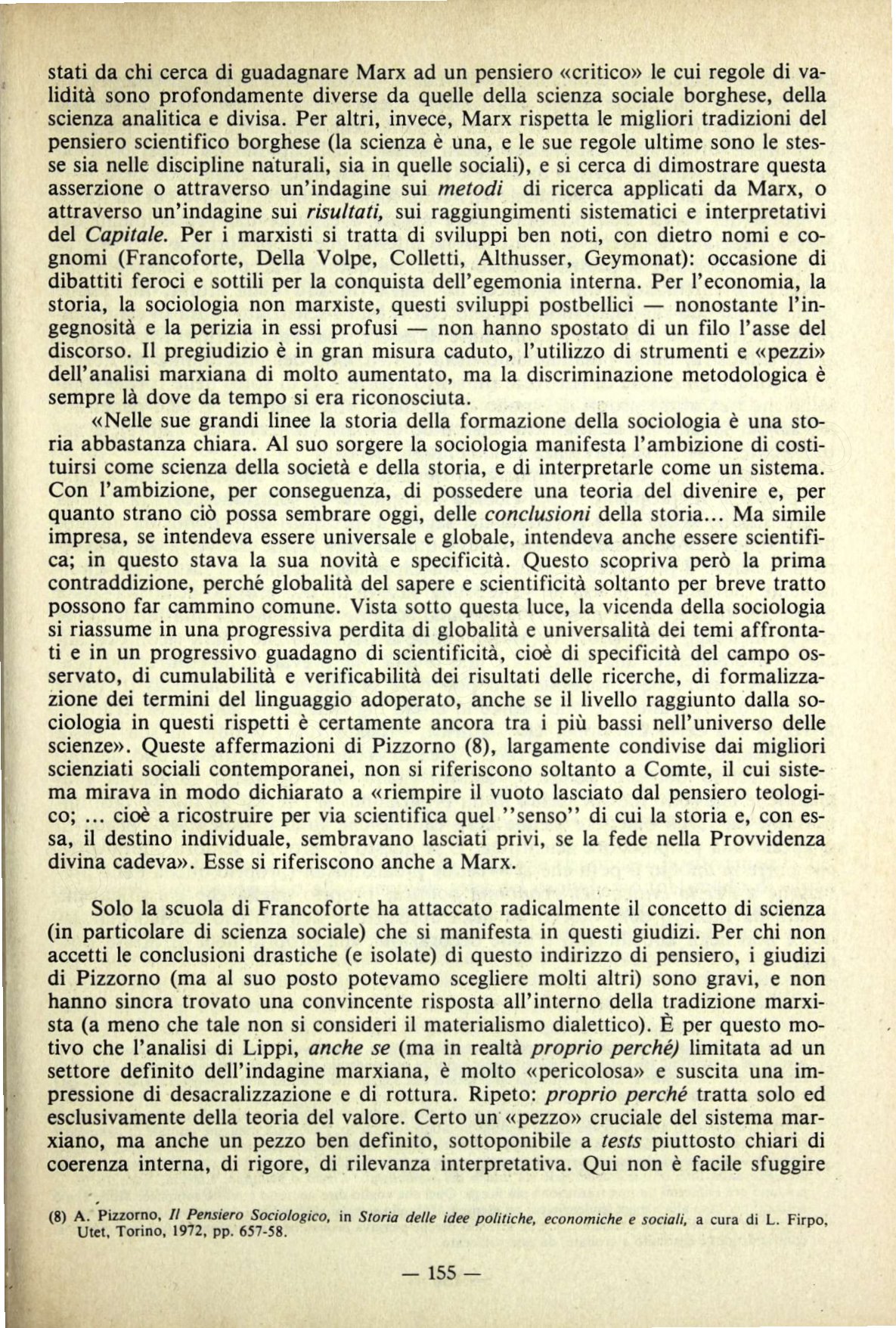
stati da chi cerca di guadagnare Marx ad un pensiero «critico» le cui regole di va-
lidità sono profondamente diverse da quelle della scienza sociale borghese, della
scienza analitica e divisa. Per altri, invece, Marx rispetta le migliori tradizioni del
pensiero scientifico borghese (la scienza è una, e le sue regole ultime sono le stes-
sesia nelle discipline naturali, sia in quelle sociali), e si cerca di dimostrare questa
asserzione o attraverso un'indagine sui
metodi
d i ricerca applicati da Marx, o
attraverso un'indagine sui
risultati,
sui raggiungimenti sistematici e interpretativi
del
Capitale.
Per i marxisti si tratta di sviluppi ben noti, con dietro nomi e co-
gnomi (Francoforte, Della Volpe, Colletti, Althusser, Geymonat): occasione di
dibattiti feroci e sottili per la conquista dell'egemonia interna. Per l'economia, la
storia, la sociologia non marxiste, questi sviluppi postbellici — nonostante l'in-
gegnosità e la perizia in essi profusi — non hanno spostato di un filo l'asse del
discorso. I l pregiudizio è in gran misura caduto, l'utilizzo di strumenti e «pezzi»
dell'analisi marxiana di molto aumentato, ma la discriminazione metodologica è
sempre là dove da tempo si era riconosciuta.
«Nelle sue grandi linee la storia della formazione della sociologia è una sto-
ria abbastanza chiara. Al suo sorgere la sociologia manifesta l'ambizione di costi-
tuirsi come scienza della società e della storia, e di interpretarle come un sistema.
Con l'ambizione, per conseguenza, di possedere una teoria del divenire e, per
quanto strano ciò possa sembrare oggi, delle
conclusioni
della storia... Ma simile
impresa, se intendeva essere universale e globale, intendeva anche essere scientifi-
ca; in questo stava la sua novità e specificità. Questo scopriva però la prima
contraddizione, perché globalità del sapere e scientificità soltanto per breve tratto
possono far cammino comune. Vista sotto questa luce, la vicenda della sociologia
si riassume in una progressiva perdita di globalità e universalità dei temi affronta-
ti e in un progressivo guadagno di scientificità, cioè di specificità del campo os-
servato, di cumulabilità e verificabilità dei risultati delle ricerche, di formalizza-
zione dei termini del linguaggio adoperato, anche se il livello raggiunto dalla so-
ciologia in questi rispetti è certamente ancora tra i più bassi nell'universo delle
scienze». Queste affermazioni di Pizzorno (8), largamente condivise dai migliori
scienziati sociali contemporanei, non si riferiscono soltanto a Comte, il cui siste-
ma mirava in modo dichiarato a «riempire il vuoto lasciato dal pensiero teologi-
co; ..• cioè a ricostruire per via scientifica quel "senso" di cui la storia e, con es-
sa, il destino individuale, sembravano lasciati privi, se la fede nella Provvidenza
divina cadeva». Esse si riferiscono anche a Marx.
Solo la scuola di Francoforte ha attaccato radicalmente il concetto di scienza
(in particolare di scienza sociale) che si manifesta in questi giudizi. Per chi non
accetti le conclusioni drastiche (e isolate) di questo indirizzo di pensiero, i giudizi
di Pizzorno (ma al suo posto potevamo scegliere molti altri) sono gravi, e non
hanno sinora trovato una convincente risposta all'interno della tradizione marxi-
sta (a meno che tale non si consideri il materialismo dialettico). È per questo mo-
tivo che l'analisi di Lippi,
anche se
(ma in realtà
proprio perché) limitata
ad un
settore definito dell'indagine marxiana, è molto «pericolosa» e suscita una im-
pressione di desacralizzazione e di rottura. Ripeto:
proprio perché
tratta solo ed
esclusivamente della teoria del valore. Certo un «pezzo» cruciale del sistema mar-
xiano, ma anche un pezzo ben definito, sottoponibile a
tests
piuttosto chiari di
coerenza interna, di rigore, di rilevanza interpretativa. Qui non è facile sfuggire
(8) A. Pizzorno, I l Pensiero Sociologico, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali, a cura di L. Firpo,
Utet, Torino, 1972, pp. 657-58.
- 155 -
















