
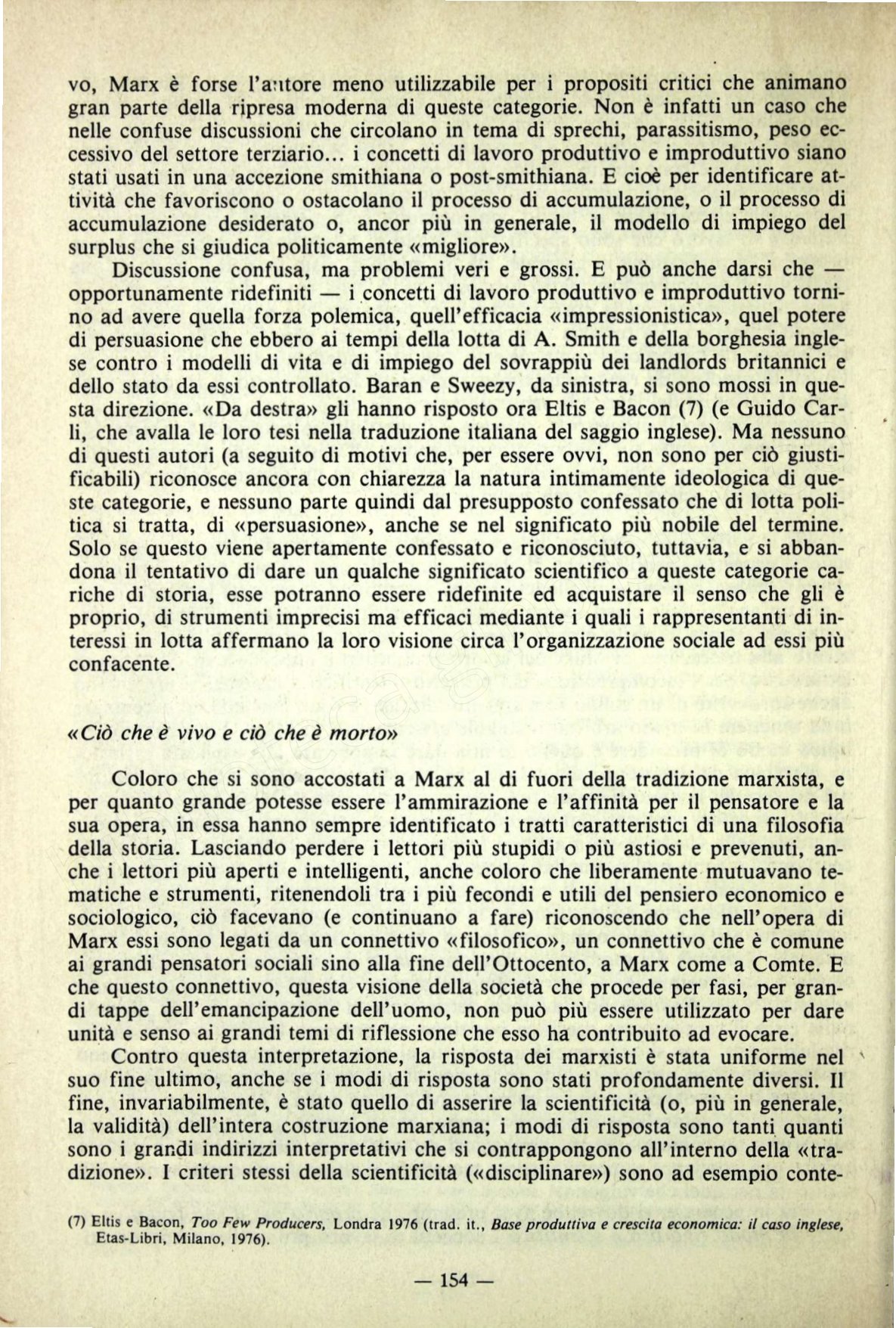
vo, Marx è forse l'autore meno utilizzabile per i propositi critici che animano
gran parte della ripresa moderna di queste categorie. Non è infatti un caso che
nelle confuse discussioni che circolano in tema di sprechi, parassitismo, peso ec-
cessivodel settore terziario.., i concetti di lavoro produttivo e improduttivo siano
stati usati in una accezione smithiana o post-smithiana. E cioè per identificare at-
tività che favoriscono o ostacolano il processo di accumulazione, o il processo di
accumulazione desiderato o, ancor più in generale, i l modello di impiego del
surplus che si giudica politicamente «migliore».
Discussione confusa, ma problemi veri e grossi. E può anche darsi che
opportunamente ridefiniti — i concetti di lavoro produttivo e improduttivo torni-
no ad avere quella forza polemica, quell'efficacia «impressionistica», quel potere
di persuasione che ebbero ai tempi della lotta di A. Smith e della borghesia ingle-
secontro i modelli di vita e di impiego del sovrappiù dei landlords britannici e
dello stato da essi controllato. Baran e Sweezy, da sinistra, si sonomossi in que-
stadirezione. «Da destra» gli hanno risposto ora Eltis e Bacon (7) (e Guido Car-
li, che avalla le loro tesi nella traduzione italiana del saggio inglese). Ma nessuno
di questi autori (a seguito di motivi che, per essere ovvi, non sono per ciò giusti-
ficabili) riconosce ancora con chiarezza la natura intimamente ideologica di que-
stecategorie, e nessuno parte quindi dal presupposto confessato che di lotta poli-
tica si tratta, di «persuasione», anche se nel significato più nobile del termine.
Solo se questo viene apertamente confessato e riconosciuto, tuttavia, e si abban-
dona il tentativo di dare un qualche significato scientifico a queste categorie ca-
riche di storia, esse potranno essere ridefinite ed acquistare i l senso che gli è
proprio, di strumenti imprecisi ma efficaci mediante i quali i rappresentanti di in-
teressi in lotta affermano la loro visione circa l'organizzazione sociale ad essi più
confacente.
«Ciò che è vivo e ciò che è morto»
Coloro che si sono accostati a Marx al di fuori della tradizione marxista, e
per quanto grande potesse essere l'ammirazione e l'affinità per il pensatore e la
suaopera, in essa hanno sempre identificato i tratti caratteristici di una filosofia
della storia. Lasciando perdere i lettori più stupidi o più astiosi e prevenuti, an-
che i lettori più aperti e intelligenti, anche coloro che liberamente mutuavano te-
matiche e strumenti, ritenendoli tra i più fecondi e utili del pensiero economico e
sociologico, ciò facevano (e continuano a fare) riconoscendo che nell'opera di
Marx essi sono legati da un connettivo «filosofico», un connettivo che è comune
ai grandi pensatori sociali sino alla fine dell'Ottocento, a Marx come a Comte. E
chequesto connettivo, questa visione della società che procede per fasi, per gran-
di tappe dell'emancipazione dell'uomo, non può più essere utilizzato per dare
unità e senso ai grandi temi di riflessione cheesso ha contribuito ad evocare.
Contro questa interpretazione, la risposta dei marxisti è stata uniforme nel
suo fine ultimo, anche se i modi di risposta sono stati profondamente diversi. I l
fine, invariabilmente, è stato quello di asserire la scientificità (o, più in generale,
la validità) dell'intera costruzione marxiana; i modi di risposta sono tanti quanti
sono i grandi indirizzi interpretativi che si contrappongono all'interno della «tra-
dizione». I criteri stessi della scientificità («disciplinare») sono ad esempio conte-
(7) Eltis e Bacon, Too Few Producers, Londra 1976 (trad. it., Base produttiva e crescita economica: il caso inglese,
Etas-Libri, Milano, 1976).
154
















