
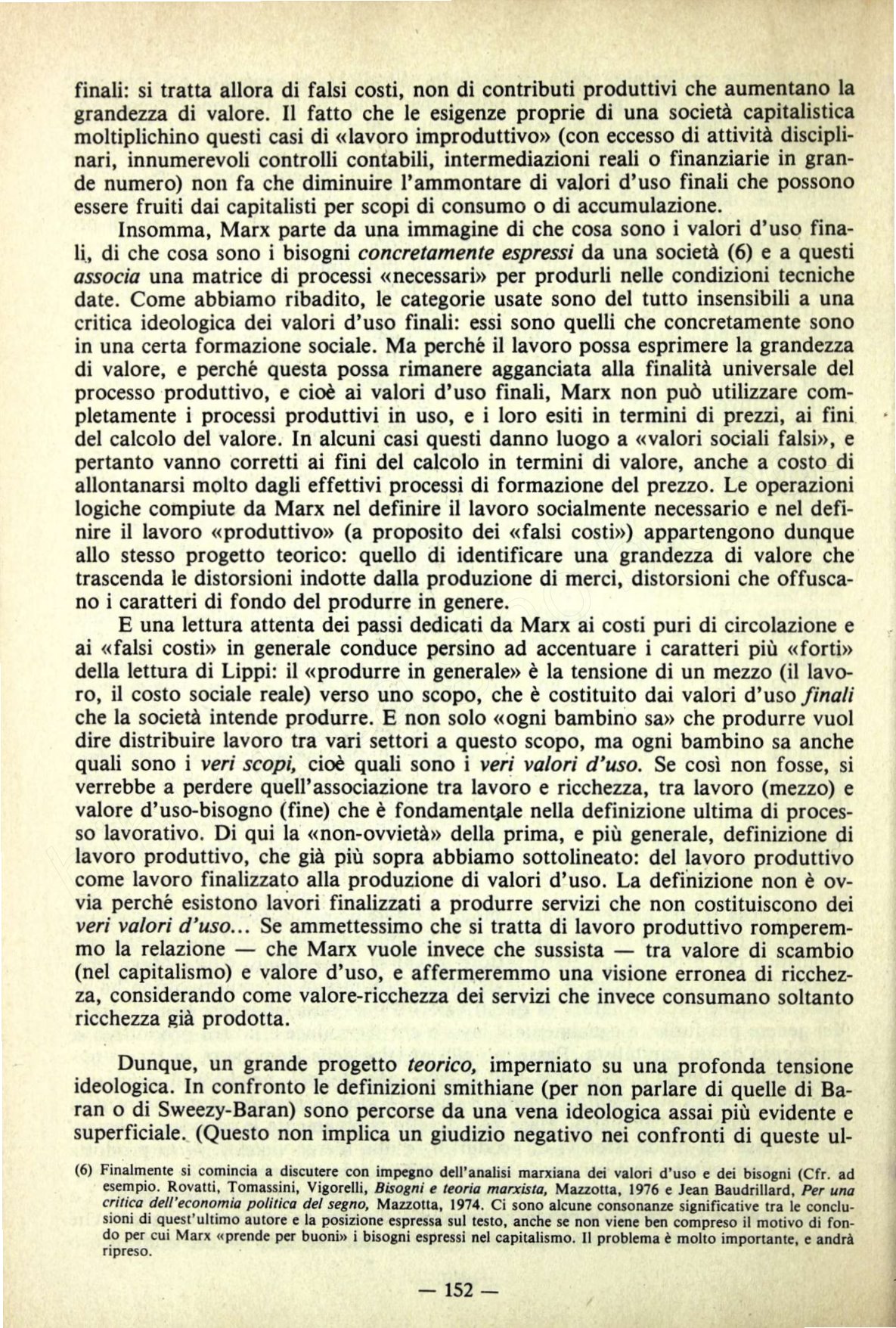
finali: si tratta allora di falsi costi, non di contributi produttivi che aumentano la
grandezza di valore. I l fatto che le esigenze proprie di una società capitalistica
moltiplichino questi casi di «lavoro improduttivo» (coneccessodi attività discipli-
nari, innumerevoli controlli contabili, intermediazioni reali o finanziarie in gran-
denumero) non fa che diminuire l'ammontare di valori d'uso finali che possono
essere fruiti dai capitalisti per scopi di consumo o di accumulazione.
Insomma, Marx parte da una immagine di checosasono i valori d'uso fina-
li, di che cosasono i bisogni
concretamenteespressi
da una società (6) e a questi
associa
una matrice di processi «necessari» per produrli nelle condizioni tecniche
date. Come abbiamo ribadito, le categorie usate sono del tutto insensibili a una
critica ideologica dei valori d'uso finali: essi sono quelli che concretamente sono
in una certa formazione sociale. Ma perché il lavoropossaesprimere la grandezza
di valore, e perché questa possa rimanere agganciata alla finalità universale del
processoproduttivo, e cioè ai valori d'uso finali, Marx non può utilizzare com-
pletamente i processi produttivi in uso, e i loro esiti in termini di prezzi, ai fini
del calcolo del valore. In alcuni casi questi danno luogo a «valori sociali falsi», e
pertanto vanno corretti ai fini del calcolo in termini di valore, anche a costo di
allontanarsi molto dagli effettivi processi di formazione del prezzo. Le operazioni
logichecompiute da Marx nel definire il lavoro socialmentenecessario e nel defi-
nire il lavoro «produttivo» (a proposito dei «falsi costi») appartengono dunque
allostesso progetto teorico: quello di identificare una grandezza di valore che
trascenda le distorsioni indotte dalla produzione di merci, distorsioni che offusca-
no i caratteri di fondo del produrre in genere.
Euna lettura attenta dei passi dedicati da Marx ai costi puri di circolazione e
ai «falsi costi» in generale conduce persino ad accentuare i caratteri più «forti»
della lettura di Lippi: il «produrre in generale» è la tensione di unmezzo (il lavo-
ro, il costo sociale reale) verso uno scopo, che è costituito dai valori d'uso
finali
che la società intende produrre. E non solo «ogni bambino sa» che produrre vuol
dire distribuire lavoro tra vari settori a questoscopo, ma ogni bambino sa anche
quali sono i
veri scopi,
cioè quali sono i
veri valori d'uso.
Se così non fosse, si
verrebbe a perdere quell'associazione tra lavoro e ricchezza, tra lavoro (mezzo) e
valore d'uso-bisogno (fine) che è fondamentftle nella definizione ultima di proces-
solavorativo. Di qui la «non-ovvietà» della prima, e più generale, definizione di
lavoro produttivo, che già più sopra abbiamo sottolineato: del lavoro produttivo
come lavoro finalizzato alla produzione di valori d'uso. La definizione non è ov-
viaperché esistono lavori finalizzati a produrre servizi che non costituiscono dei
veri valori d'uso...
Se ammettessimoche si tratta di lavoro produttivo romperem-
mo la relazione — che Marx vuole invece che sussista — tra valore di scambio
(nel capitalismo) e valore d'uso, e affermeremmo una visione erronea di ricchez-
za, considerandocome valore-ricchezza dei servizi che invececonsumano soltanto
ricchezzagià prodotta.
Dunque, un grande progetto
teorico,
imperniato su una profonda tensione
ideologica. In confronto le definizioni smithiane (per non parlare di quelle di Ba-
ran o di Sweezy-Baran) sonopercorse da una vena ideologica assai più evidente e
superficiale. (Questo non implica un giudizio negativo nei confronti di queste ul-
(6) Finalmente si comincia a discutere con impegno dell'analisi marxiana dei valori d'uso e dei bisogni (Cfr. ad
esempio. Rovatti, Tomassini, Vigorelli,
Bisogni
e
teoria marxista,
Mazzotta, 1976 e Jean Baudrillard,
Per una
critica dell'economia politica del segno,
Mazzotta, 1974. Ci sono alcune consonanze significative tra le conclu-
sioni di quest'ultimo autore e la posizione espressa sul testo, anche se non viene ben compreso il motivo di fon-
do per cui Marx «prende per buoni)) i bisogni espressi nel capitalismo. I l problema è molto importante, e andrà
ripreso.
—152
















