
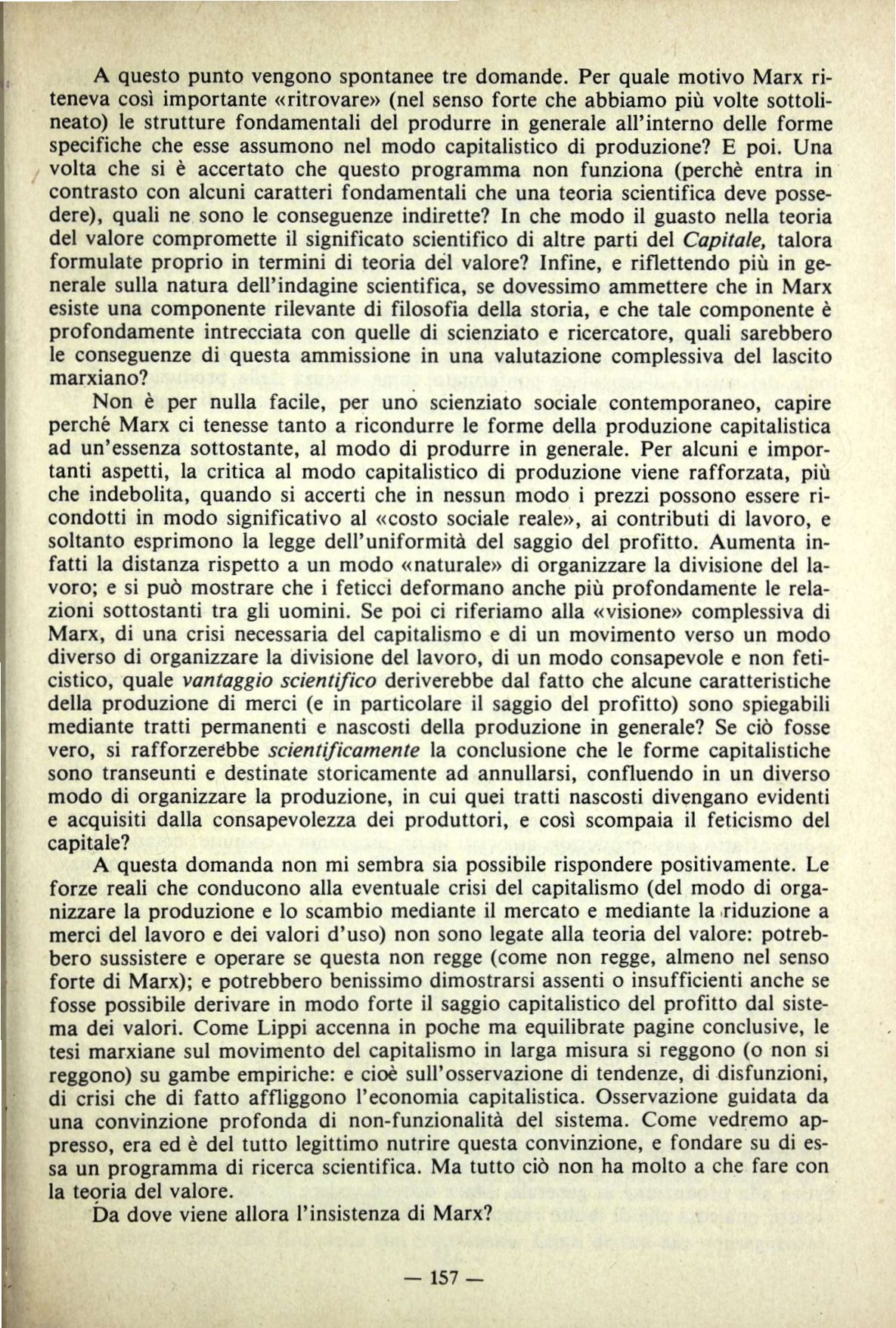
A questo punto vengono spontanee tre domande. Per quale motivo Marx ri-
teneva così importante «ritrovare» (nel senso forte che abbiamo più volte sottoli-
neato) le strutture fondamentali del produrre in generale all'interno delle forme
specifiche che esse assumono nel modo capitalistico di produzione? E poi. Una
volta che si è accertato che questo programma non funziona (perché entra in
contrasto con alcuni caratteri fondamentali che una teoria scientifica deve posse-
dere), quali ne sono le conseguenze indirette? In che modo il guasto nella teoria
del valore compromette il significato scientifico di altre parti del
Capitale,
talora
formulate proprio in termini di teoria dél valore? Infine, e riflettendo più in ge-
nerale sulla natura dell'indagine scientifica, se dovessimo ammettere che in Marx
esiste una componente rilevante di filosofia della storia, e che tale componente è
profondamente intrecciata con quelle di scienziato e ricercatore, quali sarebbero
leconseguenze di questa ammissione in una valutazione complessiva del lascito
marxiano?
Non è per nulla facile, per unò scienziato sociale contemporaneo, capire
perché Marx ci tenesse tanto a ricondurre le forme della produzione capitalistica
ad un'essenza sottostante, al modo di produrre in generale. Per alcuni e impor-
tanti aspetti, la critica al modo capitalistico di produzione viene rafforzata, più
che indebolita, quando si accerti che in nessun modo i prezzi possono essere ri-
condotti in modo significativo al «costo sociale reale», ai contributi di lavoro, e
soltanto esprimono la legge dell'uniformità del saggio del profitto. Aumenta in-
fatti la distanza rispetto a un modo «naturale» di organizzare la divisione del la-
voro; e si può mostrare che i feticci deformano anche più profondamente le rela-
zioni sottostanti tra gli uomini. Se poi ci riferiamo alla «visione» complessiva di
Marx, di una crisi necessaria del capitalismo e di un movimento verso un modo
diverso di organizzare la divisione del lavoro, di un modo consapevole e non feti-
cistico, quale
vantaggio scientifico
deriverebbe dal fatto che alcune caratteristiche
della produzione di merci (e in particolare il saggio del profitto) sono spiegabili
mediante tratti permanenti e nascosti della produzione in generale? Se ciò fosse
vero, si rafforzerebbe
scientificamente
la conclusione che le forme capitalistiche
sono transeunti e destinate storicamente ad annullarsi, confluendo in un diverso
modo di organizzare la produzione, in cui quei tratti nascosti divengano evidenti
eacquisiti dalla consapevolezza dei produttori, e così scompaia il feticismo del
capitale?
A questa domanda non mi sembra sia possibile rispondere positivamente. Le
forze reali che conducono alla eventuale crisi del capitalismo (del modo di orga-
nizzare la produzione e lo scambio mediante il mercato e mediante la riduzione a
merci del lavoro e dei valori d'uso) non sono legate alla teoria del valore: potreb-
berosussistere e operare se questa non regge (come non regge, almeno nel senso
forte di Marx); e potrebbero benissimo dimostrarsi assenti o insufficienti anche se
fossepossibile derivare in modo forte il saggio capitalistico del profitto dal siste-
ma dei valori. Come Lippi accenna in poche ma equilibrate pagine conclusive, le
tesi marxiane sul movimento del capitalismo in larga misura si reggono (o non si
reggono) su gambe empiriche: e cioè sull'osservazione di tendenze, di disfunzioni,
di crisi che di fatto affliggono l'economia capitalistica. Osservazione guidata da
una convinzione profonda di non-funzionalità del sistema. Come vedremo ap-
presso, era ed è del tutto legittimo nutrire questa convinzione, e fondare su di es-
saun programma di ricerca scientifica. Ma tutto ciò non ha molto a che fare con
la tegria del valore.
Da dove viene allora l'insistenza di Marx?
















