
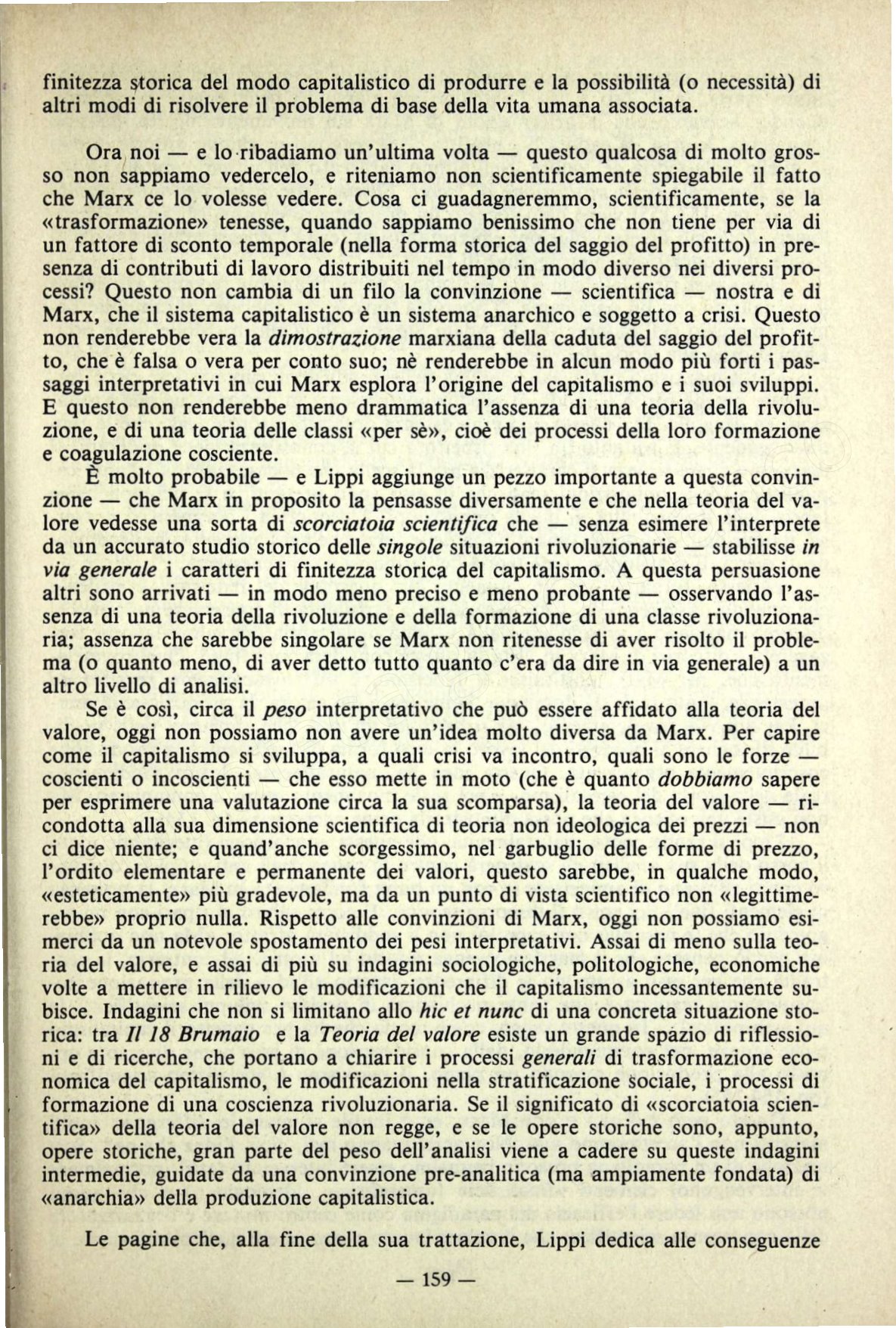
finitezza storica del modo capitalistico di produrre e la possibilità (o necessità) di
altri modi di risolvere il problema di base della vita umana associata.
Ora noi — e lo .ribadiamo un'ultima volta — questo qualcosa di molto gros-
sonon sappiamo vedercelo, e riteniamo non scientificamente spiegabile il fatto
che Marx ce lo volesse vedere. Cosa ci guadagneremmo, scientificamente, se la
«trasformazione» tenesse, quando sappiamo benissimo che non tiene per via di
un fattore di sconto temporale (nella forma storica del saggio del profitto) in pre-
senza di contributi di lavoro distribuiti nel tempo in modo diverso nei diversi pro-
cessi?Questo non cambia di un filo la convinzione — scientifica — nostra e di
Marx, che il sistema capitalistico è un sistema anarchico e soggetto a crisi. Questo
non renderebbe vera la
dimostrazione
marxiana della caduta del saggio del profit-
to, che è falsa o vera per conto suo; nè renderebbe in alcun modo più forti i pas-
saggi interpretativi in cui Marx esplora l'origine del capitalismo e i suoi sviluppi.
E questo non renderebbe meno drammatica l'assenza di una teoria della rivolu-
zione, e di una teoria delle classi «per sè», cioè dei processi della loro formazione
ecoagulazione cosciente.
E molto probabile — e Lippi aggiunge un pezzo importante a questa convin-
zione — che Marx in proposito la pensassediversamente e che nella teoria del va-
lore vedesse una sorta di
scorciatoia scientifica
che - - senza esimere l'interprete
da un accurato studio storico delle
singole
situazioni rivoluzionarie — stabilisse
in
via generale
i caratteri di finitezza storica del capitalismo. A questa persuasione
altri sono arrivati — in modo meno preciso e meno probante — osservando l'as-
senza di una teoria della rivoluzione e della formazione di una classe rivoluziona-
ria; assenza che sarebbe singolare se Marx non ritenesse di aver risolto il proble-
ma (o quanto meno, di aver detto tutto quanto c'era da dire in via generale) a un
altro livello di analisi.
Se è così, circa il
peso
interpretativo che può essere affidato alla teoria del
valore, oggi non possiamo non avere un'idea molto diversa da Marx. Per capire
come il capitalismo si sviluppa, a quali crisi va incontro, quali sono le forze —
coscienti o incoscienti — che essomette in moto (che è quanto
dobbiamo
sapere
per esprimere una valutazione circa la sua scomparsa), la teoria del valore — ri-
condotta alla sua dimensione scientifica di teoria non Ideologica dei prezzi — non
ci dice niente; e quand'anche scorgessimo, nel garbuglio delle forme di prezzo,
l'ordito elementare e permanente dei valori, questo sarebbe, in qualche modo,
«esteticamente» più gradevole, ma da un punto di vista scientifico non «legittime-
rebbe» proprio nulla. Rispetto alle convinzioni di Marx, oggi non possiamo esi-
merci da un notevole spostamento dei pesi interpretativi. Assai di meno sulla teo-
ria del valore, e assai di più su indagini sociologiche, politologiche, economiche
volte a mettere in rilievo le modificazioni che il capitalismo incessantemente su-
bisce. Indagini che non si limitano allo
hic et nunc
di una concreta situazione sto-
rica: tra
11 18 Brumaio
e
la Teoria del valore
esiste un grande spazio di riflessio-
ni e di ricerche, che portano a chiarire i processi
generali
di trasformazione eco-
nomica del capitalismo, le modificazioni nella stratificazione sociale, i processi di
formazione di una coscienza rivoluzionaria. Se il significato di «scorciatoia scien-
tifica» della teoria del valore non regge, e se le opere storiche sono, appunto,
opere storiche, gran parte del peso dell'analisi viene a cadere su queste indagini
intermedie, guidate da una convinzione pre-analitica (ma ampiamente fondata) di
«anarchia» della produzione capitalistica.
Le pagine che, alla fine della sua trattazione, Lippi dedica alle conseguenze
















