
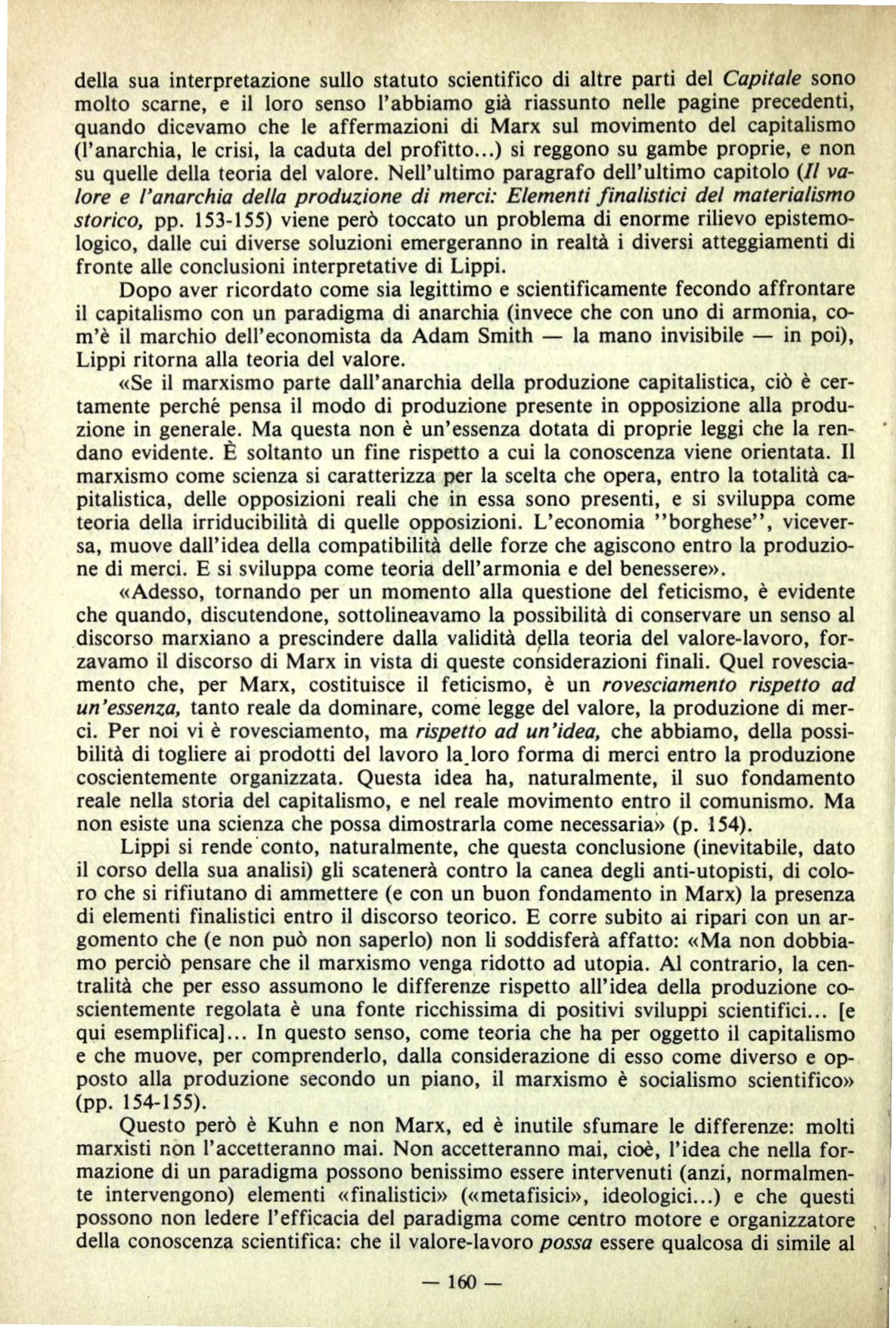
della sua interpretazione sullo statuto scientifico di altre parti del
Capitale
sono
molto scarne, e i l loro senso l'abbiamo già riassunto nelle pagine precedenti,
quandodicevamo che le affermazioni di Marx sul movimento del capitalismo
(l'anarchia, le crisi, la caduta del profitto...) si reggono sugambe proprie, e non
suquelle della teoria del valore. Nell'ultimo paragrafo dell'ultimo capitolo
(Il va-
lore e l'anarchia della produzione di merci: Elementi finalistici del materialismo
storico,
pp. 153-155) viene però toccato un problema di enorme rilievo epistemo-
logico, dalle cui diverse soluzioni emergeranno in realtà i diversi atteggiamenti di
fronte alle conclusioni interpretative di Lippi.
Dopo aver ricordato come sia legittimo e scientificamente fecondo affrontare
il capitalismo con un paradigma di anarchia (invece che con uno di armonia, co-
m'è il marchio dell'economista da Adam Smith — la mano invisibile — in poi),
Lippi ritorna alla teoria del valore.
«Se il marxismo parte dall'anarchia della produzione capitalistica, ciò è cer-
tamenteperchépensa il modo di produzione presente in opposizione alla produ-
zione in generale. Ma questa non è un'essenza dotata di proprie leggi che la ren-
danoevidente. È soltanto un fine rispetto a cui la conoscenza viene orientata. I l
marxismocomescienza si caratterizza per la sceltache opera, entro la totalità ca-
pitalistica, delle opposizioni reali che in essa sono presenti, e si sviluppa come
teoria della irriducibilità di quelle opposizioni. L'economia "borghese", vicever-
sa,muove dall'idea della compatibilità delle forze cheagiscono entro la produzio-
nedi merci. E si sviluppa come teoria dell'armonia e del benessere».
«Adesso, tornando per un momento alla questione del feticismo, è evidente
chequando, discutendone, sottolineavamo la possibilità di conservare un senso al
discorsomarxiano a prescindere dalla validità della teoria del valore-lavoro, for-
zavamo il discorso di Marx in vista di questeconsiderazioni finali. Quel rovescia-
mento che, per Marx, costituisce i l feticismo, è un
rovesciamento rispetto ad
un'essenza,
tanto reale da dominare, come legge del valore, la produzione di mer-
ci. Per noi vi è rovesciamento, ma
rispetto ad un'idea,
che abbiamo, della possi-
bilità di togliere ai prodotti del lavoro la loro forma di merci entro la produzione
coscientementeorganizzata. Questa idea ha, naturalmente, i l suo fondamento
reale nella storia del capitalismo, e nel reale movimento entro il comunismo. Ma
nonesiste una scienzachepossadimostrarla comenecessaria» (p. 154).
Lippi si rende conto, naturalmente, che questaconclusione (inevitabile, dato
il corso della sua analisi) gli scatenerà contro la canea degli anti-utopisti, di colo-
roche si rifiutano di ammettere (e con un buon fondamento in Marx) la presenza
di elementi finalistici entro il discorso teorico. E corre subito ai ripari con un ar-
gomentoche (e non può non saperlo) non li soddisferà affatto: «Ma non dobbia-
moperciòpensare che il marxismo venga ridotto ad utopia. Al contrario, la cen-
tralità che per essoassumono le differenze rispetto all'idea della produzione co-
scientemente regolata è una fonte ricchissima di positivi sviluppi scientifici... [e
qui esemplifica]... In questosenso, come teoria che ha per oggetto il capitalismo
echemuove, per comprenderlo, dalla considerazione di essocome diverso e op-
posto alla produzione secondo un piano, i l marxismo è socialismo scientifico»
(pp. 154-155).
Questoperò è Kuhn e non Marx, ed è inutile sfumare le differenze: molti
marxisti non l'accetteranno mai. Non accetterannomai, cioè, l'idea che nella for-
mazione di un paradigmapossonobenissimoessere intervenuti (anzi, normalmen-
te intervengono) elementi «finalistici» («metafisici», ideologici...) e che questi
possononon ledere l'efficacia del paradigma come centromotore e organizzatore
dellaconoscenzascientifica: che il valore-lavoro
possa
esserequalcosa di simile al
1 6 0 -
è
















