
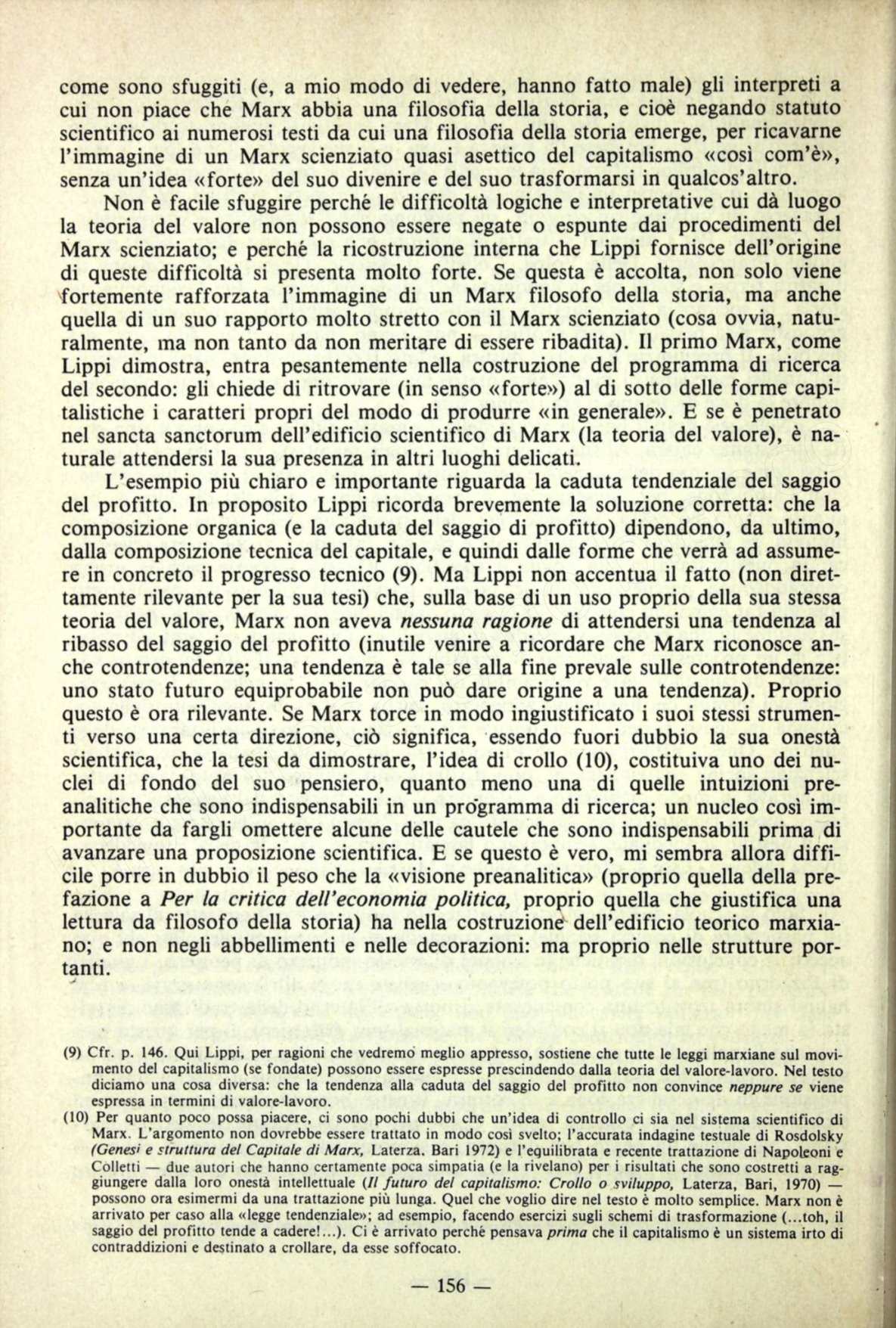
come sono sfuggiti (e, a mio modo di vedere, hanno fatto male) gli interpreti a
cui non piace che Marx abbia una filosofia della storia, e cioè negando statuto
scientifico ai numerosi testi da cui una filosofia della storia emerge, per ricavarne
l'immagine di un Marx scienziato quasi asettico del capitalismo «così com'è»,
senza un'idea «forte» del suo divenire e del suo trasformarsi in qualcos'altro.
Non è facile sfuggire perché le difficoltà logiche e interpretative cui dà luogo
la teoria del valore non possono essere negate o espunte dai procedimenti del
Marx scienziato; e perché la ricostruzione interna che Lippi fornisce dell'origine
di queste difficoltà si presenta molto forte. Se questa è accolta, non solo viene
fortemente rafforzata l'immagine di un Marx filosofo della storia, ma anche
quella di un suo rapporto molto stretto con il Marx scienziato (cosa ovvia, natu-
ralmente, ma non tanto da non meritare di essere ribadita). I l primo Marx, come
Lippi dimostra, entra pesantemente nella costruzione del programma di ricerca
del secondo: gli chiede di ritrovare (in senso «forte») al di sotto delle forme capi-
talistiche i caratteri propri del modo di produrre «in generale». E se è penetrato
nel sancta sanctorum dell'edificio scientifico di Marx (la teoria del valore), è na-
turale attendersi la sua presenza in altri luoghi delicati.
L'esempio più chiaro e importante riguarda la caduta tendenziale del saggio
del profitto. In proposito Lippi ricorda brevemente la soluzione corretta: che la
composizione organica (e la caduta del saggio di profitto) dipendono, da ultimo,
dalla composizione tecnica del capitale, e quindi dalle forme che verrà ad assume-
re in concreto il progresso tecnico (9). Ma Lippi non accentua il fatto (non diret-
tamente rilevante per la sua tesi) che, sulla base di un uso proprio della sua stessa
teoria del valore, Marx non aveva
nessuna ragione
di attendersi una tendenza al
ribasso del saggio del profitto (inutile venire a ricordare che Marx riconosce an-
checontrotendenze; una tendenza è tale se alla fine prevale sulle controtendenze:
uno stato futuro equiprobabile non può dare origine a una tendenza). Proprio
questo è ora rilevante. Se Marx torce in modo ingiustificato i suoi stessi strumen-
ti verso una certa direzione, ciò significa, essendo fuori dubbio la sua onestà
scientifica, che la tesi da dimostrare, l'idea di crollo (10), costituiva uno dei nu-
clei d i fondo del suo pensiero, quanto meno una d i quelle intuizioni pre-
analitiche che sono indispensabili in un pro-gramma di ricerca; un nucleo così im-
portante da fargli omettere alcune delle cautele che sono indispensabili prima di
avanzare una proposizione scientifica. E se questo è vero, mi sembra allora diffi-
cile porre in dubbio il peso che la «visione preanalitica» (proprio quella della pre-
fazione a
Per la critica dell'economia politica,
proprio quella che giustifica una
lettura da filosofo della storia) ha nella costruzione dell'edificio teorico marxia-
no; e non negli abbellimenti e nelle decorazioni: ma proprio nelle strutture por-
tanti.
(9) Cfr. p. 146. Qui Lippi, per ragioni che vedremci meglio appresso, sostiene che tutte le leggi marxiane sul movi-
mento del capitalismo (se fondate) possonoessereespresseprescindendo dalla teoria del valore-lavoro. Nel testo
diciamo una cosa diversa: che la tendenza alla caduta del saggio del profitto non convince
neppure se
viene
espressa in termini di valore-lavoro.
(10) Per quanto poco possa piacere, ci sono pochi dubbi che un'idea di controllo ci sia nel sistema scientifico di
Marx. L'argomento non dovrebbe essere trattato in modo così svelto; l'accurata indagine testuale di Rosdolsky
(Genesi
e
struttura del Capitale di Marx,
Laterza. Bari 1972) e l'equilibrata e recente trattazione di Napoleoni e
Colletti — due autori che hanno certamente poca simpatia (e la rivelano) per i risultati che sono costretti a rag-
giungere dalla loro onestà intellettuale
( I l futuro del capitalismo: Crollo
o
sviluppo,
Laterza, Bari, 1970)
possono ora esimermi da una trattazione più lunga. Quel che voglio dire nel testo è molto semplice. Marx non è
arrivato per caso alla «legge tendenziale»; ad esempio, facendo esercizi sugli schemi di trasformazione (...toh, il
saggiodel profitto tende a cadere!...). Ci è arrivato perché pensava
prima
che il capitalismo è un sistema irto di
contraddizioni e destinato a crollare, da esse soffocato.
156
















