
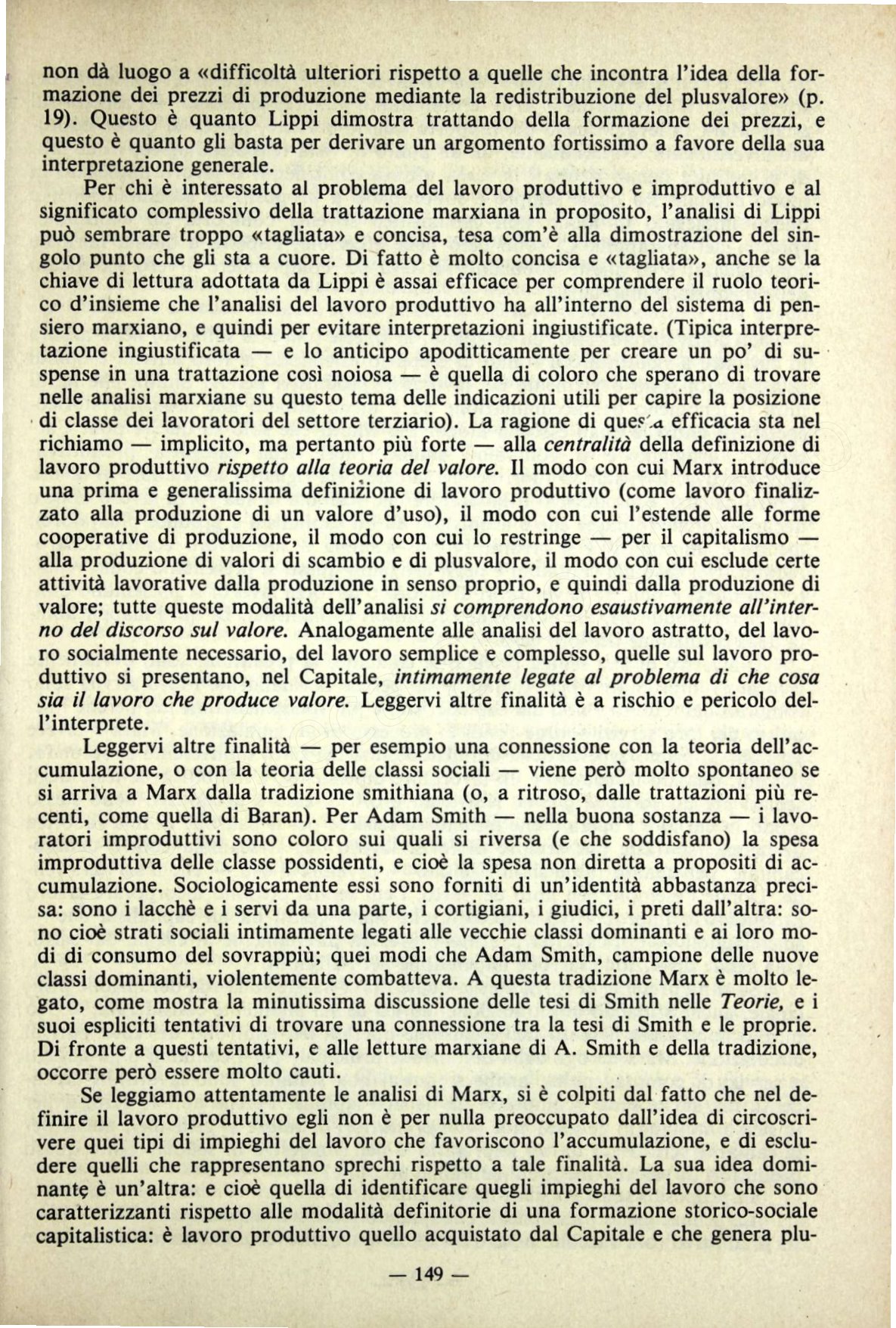
non dà luogo a «difficoltà ulteriori rispetto a quelle che incontra l'idea della for-
mazione dei prezzi di produzione mediante la redistribuzione del plusvalore» (p.
19). Questo è quanto Lippi dimostra trattando della formazione dei prezzi, e
questoè quanto gli basta per derivare un argomento fortissimo a favore della sua
interpretazione generale.
Per chi è interessato al problema del lavoro produttivo e improduttivo e al
significatocomplessivo della trattazione marxiana in proposito, l'analisi di Lippi
puòsembrare troppo «tagliata» e concisa, tesa com'è alla dimostrazione del sin-
golo punto che gli sta a cuore. Di fatto è molto concisa e «tagliata», anche se la
chiave di lettura adottata da Lippi è assai efficace per comprendere il ruolo teori-
cod'insieme che l'analisi del lavoro produttivo ha all'interno del sistema di pen-
sieromarxiano, e quindi per evitare interpretazioni ingiustificate. (Tipica interpre-
tazione ingiustificata — e lo anticipo apoditticamente per creare un po' di su-
spense in una trattazione così noiosa — è quella di coloro che sperano di trovare
nelle analisi marxiane suquesto tema delle indicazioni utili per capire la posizione
di classe dei lavoratori del settore terziario). La ragione di queF'.4 efficacia sta nel
richiamo — implicito, ma pertanto più forte — alla
centralità
della definizione di
lavoro produttivo
rispetto alla teoria del valore.
I l modo con cui Marx introduce
una prima e generalissima definffione di lavoro produttivo (come lavoro finaliz-
zato alla produzione di un valore d'uso), i l modo con cui l'estende alle forme
cooperative di produzione, il modo con cui lo restringe — per il capitalismo
alla produzione di valori di scambio e di plusvalore, il modo con cui escludecerte
attività lavorative dalla produzione in sensoproprio, e quindi dalla produzione di
valore; tutte questemodalità dell'analisi
si comprendonoesaustivamente all'inter-
no del discorso sul valore.
Analogamente alle analisi del lavoro astratto, del lavo-
ro socialmentenecessario, del lavoro semplice e complesso, quelle sul lavoro pro-
duttivo si presentano, nel Capitale, intimamente legate al problema di che cosa
sia il lavoro che produce valore.
Leggervi altre finalità è a rischio e pericolo del-
l'interprete.
Leggervi altre finalità — per esempio una connessione con la teoria dell'ac-
cumulazione, o con la teoria delle classi sociali — viene però molto spontaneose
si arriva a Marx dalla tradizione smithiana (o, a ritroso, dalle trattazioni più re-
centi, come quella di Baran). Per Adam Smith — nella buona sostanza— i lavo-
ratori improduttivi sono coloro sui quali si riversa (e che soddisfano) la spesa
improduttiva delle classepossidenti, e cioè la spesa non diretta a propositi di ac-
cumulazione. Sociologicamente essi sono forniti di un'identità abbastanza preci-
sa:sono i lacchè e i servi da una parte, i cortigiani, i giudici, i preti dall'altra: so-
nocioè strati sociali intimamente legati alle vecchieclassi dominanti e ai loro mo-
di di consumo del sovrappiù; quei modi che Adam Smith, campione delle nuove
classi dominanti, violentemente combatteva. A questa tradizione Marx è molto le-
gato, come mostra la minutissimadiscussione delle tesi di Smith nelle
Teorie,
e i
suoi espliciti tentativi di trovare una connessione tra la tesi di Smith e le proprie.
Di fronte a questi tentativi, e alle letture marxiane di A. Smith e della tradizione,
occorreperòesseremolto cauti.
Seleggiamo attentamente le analisi di Marx, si è colpiti dal fatto che nel de-
finire il lavoro produttivo egli non è per nulla preoccupato dall'idea di circoscri-
vere quei tipi di impieghi del lavoro che favoriscono l'accumulazione, e di esclu-
dere quelli che rappresentano sprechi rispetto a tale finalità. La sua idea domi-
nante è un'altra: e cioè quella di identificare quegli impieghi del lavoro che sono
caratterizzanti rispetto alle modalità definitorie di una formazione storico-sociale
capitalistica: è lavoro produttivo quello acquistato dal Capitale e che genera plu-
149
















