
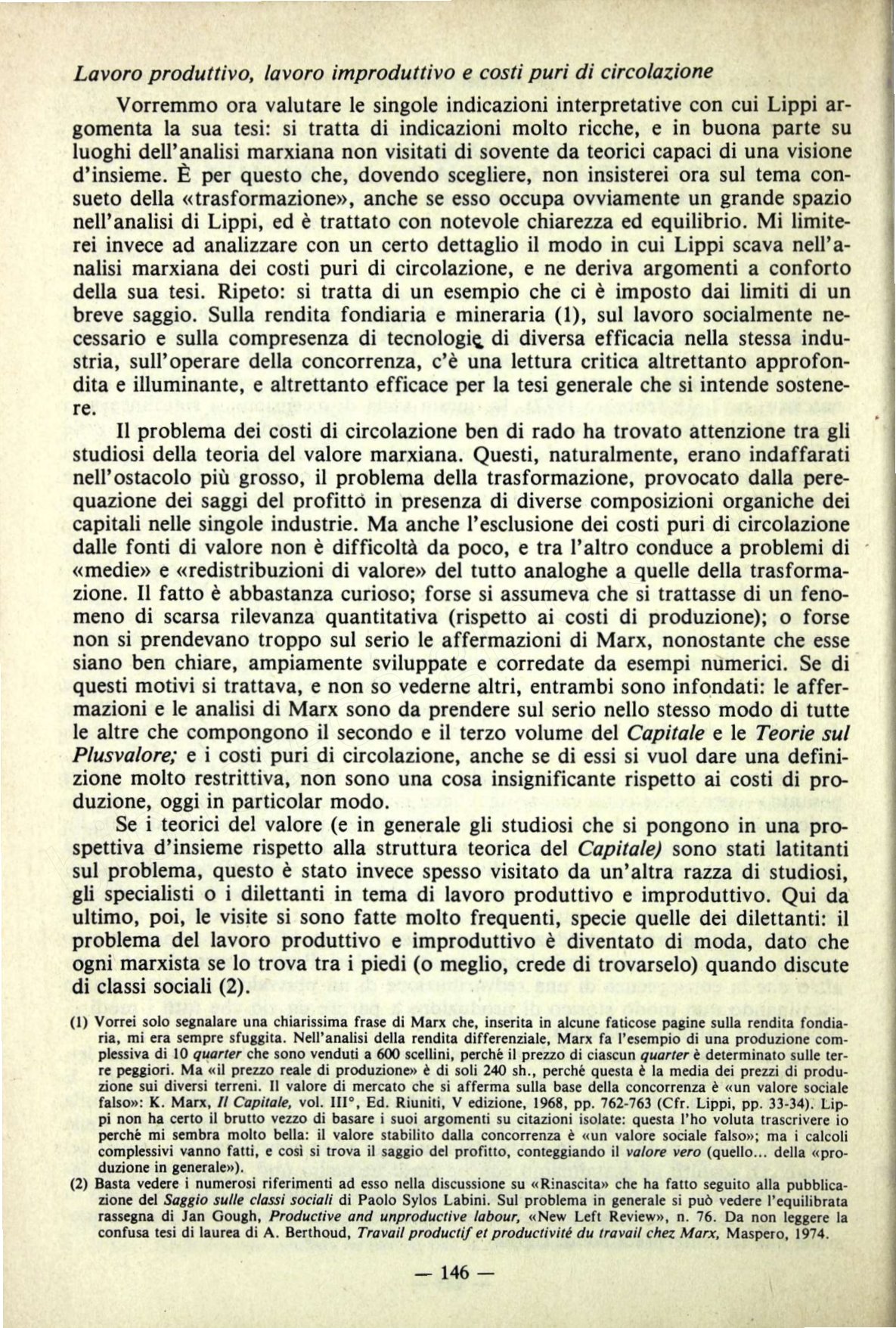
Lavoro produttivo, lavoro improduttivo e costi puri di circolazione
Vorremmo ora valutare le singole indicazioni interpretative con cui Lippi ar-
gomenta la sua tesi: si tratta di indicazioni molto ricche, e in buona parte su
luoghi dell'analisi marxiana non visitati di sovente da teorici capaci di una visione
d'insieme. È per questo che, dovendo scegliere, non insisterei ora sul tema con-
suetodella «trasformazione», anche seessooccupa ovviamente un grande spazio
nell'analisi di Lippi, ed è trattato con notevole chiarezza ed equilibrio. Mi limite-
rei invece ad analizzare con un certo dettaglio il modo in cui Lippi scava nell'a-
nalisi marxiana dei costi puri di circolazione, e ne deriva argomenti a conforto
della sua tesi. Ripeto: si tratta di un esempio che ci è imposto dai limiti di un
brevesaggio. Sulla rendita fondiaria e mineraria (1), sul lavoro socialmente ne-
cessario e sulla compresenza di tecnologie, di diversa efficacia nella stessa indu-
stria, sull'operare della concorrenza, c'è una lettura critica altrettanto approfon-
dita e illuminante, e altrettanto efficace per la tesi generale che si intendesostene-
re.
Il problema dei costi di circolazione ben di rado ha trovato attenzione tra gli
studiosi della teoria del valore marxiana. Questi, naturalmente, erano indaffarati
nell'ostacolo più grosso, il problema della trasformazione, provocato dalla pere-
quazione dei saggi del profittò in presenza di diverse composizioni organiche dei
capitali nelle singole industrie. Ma anche l'esclusione dei costi puri di circolazione
dalle fonti di valore non è difficoltà da poco, e tra l'altro conduce a problemi di
«medie» e «redistribuzioni di valore» del tutto analoghe a quelle della trasforma-
zione. I l fatto è abbastanza curioso; forse si assumevache si trattasse di un feno-
meno di scarsa rilevanza quantitativa (rispetto ai costi di produzione); o forse
nonsi prendevano troppo sul serio le affermazioni di Marx, nonostante cheesse
sianoben chiare, ampiamente sviluppate e corredate da esempi numerici. Se di
questi motivi si trattava, e non sovederne altri, entrambi sono infondati: le affer-
mazioni e le analisi di Marx sono da prendere sul serio nellostessomodo di tutte
le altre che compongono il secondo e il terzo volume del
Capitale
e
le Teorie sul
Plusvalore;
e i costi puri di circolazione, anche se di essi si vuol dare una defini-
zionemolto restrittiva, non sono una cosa insignificante rispetto ai costi di pro-
duzione, oggi in particolar modo.
Se i teorici del valore (e in generale gli studiosi che si pongono in una pro-
spettiva d'insieme rispetto alla struttura teorica del
Capitale)
sono stati latitanti
sul problema, questo è stato invecespessovisitato da un'altra razza di studiosi,
gli specialisti o i dilettanti in tema di lavoro produttivo e improduttivo. Qui da
ultimo, poi, le visite si sono fatte molto frequenti, specie quelle dei dilettanti: il
problema del lavoro produttivo e improduttivo è diventato di moda, dato che
ognimarxistase lo trova tra i piedi (o meglio, crede di trovarselo) quando discute
di classi sociali (2).
(1) Vorrei solo segnalare una chiarissima frase di Marx che, inserita in alcune faticose pagine sulla rendita fondia-
ria, mi era sempre sfuggita. Nell'analisi della rendita differenziale, Marx fa l'esempio di una produzione com-
plessiva di 10
quarter
che sono venduti a 600 scellini, perché il prezzo di ciascun
quarter
è determinato sulle ter-
re peggiori. Ma «il prezzo reale di produzione» è di soli 240 sh., perché questa è la media dei prezzi di produ-
zione sui diversi terreni. I l valore di mercato che si afferma sulla base della concorrenza è «un valore sociale
falso»: K. Marx,
I l Capitale, vol. 111°,
Ed. Riuniti, V edizione, 1968, pp. 762-763 (Cfr. Lippi, pp. 33-34). Lip-
pi non ha certo il brutto vezzo di basare i suoi argomenti su citazioni isolate: questa l'ho voluta trascrivere io
perché mi sembra molto bella: i l valore stabilito dalla concorrenza è «un valore sociale falso»; ma i calcoli
complessivi vanno fatti, e così si trova il saggio del profitto, conteggiando il
valore vero
(quello... della «pro-
duzione in generale»).
(2) Basta vedere i numerosi riferimenti ad esso nella discussione su «Rinascita» che ha fatto seguito alla pubblica-
zione del
Saggio sulle classi sociali
di Paolo Sylos Labini. Sul problema in generale si può vedere l'equilibrata
rassegna di Jan Gough,
Productive and unproductive labour,
«New Left Review», n. 76. Da non leggere la
confusa tesi di laurea di A. Berthoud, Travail productif et productivité du travail chez Marx, Maspero, 1974.
















