
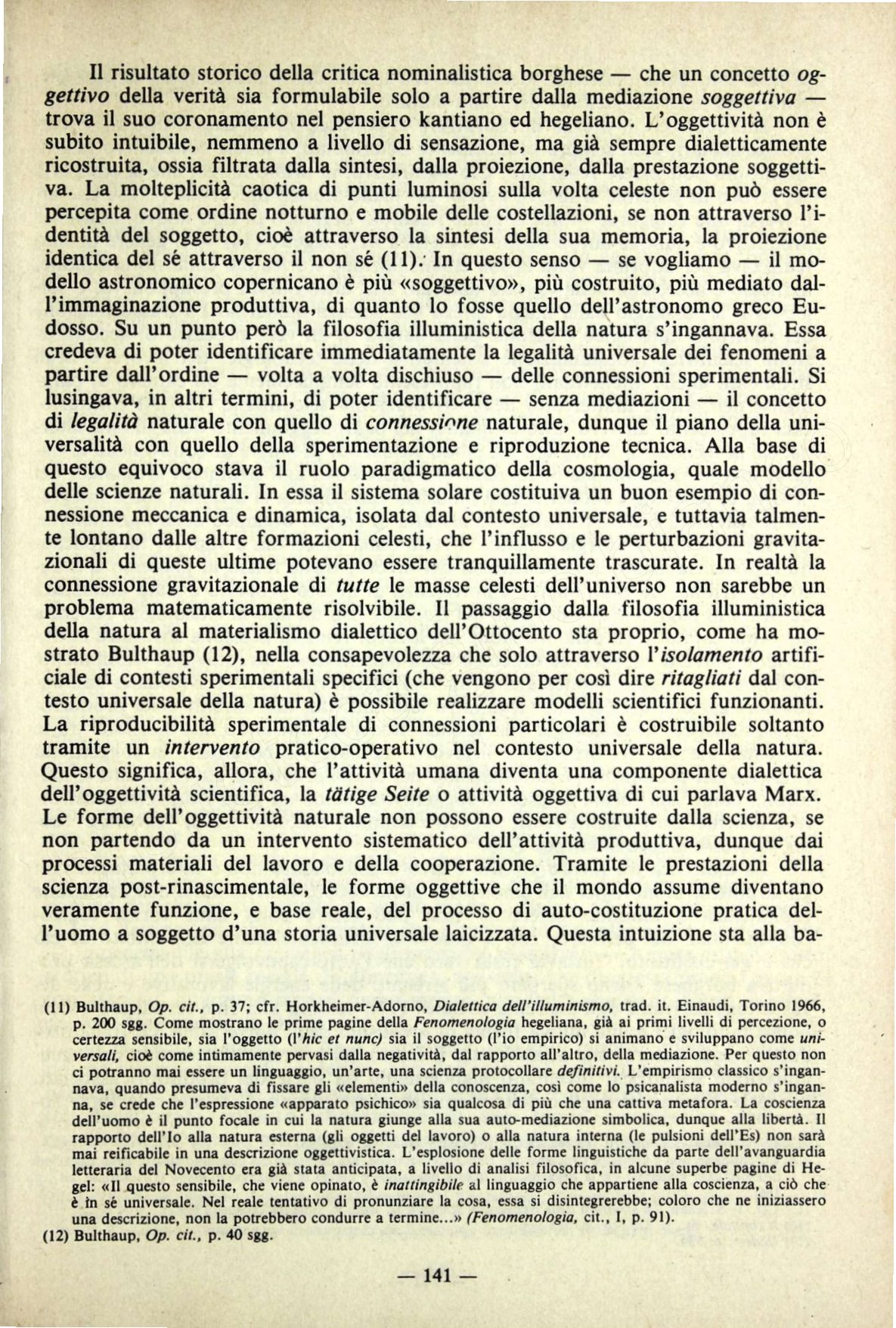
Il risultato storico della critica nominalisticaborghese c h e un concetto
og-
gettivo
della verità sia formulabile solo a partire dalla mediazione
soggettiva
trova il suo coronamento nel pensiero kantiano ed hegeliano. L'oggettività non è
subito intuibile, nemmeno a livello di sensazione, ma già sempre dialetticamente
ricostruita, ossia filtrata dalla sintesi, dalla proiezione, dalla prestazione soggetti-
va. La molteplicità caotica di punti luminosi sulla volta celeste non può essere
percepita come ordine notturno e mobile delle costellazioni, se non attraverso l'i-
dentità del soggetto, cioè attraverso la sintesi della sua memoria, la proiezione
identica del sé attraverso il non sé (11); In questosenso— se vogliamo — il mo-
dello astronomico copernicano è più «soggettivo», più costruito, più mediato dal-
l'immaginazione produttiva, di quanto lo fosse quello dell'astronomo greco Eu-
dosso. Su un punto però la filosofia illuministica della natura s'ingannava. Essa
credeva di poter identificare immediatamente la legalità universale dei fenomeni a
partire dall'ordine — volta a volta dischiuso — delle connessioni sperimentali. Si
lusingava, in altri termini, di poter identificare —senzamediazioni — il concetto
di
legalità
naturale con quello di
connessione
naturale, dunque il piano della uni-
versalità con quello della sperimentazione e riproduzione tecnica. Alla base di
questoequivoco stava i l ruolo paradigmatico della cosmologia, quale modello
dellescienze naturali. In essa il sistema solare costituiva un buon esempio di con-
nessionemeccanica e dinamica, isolata dal contestouniversale, e tuttavia talmen-
te lontano dalle altre formazioni celesti, che l'influsso e le perturbazioni gravita-
zionali di queste ultime potevano essere tranquillamente trascurate. In realtà la
connessionegravitazionale di
tutte
le massecelesti dell'universo non sarebbe un
problemamatematicamente risolvibile. I l passaggio dalla filosofia illuministica
della natura al materialismo dialettico dell'Ottocento sta proprio, come ha mo-
strato Bulthaup (12), nella consapevolezza che solo attraverso
l'isolamento
artifi-
ciale di contesti sperimentali specifici (chevengono per così dire
ritagliati
dal con-
testouniversale della natura) è possibile realizzare modelli scientifici funzionanti.
La riproducibilità sperimentale di connessioni particolari è costruibile soltanto
tramite un
intervento
pratico-operativo nel contesto universale della natura.
Questo significa, allora, che l'attività umana diventa una componente dialettica
dell'oggettività scientifica, la
Nage Seite
o attività oggettiva di cui parlava Marx.
Le forme dell'oggettività naturale non possonoessere costruite dalla scienza, se
non partendo da un intervento sistematico dell'attività produttiva, dunque dai
processi materiali del lavoro e della cooperazione. Tramite le prestazioni della
scienza post-rinascimentale, le forme oggettive che il mondo assume diventano
veramente funzione, e base reale, del processo di auto-costituzione pratica del-
l'uomo a soggetto d'una storia universale laicizzata. Questa intuizione sta alla ba-
(11) Bulthaup,
Op. cit.,
p. 37; cfr. Horkheimer-Adorno,
Dialettica dell'illuminismo,
trad. it. Einaudi, Torino 1966,
p. 200 sgg. Come mostrano le prime pagine della
Fenomenologia
hegeliana, già ai primi livelli di percezione, o
certezza sensibile, sia l'oggetto
(l'hic et nunc) sia
il soggetto (l'io empirico) si animano. e sviluppano come
uni
-
venali,
cioè come intimamente pervasi dalla negatività, dal rapporto all'altro, della mediazione. Per questo non
ci potranno mai essere un linguaggio, un'arte, una scienza protocollare
definitivi..
L'empirismo classico s'ingan-
nava, quando presumeva di fissare gli «elementi» della conoscenza, così come lo psicanalista moderno s'ingan-
na, se crede che l'espressione «apparato psichico» sia qualcosa di più che una cattiva metafora. La coscienza
dell'uomo è il punto focale in cui la natura giunge alla sua auto-mediazione simbolica, dunque alla libertà. I l
rapporto dell'Io alla natura esterna (gli oggetti del lavoro) o alla natura interna (le pulsioni dell'Es) non sarà
mai reificabile in una descrizione oggettivistica. L'esplosione delle forme linguistiche da parte dell'avanguardia
letteraria del Novecento era già stata anticipata, a livello di analisi filosofica, in alcune superbe pagine di He-
gel: «I l questo sensibile, che viene opinato, è
inattingibile
al linguaggio che appartiene alla coscienza, a ciò che
è la sé universale. Nel reale tentativo di pronunziare la cosa, essa si disintegrerebbe; coloro che ne iniziassero
una descrizione, non la potrebbero condurre a termine...»
(Fenomenologia, cit.,
I , p. 91).
(12) Bulthaup,
Op. cit.,
p. 40 sgg.
- 1 4 1
















