
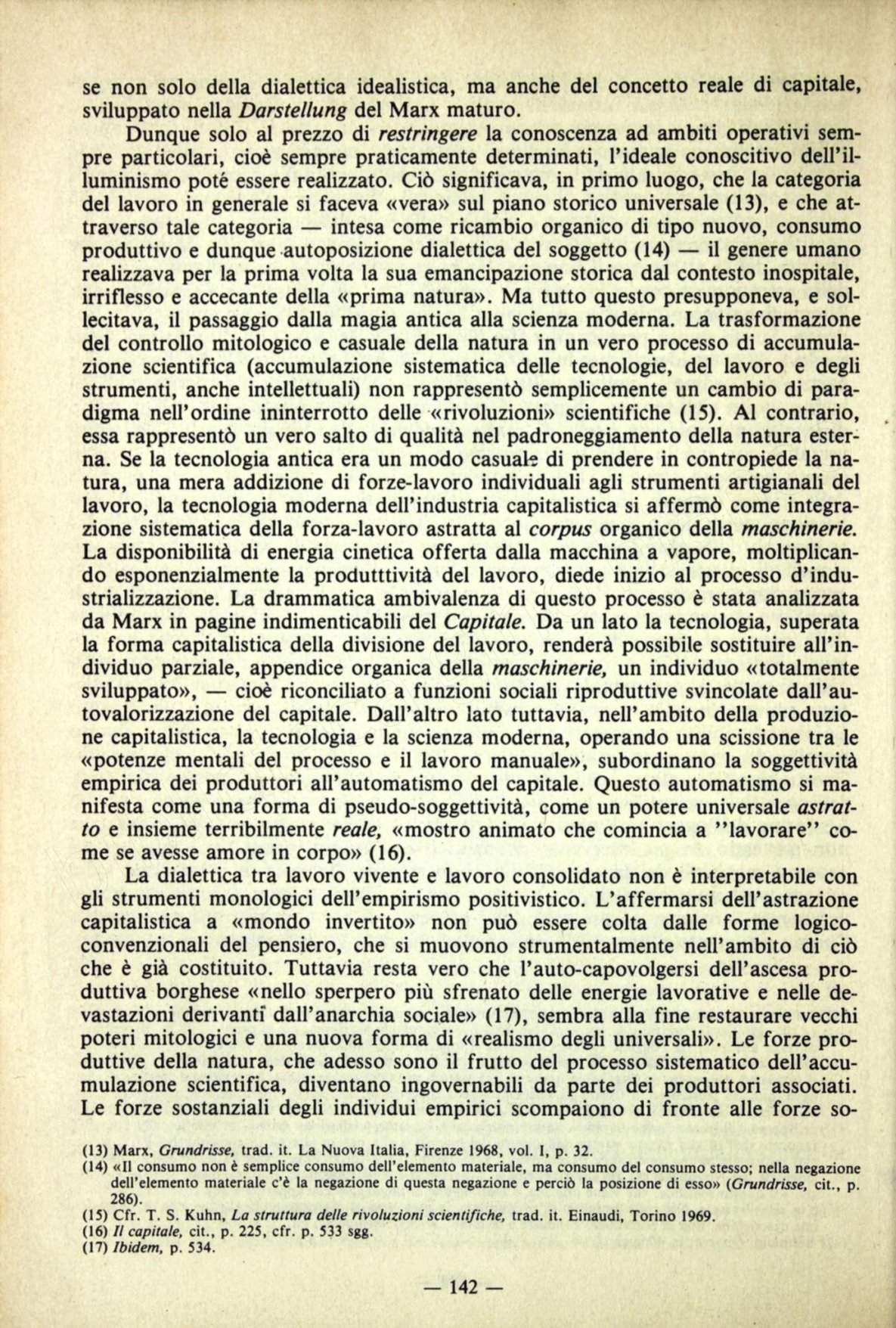
senon solo della dialettica idealistica, ma anche del concetto reale di capitale,
sviluppato nella
Darstellung
del Marx maturo.
Dunque solo al prezzo di
restringere
la conoscenza ad ambiti operativi sem-
pre particolari, cioè sempre praticamente determinati, l'ideale conoscitivo dell'il-
luminismopotéessere realizzato. Ciò significava, in primo luogo, che la categoria
del lavoro in generale si faceva «vera» sul piano storico universale (13), e che at-
traverso tale categoria — intesa come ricambio organico di tipo nuovo, consumo
produttivo e dunquesautoposizionedialettica del soggetto (14) — il genere umano
realizzava per la prima volta la sua emancipazione storica dal contesto inospitale,
irriflesso eaccecante della «prima natura». Ma tutto questopresupponeva, e sol-
lecitava, il passaggio dalla magia antica alla scienzamoderna. La trasformazione
del controllo mitologico e casuale della natura in un vero processo di accumula-
zione scientifica (accumulazione sistematica delle tecnologie, del lavoro e degli
strumenti, anche intellettuali) non rappresentòsemplicemente un cambio di para-
digma nell'ordine ininterrotto delle «rivoluzioni» scientifiche (15). Al contrario,
essarappresentò un vero salto di qualità nel padroneggiamento della natura ester-
na. Se la tecnologia antica era un modo casuale di prendere in contropiede la na-
tura, una mera addizione di forze-lavoro individuali agli strumenti artigianali del
lavoro, la tecnologiamoderna dell'industria capitalistica si affermò come integra-
zionesistematica della forza-lavoro astratta al
corpus
organico della
maschinerie.
La disponibilità di energia cinetica offerta dalla macchina a vapore, moltiplican-
doesponenzialmente la produtttività del lavoro, diede inizio al processo d'indu-
strializzazione. La drammatica ambivalenza di questoprocesso è stata analizzata
daMarx in pagine indimenticabili del
Capitale.
Da un lato la tecnologia, superata
la forma capitalistica della divisione del lavoro, renderà possibile sostituire all'in-
dividuo parziale, appendice organica della
maschinerie,
un individuo «totalmente
sviluppato», — cioè riconciliato a funzioni sociali riproduttive svincolate dall'au-
tovalorizzazione del capitale. Dall'altro lato tuttavia, nell'ambito della produzio-
necapitalistica, la tecnologia e la scienzamoderna, operando una scissione tra le
«potenzementali del processo e il lavoro manuale», subordinano la soggettività
empirica dei produttori all'automatismo del capitale. Questo automatismo si ma-
nifesta come una forma di pseudo-soggettività, come un potere universale
astrat-
to
e insieme terribilmente
reale,
«mostro animato che comincia a "lavorare" co-
meseavesseamore in corpo» (16).
La dialettica tra lavoro vivente e lavoro consolidato non è interpretabile con
gli strumenti monologici dell'empirismo positivistico. L'affermarsi dell'astrazione
capitalistica a «mondo invertito» non può essere colta dalle forme logico-
convenzionali del pensiero, che si muovono strumentalmente nell'ambito di ciò
che è già costituito. Tuttavia resta vero che l'auto-capovolgersi dell'ascesa pro-
duttiva borghese «nello sperpero più sfrenato delle energie lavorative e nelle de-
vastazioni derivanti dall'anarchia sociale» (17), sembra alla fine restaurare vecchi
poteri mitologici e una nuova forma di «realismo degli universali». Le forze pro-
duttive della natura, che adessosono il frutto del processosistematico dell'accu-
mulazione scientifica, diventano ingovernabili da parte dei produttori associati.
Le forze sostanziali degli individui empirici scompaiono di fronte alle forze so-
(13) Marx,
Grundrisse,
trad. it. La Nuova Italia, Firenze 1968, vol. I, p. 32.
(14) «Il consumo non è semplice consumo dell'elemento materiale, ma consumo del consumostesso; nella negazione
dell'elemento materiale c'è la negazione di questa negazione e perciò la posizione di esso»
(Grundrisse, cit.,
p.
286).
(15) Cfr. T. S. Kuhn,
La struttura delle rivoluzioni scientifiche,
trad. it. Einaudi, Torino 1969.
(16)
I l capitale,
cit., p. 225, cfr. p. 533 sgg.
(17) Ibidem, p. 534.
















