
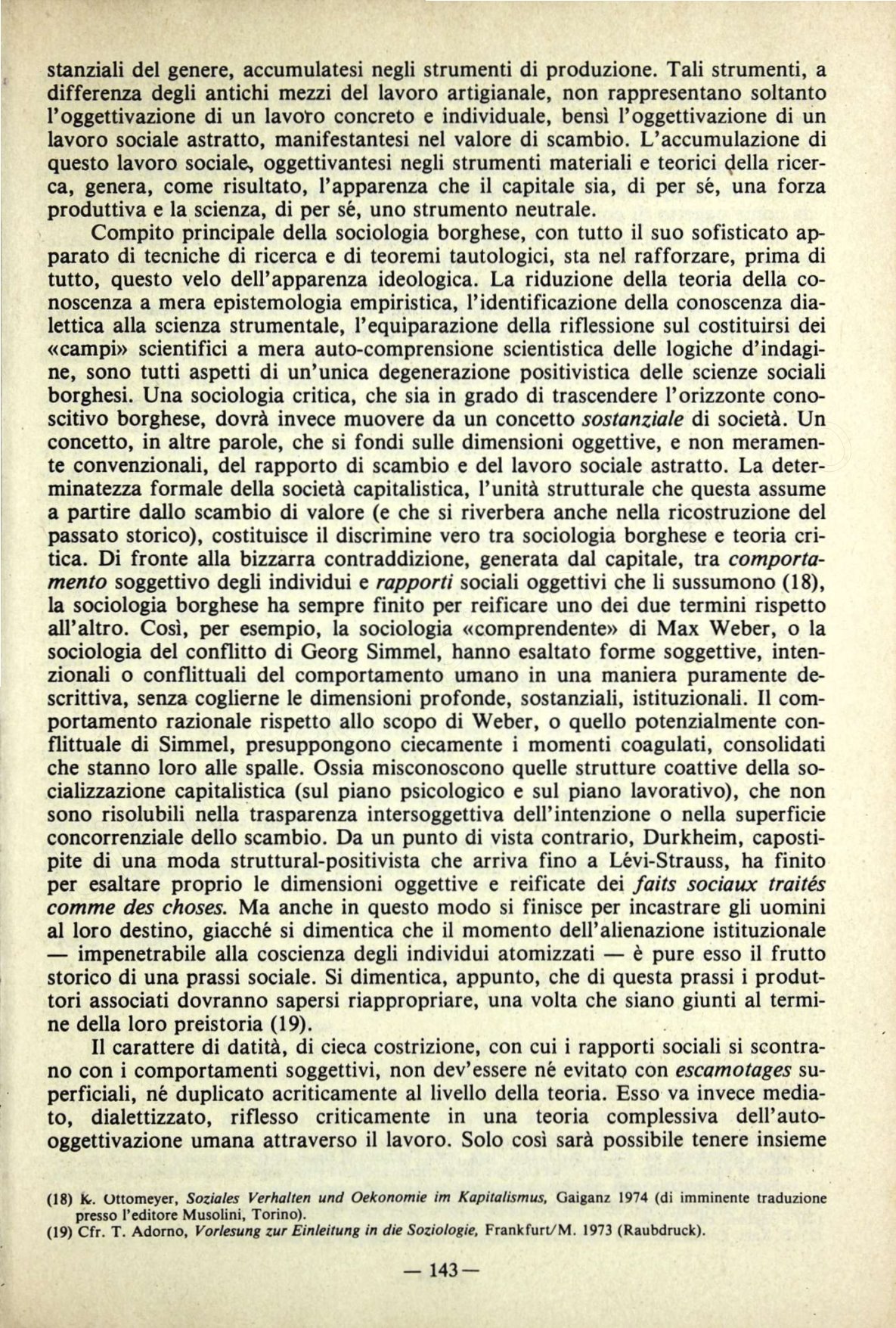
stanziali del genere, accumulatesi negli strumenti di produzione. Tali strumenti, a
differenza degli antichi mezzi del lavoro artigianale, non rappresentano soltanto
l'oggettivazione di un lavoro concreto e individuale, bensì l'oggettivazione di un
lavoro sociale astratto, manifestantesi nel valore di scambio. L'accumulazione di
questo lavoro sociale., oggettivantesi negli strumenti materiali e teorici gella ricer-
ca, genera, come risultato, l'apparenza che il capitale sia, di per sé, una forza
produttiva e la scienza, di per sé, uno strumento neutrale.
Compito principale della sociologiaborghese, con tutto il suo sofisticato ap-
parato di tecniche di ricerca e di teoremi tautologici, sta nel rafforzare, prima di
tutto, questo velo dell'apparenza ideologica. La riduzione della teoria della co-
noscenza a mera epistemologia empiristica, l'identificazione della conoscenza dia-
lettica alla scienza strumentale, l'equiparazione della riflessione sul costituirsi dei
«campi» scientifici a mera auto-comprensionescientistica delle logiche d'indagi-
ne, sono tutti aspetti di un'unica degenerazione positivistica delle scienze sociali
borghesi. Una sociologia critica, che sia in grado di trascendere l'orizzonte cono-
scitivoborghese, dovrà invecemuovere da un concetto
sostanziale
di società. Un
concetto, in altre parole, che si fondi sulle dimensioni oggettive, e nonmeramen-
te convenzionali, del rapporto di scambio e del lavoro sociale astratto. La deter-
minatezza formale della società capitalistica, l'unità strutturale chequestaassume
a partire dallo scambio di valore (e che si riverbera anche nella ricostruzione del
passatostorico), costituisce il discrimine vero tra sociologiaborghese e teoria cri-
tica. Di fronte alla bizzarra contraddizione, generata dal capitale, tra
comporta-
mento
soggettivo degli individui e
rapporti
sociali oggettivi che li sussumono (18),
la sociologiaborghese ha sempre finito per reificare uno dei due termini rispetto
all'altro. Così, per esempio, la sociologia «comprendente» di Max Weber, o la
sociologia del conflitto di Georg Simmel, hanno esaltato forme soggettive, inten-
zionali o conflittuali del comportamento umano in una maniera puramente de-
scrittiva, senza coglierne le dimensioni profonde, sostanziali, istituzionali. Il com-
portamento razionale rispetto allo scopo di Weber, o quello potenzialmente con-
flittuale di Simmel, presuppongonociecamente i momenti coagulati, consolidati
chestanno loro alle spalle. Ossiamisconosconoquelle strutture coattive della so-
cializzazione capitalistica (sul piano psicologico e sul piano lavorativo), che non
sono risolubili nella trasparenza intersoggettiva dell'intenzione o nella superficie
concorrenziale dello scambio. Da un punto di vista contrario, Durkheim, caposti-
pite di una moda struttural-positivista che arriva fino a Lévi-Strauss, ha finito
per esaltare proprio le dimensioni oggettive e reificate dei
faits sociaux traités
commedeschoses.
Ma anche in questomodo si finisce per incastrare gli uomini
al loro destino, giacché si dimentica che il momento dell'alienazione istituzionale
impenetrabile alla coscienza degli individui atomizzati — è pure esso il frutto
storico di una prassi sociale. Si dimentica, appunto, che di questaprassi i produt-
tori associati dovranno sapersi riappropriare, una volta che siano giunti al termi-
nedella loro preistoria (19).
Il carattere di datità, di cieca costrizione, con cui i rapporti sociali si scontra-
nocon i comportamenti soggettivi, non dev'essere né evitato con
escamotages
su-
perficiali, né duplicato acriticamente al livello della teoria. Esso va invecemedia-
to, dialettizzato, riflesso criticamente i n una teoria complessiva dell'auto-
oggettivazione umana attraverso il lavoro. Solo così sarà possibile tenere insieme
(18) K. Ottomeyer,
Soziales Verhalten und Oekonomie im Kapitalismus,
Gaiganz 1974 (di imminente traduzione
presso l'editore Musolini, Torino).
(19) Cfr. T. Adorno,
Vorlesung zur Einleitung in die Soziologie,
Frankfurt/M. 1973 (Raubdruck).
—143—
















