
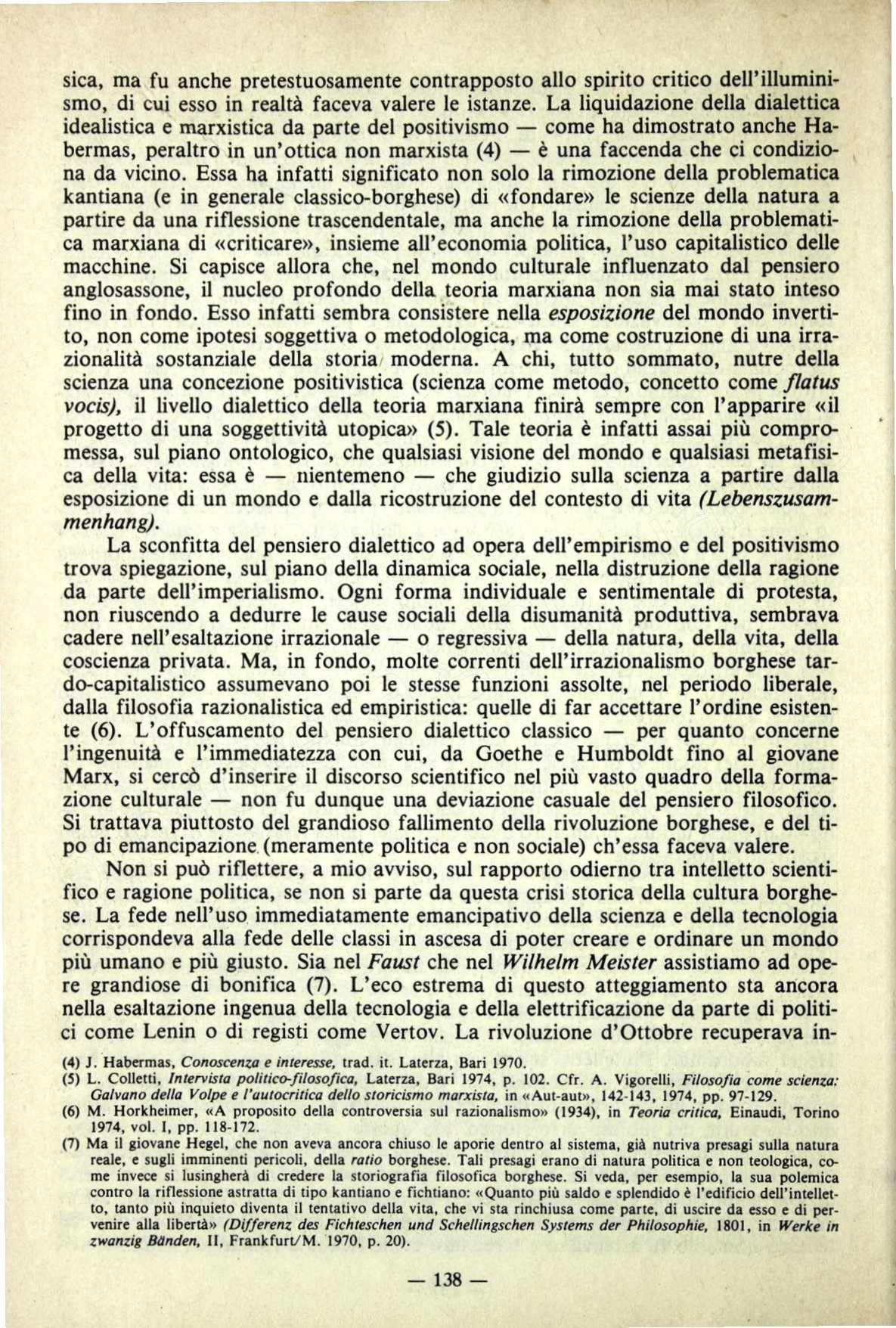
sica, ma fu anchepretestuosamente contrapposto allo spirito critico dell'illumini-
smo, di cui esso in realtà faceva valere le istanze. La liquidazione della dialettica
idealistica emarxistica da parte del positivismo—come ha dimostrato anche Ha-
bermas, peraltro in un'ottica nonmarxista (4) — è una faccenda che ci condizio-
nada vicino. Essa ha infatti significato non solo la rimozione della problematica
kantiana (e in generale classico-borghese) di «fondare» le scienze della natura a
partire da una riflessione trascendentale, ma anche la rimozione della problemati-
camarxiana di «criticare», insieme all'economia politica, l'uso capitalistico delle
macchine. Si capisce allora che, nel mondo culturale influenzato dal pensiero
anglosassone, il nucleo profondo della teoria marxiana non sia mai stato inteso
fino in fondo. Esso infatti sembraconsistere nella
esposizione
del mondo inverti-
to, non come ipotesi soggettiva ometodologica, ma comecostruzione di una irra-
zionalità sostanziale della storia moderna. A chi, tutto sommato, nutre della
scienza una concezione positivistica (scienza comemetodo, concetto come
flatus
vocis),
i l livello dialettico della teoria marxiana finirà sempre con l'apparire «il
progetto di una soggettività utopica» (5). Tale teoria è infatti assai più compro-
messa, sul piano ontologico, che qualsiasi visione del mondo e qualsiasi metafisi-
cadella vita: essa è — nientemeno — che giudizio sulla scienza a partire dalla
esposizione di un mondo e dalla ricostruzione del contesto di vita
(Lebenszusam-
menhang).
La sconfitta del pensiero dialettico ad opera dell'empirismo e del positivismo
trova spiegazione, sul piano della dinamica sociale, nella distruzione della ragione
da parte dell'imperialismo. Ogni forma individuale e sentimentale di protesta,
nonriuscendo a dedurre le cause sociali della disumanità produttiva, sembrava
caderenell'esaltazione irrazionale — o regressiva— della natura, della vita, della
coscienzaprivata. Ma, in fondo, molte correnti dell'irrazionalismo borghese tar-
do-capitalisticoassumevano poi le stesse funzioni assolte, nel periodo liberale,
dalla filosofia razionalistica ed empiristica: quelle di far accettare l'ordine esisten-
te (6). L'offuscamento del pensiero dialettico classico — per quanto concerne
l'ingenuità e l'immediatezza con cui, da Goethe e Humboldt fino al giovane
Marx, si cercò d'inserire il discorso scientifico nel più vasto quadro della forma-
zione culturale — non fu dunque una deviazione casuale del pensiero filosofico.
Si trattava piuttosto del grandioso fallimento della rivoluzione borghese, e del ti-
po di emancipazione. (meramente politica e non sociale) ch'essa faceva valere.
Non si può riflettere, a mio avviso, sul rapporto odierno tra intelletto scienti-
ficoe ragione politica, se non si parte da questa crisi storica della cultura borghe-
se. La fede nell'uso immediatamente emancipativo della scienza e della tecnologia
corrispondeva alla fede delle classi in ascesa di poter creare e ordinare un mondo
piùumano e più giusto. Sia nel
Faust
che nel
WilhelmMeister
assistiamo ad ope-
regrandiose di bonifica (7). L'eco estrema di questo atteggiamento sta ancora
nellaesaltazione ingenua della tecnologia e della elettrificazione da parte di politi-
ci come Lenin o di registi come Vertov. La rivoluzione d'Ottobre recuperava in-
(4) J. Habermas,
Conoscenza
e
interesse,
trad. it. Laterza, Bari 1970.
(5) L. Colletti,
Intervista politico-filosofica,
Laterza, Bari 1974, p. 102. Cfr. A. Vigorelli,
Filosofia come scienza:
Galvano della Volpe e l'autocritica dello storicismomarxista, in «Aut-aut», 142-143, 1974, pp. 97-129.
(6) M. Horkheimer, «A proposito della controversia sul razionalismo» (1934), in
Teoria critica,
Einaudi, Torino
1974, vol. I , pp. 118-172.
(7) Ma il giovane Hegel, che non aveva ancora chiuso le aporie dentro al sistema, già nutriva presagi sulla natura
reale, e sugli imminenti pericoli, della
ratio
borghese. Tali presagi erano di natura politica e non teologica, co-
me invece si lusingherà di credere la storiografia filosofica borghese. Si veda, per esempio, la sua polemica
contro la riflessione astratta di tipo kantiano e fichtiano: «Quanto più saldo e splendido è l'edificio dell'intellet-
to, tanto più inquieto diventa il tentativo della vita, che vi
sta
rinchiusa come parte, di uscire da esso e di per-
venire alla libertà» (Differenz des Fichteschen und SchellingschenSystems der Philosophie, 1801, in Werke in
zwanzigMinden, I l ,
Frankfurt/M..1970, p. 20).
















