
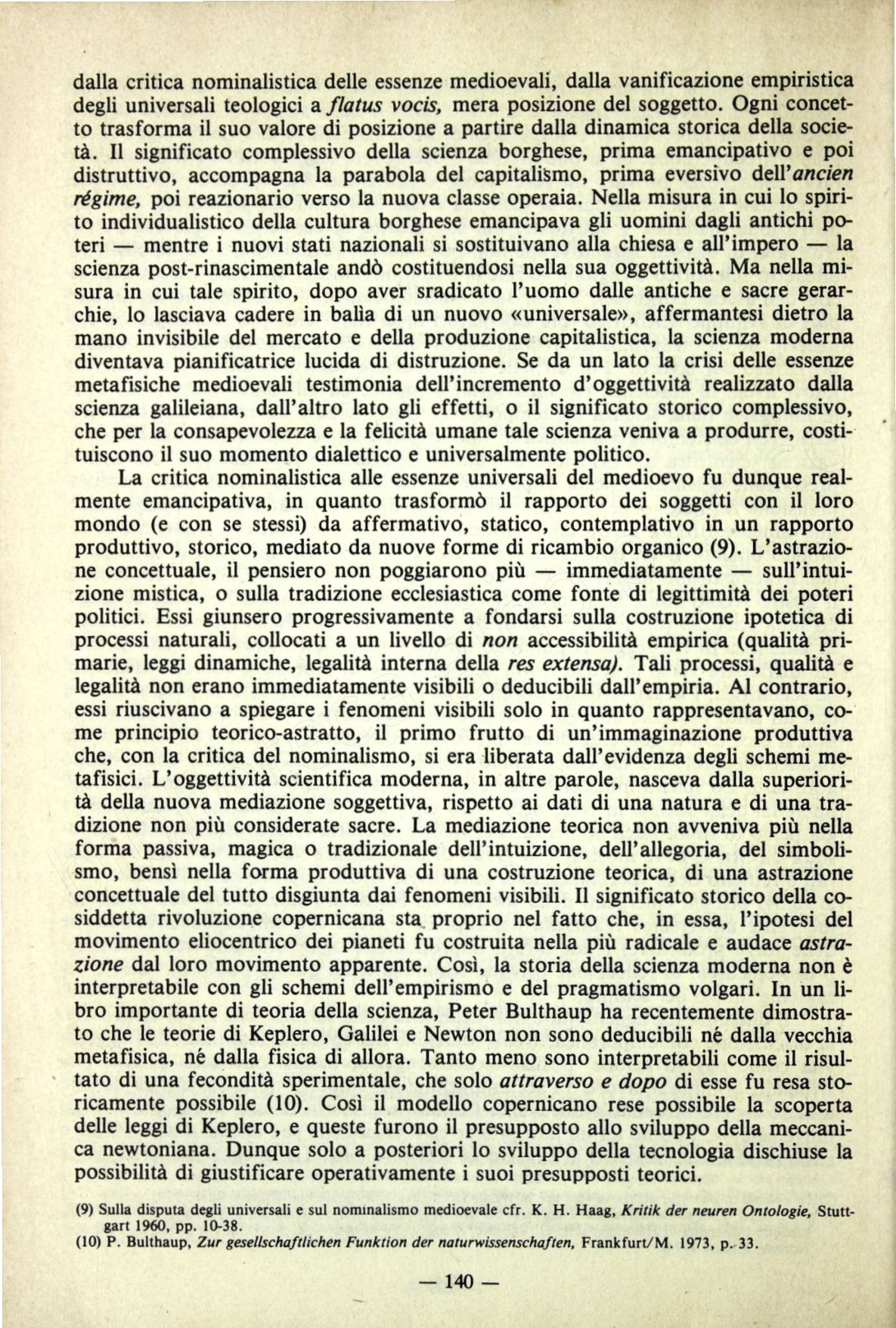
dalla critica nominalistica delleessenzemedioevali, dalla vanificazione empiristica
degli universali teologici a
flatus vocis,
mera posizione del soggetto. Ogni concet-
to trasforma il suo valore di posizione a partire dalla dinamica storica della socie-
tà. I l significato complessivo della scienza borghese, prima emancipativo e poi
distruttivo, accompagna la parabola del capitalismo, prima eversivo
dell'ancien
régime,
poi reazionario verso la nuovaclasseoperaia. Nella misura in cui lo spiri-
to individualistico della cultura borgheseemancipava gli uomini dagli antichi po-
teri — mentre i nuovi stati nazionali si sostituivano alla chiesa e all'impero — la
scienzapost-rinascimentale andò costituendosi nella sua oggettività. Ma nella mi-
sura in cui tale spirito, dopo aver sradicato l'uomo dalle antiche e sacre gerar-
chie, lo lasciava cadere in balia di un nuovo «universale», affermantesi dietro la
mano invisibile del mercato e della produzione capitalistica, la scienzamoderna
diventava pianificatrice lucida di distruzione. Se da un lato la crisi delle essenze
metafisichemedioevali testimonia dell'incremento d'oggettività realizzato dalla
scienzagalileiana, dall'altro lato gli effetti, o il significato storico complessivo,
cheper la consapevolezza e la felicità umane tale scienza veniva a produrre, costi-
tuiscono il suomomento dialettico e universalmente politico.
La critica nominalistica alle essenzeuniversali del medioevo fu dunque real-
menteemancipativa, in quanto trasformò i l rapporto dei soggetti con i l loro
mondo (e con se stessi) da affermativo, statico, contemplativo in un rapporto
produttivo, storico, mediato da nuove forme di ricambio organico (9). L'astrazio-
neconcettuale, il pensiero non poggiarono più — immediatamente — sull'intui-
zionemistica, o sulla tradizione ecclesiastica come fonte di legittimità dei poteri
politici. Essi giunseroprogressivamente a fondarsi sulla costruzione ipotetica di
processi naturali, collocati a un livello di
non
accessibilità empirica (qualità pri-
marie, leggi dinamiche, legalità interna della
res extensa).
Tali processi, qualità e
legalità non erano immediatamente visibili o deducibili dall'empiria. Al contrario,
essiriuscivano a spiegare i fenomeni visibili solo in quanto rappresentavano, co-
meprincipio teorico-astratto, i l primo frutto di un'immaginazione produttiva
che, con la critica del nominalismo, si era liberata dall'evidenza degli schemi me-
tafisici. L'oggettività scientificamoderna, in altre parole, nasceva dalla superiori-
tà della nuovamediazione soggettiva, rispetto ai dati di una natura e di una tra-
dizione non più considerate sacre. La mediazione teorica non avveniva più nella
forma passiva, magica o tradizionale dell'intuizione, dell'allegoria, del simboli-
smo, bensì nella forma produttiva di una costruzione teorica, di una astrazione
concettuale del tutto disgiunta dai fenomeni visibili. Il significato storico della co-
siddetta rivoluzione copernicana sta, proprio nel fatto che, in essa, l'ipotesi del
movimentoeliocentrico dei pianeti fu costruita nella più radicale e audace
astra-
zione
dal loro movimento apparente. Così, la storia della scienzamoderna non è
interpretabile con gli schemi dell'empirismo e del pragmatismo volgari. In un li-
bro importante di teoria della scienza, Peter Bulthaup ha recentemente dimostra-
toche le teorie di Keplero, Galilei e Newton non sono deducibili né dalla vecchia
metafisica, né dalla fisica di allora. Tanto meno sono interpretabili come il risul-
tato di una fecondità sperimentale, che solo
attraverso
e
dopo
di esse fu resa sto-
ricamentepossibile (10). Così il modello copernicano rese possibile la scoperta
delle leggi di Keplero, e queste furono il presupposto allo sviluppo dellameccani-
canewtoniana. Dunque solo a posteriori lo sviluppo della tecnologiadischiuse la
possibilità di giustificare operativamente i suoi presupposti teorici.
(9) Sulla disputa degli universali e sul nominalismomedioevale cfr. K. H. Haag,
Kritik der neuren Ontologie,
Stutt-
gart 1960, pp. 10-38.
(10) P. Bulthaup, Zur gesellschaftlichén Funktion der naturwissenschaften, Frankfurt/M. 1973, p 33.
140
















