
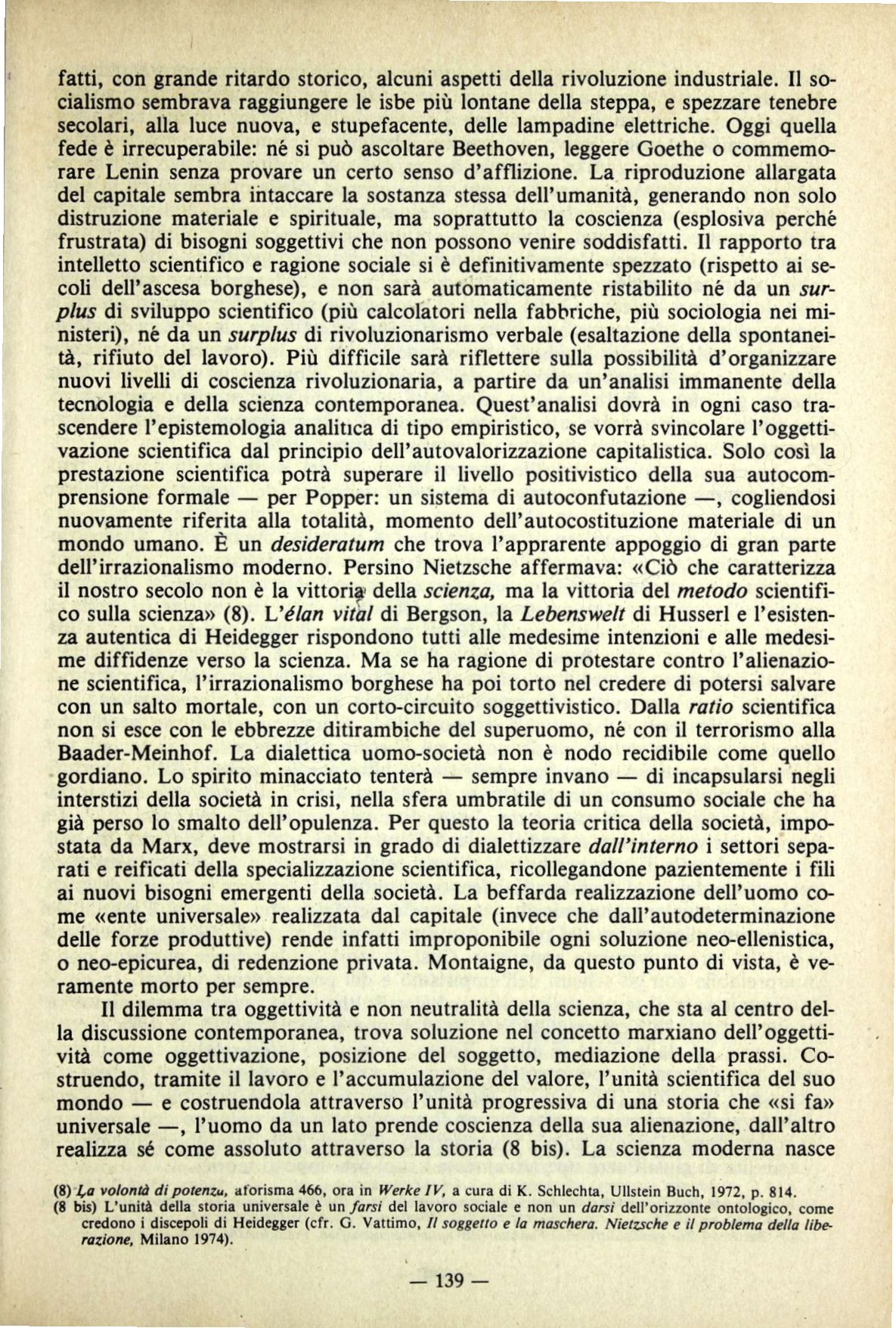
fatti, con grande ritardo storico, alcuni aspetti della rivoluzione industriale. Il so-
cialismosembrava raggiungere le isbe più lontane della steppa, e spezzare tenebre
secolari, alla luce nuova, e stupefacente, delle lampadine elettriche. Oggi quella
fede è irrecuperabile: né si può ascoltareBeethoven, leggereGoethe o commemo-
rare Lenin senza provare un certo senso d'afflizione. La riproduzione allargata
del capitale sembra intaccare la sostanzastessa dell'umanità, generando non solo
distruzionemateriale e spirituale, ma soprattutto la coscienza (esplosiva perché
frustrata) di bisogni soggettivi che nonpossonovenire soddisfatti. I l rapporto tra
intelletto scientifico e ragione sociale si è definitivamente spezzato (rispetto ai se-
coli dell'ascesa borghese), e non sarà automaticamente ristabilito né da un
sur-
plus
di sviluppo scientifico (più calcolatori nella fabbriche, più sociologia nei mi-
nisteri), né da un
surplus
di rivoluzionarismo verbale (esaltazione della spontanei-
tà, rifiuto del lavoro). Più difficile sarà riflettere sulla possibilità d'organizzare
nuovi livelli di coscienza rivoluzionaria, a partire da un'analisi immanente della
tecnologia e della scienza contemporanea. Quest'analisi dovrà in ogni caso tra-
scendere l'epistemologia analitica di tipo empiristico, se vorrà svincolare l'oggetti-
vazione scientifica dal principio dell'autovalorizzazione capitalistica. Solo così la
prestazione scientifica potrà superare il livello positivistico della sua autocom-
prensione formale — per Popper: un sistema di autoconfutazione —, cogliendosi
nuovamente riferita alla totalità, momento dell'autocostituzione materiale di un
mondoumano. È un
desideratum
che trova l'apprarente appoggio di gran parte
dell'irrazionalismomoderno. Persino Nietzsche affermava: «Ciò che caratterizza
il nostro secolo non è la vittori!, della
scienza, ma
la vittoria del
metodo scientifi-
co
sulla scienza» (8).
L'élan vita!
di Bergson, la
Lebenswelt
di Husserl e l'esisten-
za autentica di Heidegger rispondono tutti allemedesime intenzioni e allemedesi-
mediffidenze verso la scienza. Ma se ha ragione di protestare contro l'alienazio-
nescientifica, l'irrazionalismo borghese ha poi torto nel credere di potersi salvare
con un salto mortale, con un corto-circuito soggettivistico. Dalla
ratio
scientifica
nonsi escecon le ebbrezze ditirambiche del superuomo, né con il terrorismo alla
Baader-Meinhof. La dialettica uomo-società non è nodo recidibile come quello
gordiano. Lo spiritominacciato tenterà — sempre invano — di incapsularsi negli
interstizi della società in crisi, nella sfera umbratile di un consumosociale che ha
giàperso lo smalto dell'opulenza. Per questo la teoria critica della società, impo-
stata da Marx, devemostrarsi in grado di dialettizzare
dall'interno
i settori sepa-
rati e reificati della specializzazione scientifica, ricollegandone pazientemente i fili
ai nuovi bisogni emergenti della società. La beffarda realizzazione dell'uomo co-
me«ente universale» realizzata dal capitale (invece che dall'autodeterminazione
delle forze produttive) rende infatti improponibile ogni soluzione neo-ellenistica,
oneo-epicurea, di redenzione privata. Montaigne, da questo punto di vista, è ve-
ramentemorto per sempre.
Il dilemma tra oggettività e non neutralità della scienza, che sta al centro del-
ladiscussionecontemporanea, trova soluzione nel concettomarxiano dell'oggetti-
vità come oggettivazione, posizione del soggetto, mediazione della prassi. Co-
struendo, tramite il lavoro e l'accumulazione del valore, l'unità scientifica del suo
mondo — e costruendola attraverso l'unità progressiva di una storia che «si fa»
universale —, l'uomo da un lato prendecoscienza della sua alienazione, dall'altro
realizza sé come assoluto attraverso la storia (8 bis). La scienzamoderna nasce
(8)
t a volontà di potenz«,
aforisma 466, ora in
Werke IV,
a cura di K. Schlechta, Ullstein Buch, 1972, p. 814.
(8 bis) L'unità della storia universale è un
farsi
del lavoro sociale e non un
darsi
dell'orizzonte ontologico, come
credono i discepoli di Heidegger (cfr. G. Vattimo, I l soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della libe-
razione,
Milano 1974).
—139—
















