
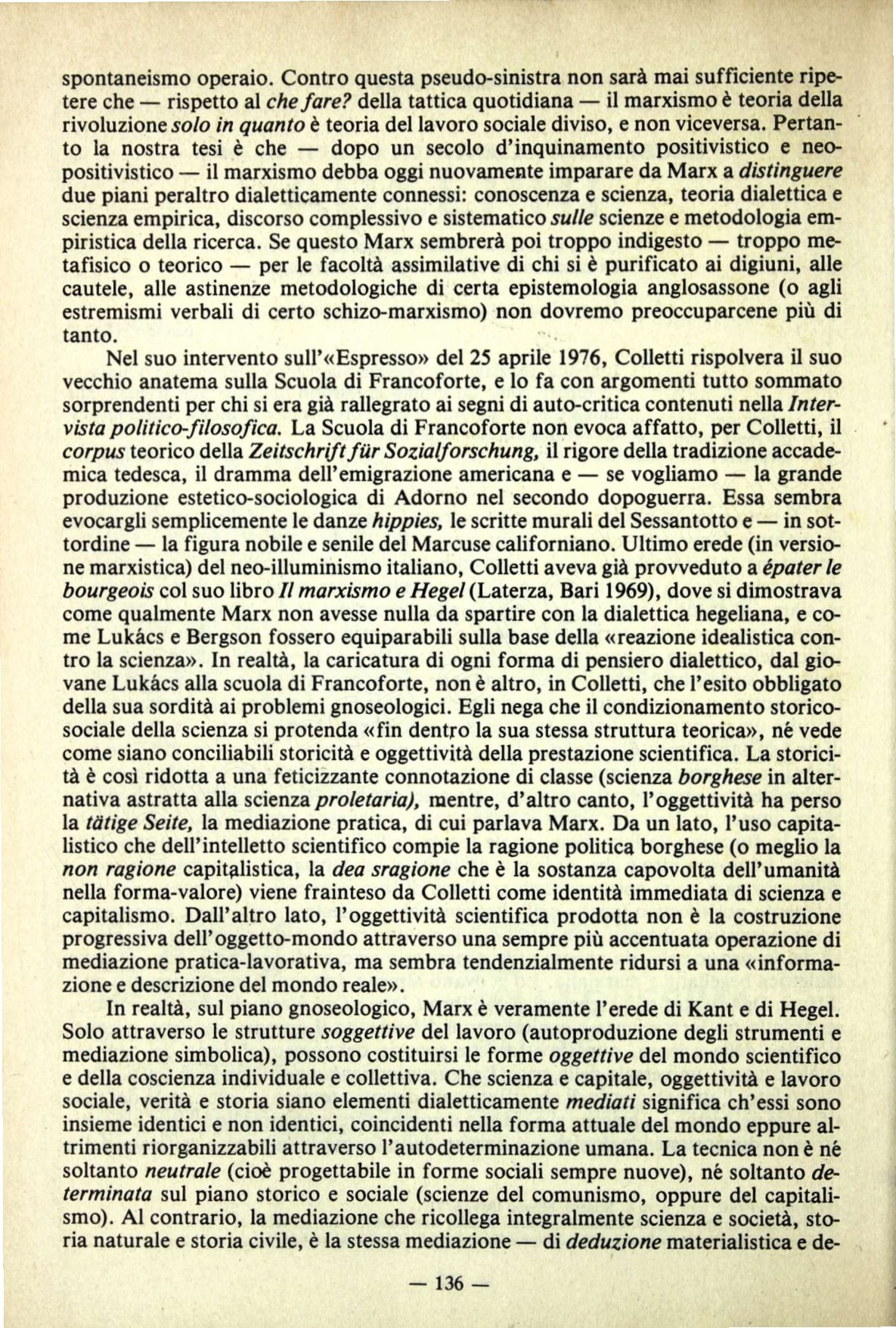
spontaneismooperaio. Contro questapseudo-sinistra nonsaràmai sufficiente ripe-
tereche—rispetto al
che fare?
della tattica quotidiana— il marxismoè teoria della
rivoluzione
solo in quanto
è teoria del lavorosocialediviso, e nonviceversa. Pertan-
to la nostra tesi è che — dopo un secolo d'inquinamento positivistico e neo-
positivistico— il marxismodebbaoggi nuovamente imparare da Marx a
distinguere
duepiani peraltro dialetticamenteconnessi:conoscenzaescienza, teoria dialettica e
scienzaempirica, discorsocomplessivoesistematico
sulle
scienzeemetodologia em-
piristica della ricerca. SequestoMarx sembrerà poi troppo indigesto— troppome-
tafisico o teorico — per le facoltà assimilative di chi si è purificato ai digiuni, alle
cautele, alle astinenzemetodologiche di certa epistemologiaanglosassone (o agli
estremismi verbali di certo schizo-marxismo) non dovremopreoccuparcene più di
tanto.
Nel suo intervento sull'«Espresso» del 25 aprile 1976, Colletti rispolvera il suo
vecchioanatema sullaScuola di Francoforte, e lo fa conargomenti tutto sommato
sorprendenti per chi si era già rallegrato ai segni di auto-critica contenuti nella
Inter-
vista politico-filosofica.
La Scuola di Francoforte nonevoca affatto, per Colletti, il
corpus
teoricodella
Zeitschrift far Sozialforschung,
il rigore della tradizioneaccade-
mica tedesca, il dramma dell'emigrazione americana e—se vogliamo— la grande
produzione estetico-sociologica di Adorno nel secondodopoguerra. Essa sembra
evocargli semplicemente ledanze
hippies,
le scrittemurali del Sessantottoe— in sot-
tordine— la figura nobileeseniledelMarcuse californiano. Ultimo erede (in versio-
nemarxistica) del neo-illuminismo italiano, Colletti avevagiàprovveduto a
épater le
bourgeois
col suo libro
li marxismo
e
Hegel
(Laterza, Bari 1969), dovesi dimostrava
comequalmente Marx nonavessenulla da spartire con la dialettica hegeliana, e co-
meLukàcs eBergsonfossero equiparabili sullabasedella «reazione idealistica con-
tro la scienza». In realtà, la caricatura di ogni forma di pensiero dialettico, dal gio-
vaneLukàcs alla scuola di Francoforte, nonè altro, in Colletti, che l'esito obbligato
dellasuasordità ai problemi gnoseologici. Egli negache il condizionamento storico-
socialedella scienzasi protenda «fin dentro la suastessastruttura teorica», né vede
comesiano conciliabili storicità eoggettività della prestazione scientifica. La storici-
tàècosì ridotta a una feticizzante connotazione di classe(scienza
borghese
in alter-
nativa astratta alla scienza
proletaria),
mentre, d'altro canto, l'oggettività ha perso
la
teitigeSeite,
la mediazione pratica, di cui parlava Marx. Da un lato, l'uso capita-
listicoche dell'intelletto scientificocompie la ragione politicaborghese (omeglio la
non ragione
capitalistica, la
dea sragione
che è la sostanza capovolta dell'umanità
nella forma-valore) viene frainteso da Colletti come identità immediata di scienza e
capitalismo. Dall'altro lato, l'oggettività scientifica prodotta non è la costruzione
progressiva dell'oggetto-mondoattraversounasemprepiù accentuataoperazione di
mediazione pratica-lavorativa, ma sembra tendenzialmente ridursi a una «informa-
zioneedescrizionedelmondo reale».
In realtà, sul pianognoseologico, Marx èveramente l'erede di Kant e di Hegel.
Soloattraverso le strutture
soggettive
del lavoro (autoproduzione degli strumenti e
mediazione simbolica), possonocostituirsi le forme
oggettive
del mondo scientifico
edellacoscienza individuale e collettiva. Che scienzae capitale, oggettività e lavoro
sociale, verità e storia siano elementi dialetticamente
mediati
significach'essi sono
insieme identici enon identici, coincidenti nella forma attuale del mondoeppure al-
trimenti riorganizzabili attraverso l'autodeterminazione umana. La tecnicanonèné
soltanto
neutrale
(cioè progettabile in forme sociali semprenuove), né soltanto
de-
terminata
sul piano storico e sociale (scienze del comunismo, oppure del capitali-
smo). Al contrario, la mediazioneche ricollega integralmentescienzaesocietà, sto-
ria naturale estoria civile, è lastessamediazione d i
deduzionematerialistica
ede-
136
















