
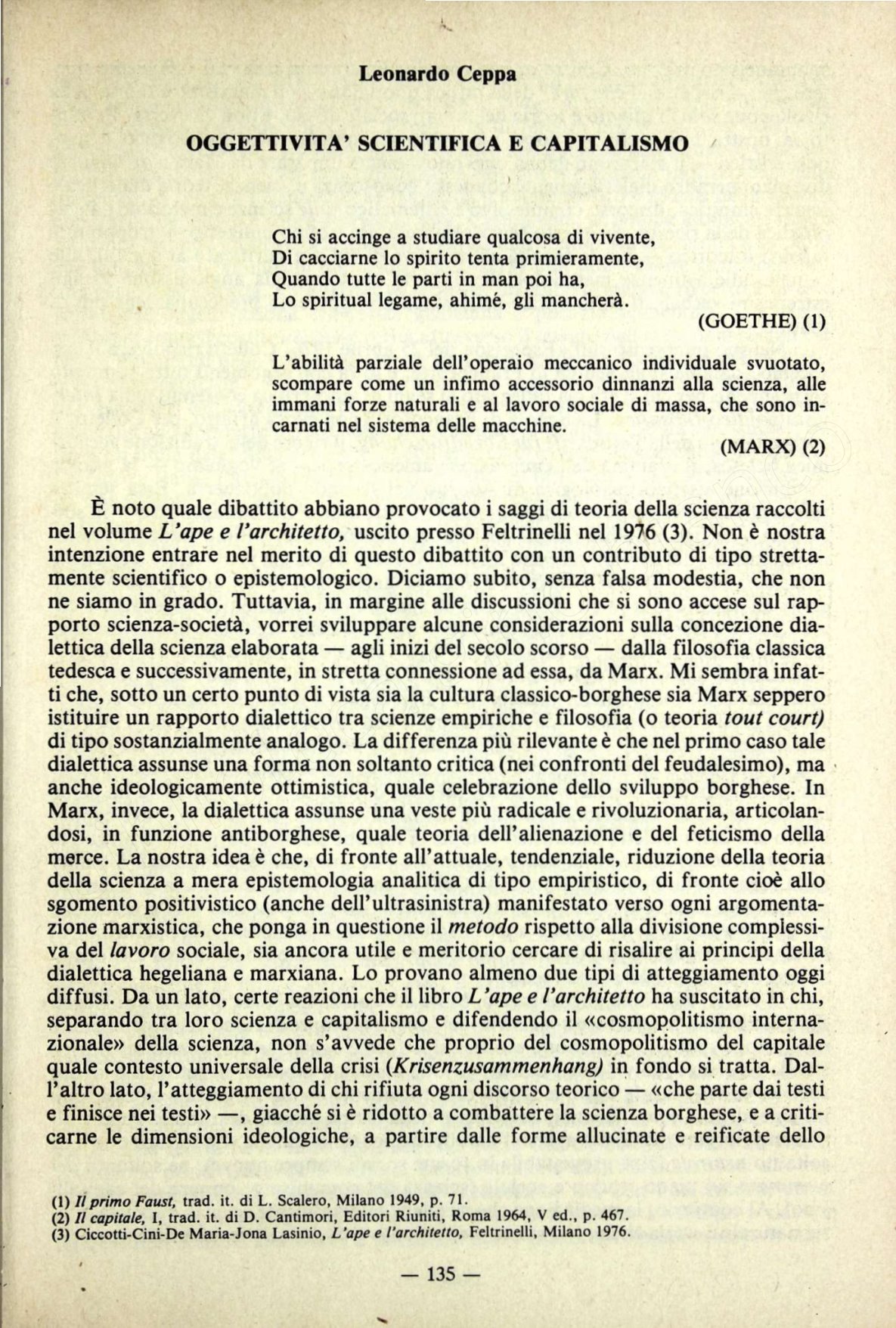
LeonardoCeppa
OGGETTIVITA' SCIENTIFICA E CAPITALISMO
Chi si accinge a studiarequalcosa di vivente,
Di cacciarne lo spirito tenta primieramente,
Quando tutte le parti in man poi ha,
Lo spiritual legame, ahimé, gli mancherà.
(GOETHE) (1)
L'abilità parziale dell'operaiomeccanico individuale svuotato,
scomparecome un infimo accessoriodinnanzi alla scienza, alle
immani forze naturali e al lavoro sociale di massa, che sono in-
carnati nel sistemadellemacchine.
(MARX) (2)
È noto quale dibattito abbianoprovocato i saggi di teoria dellascienza raccolti
nel volume
L'ape
e
l'architetto,
uscitopressoFeltrinelli nel l 9/6 (3). Non è nostra
intenzione entrare nel merito di questo dibattito con un contributo di tipo stretta-
mentescientifico o epistemologico. Diciamo subito, senza falsamodestia, che non
nesiamo in grado. Tuttavia, in margine alle discussioni che si sonoaccesesul rap-
portoscienza-società, vorrei sviluppare alcune considerazioni sulla concezione dia-
lettica dellascienzaelaborata—agli inizi del secoloscorso—dalla filosofiaclassica
tedescaesuccessivamente, in strettaconnessioneadessa, da Marx. Mi sembra infat-
ti che, sotto uncertopunto di vistasia la culturaclassico-borghesesia Marx seppero
istituire un rapporto dialettico tra scienzeempiriche e filosofia (o teoria
tout court)
di tipo sostanzialmenteanalogo. La differenza più rilevanteèchenel primocasotale
dialetticaassunseuna forma nonsoltanto critica (nei confronti del feudalesimo), ma
anche ideologicamente ottimistica, quale celebrazione dello sviluppoborghese. In
Marx, invece, la dialetticaassunseunavestepiù radicalee rivoluzionaria, articolan-
dosi, in funzione antiborghese, quale teoria dell'alienazione e del feticismo della
merce. La nostra ideaèche, di fronte all'attuale, tendenziale, riduzione della teoria
della scienza a mera epistemologia analitica di tipo empiristico, di fronte cioè allo
sgomentopositivistico (anche dell'ultrasinistra) manifestato versoogni argomenta-
zionemarxistica, cheponga in questione il
metodo
rispetto alla divisionecomplessi-
va del
lavoro
sociale, sia ancora utile e meritorio cercare di risalire ai principi della
dialettica hegeliana emarxiana. Lo provano almenodue tipi di atteggiamentooggi
diffusi. Da un lato, certe reazioni che il libro
L'ape
e
l'architetto
hasuscitato in chi,
separando tra loro scienza e capitalismo e difendendo il «cosmopolitismo interna-
zionale» della scienza, non s'avvede che proprio del cosmopolitismo del capitale
qualecontestouniversale della crisi
(Krisenzusammenhang)
in fondo si tratta. Dal-
l'altro lato, l'atteggiamento di chi rifiuta ognidiscorso teorico—«cheparte dai testi
efiniscenei testi» —, giacchési è ridotto a combattere la scienzaborghese, e a criti-
carne le dimensioni ideologiche, a partire dalle forme allucinate e reificate dello
(1) I l primo Faust,
trad. it. di L. Scalero, Milano 1949, p. 71.
(2)
I l capitale,
I , trad. it. di D. Cantimori, Editori Riuniti, Roma 1964, V ed., p. 467.
(3) Ciccotti-Cini-De Maria-Jona Lasinio,
L'ape
e
l'architetto,
Feltrinelli, Milano 1976.
—135
•
















