
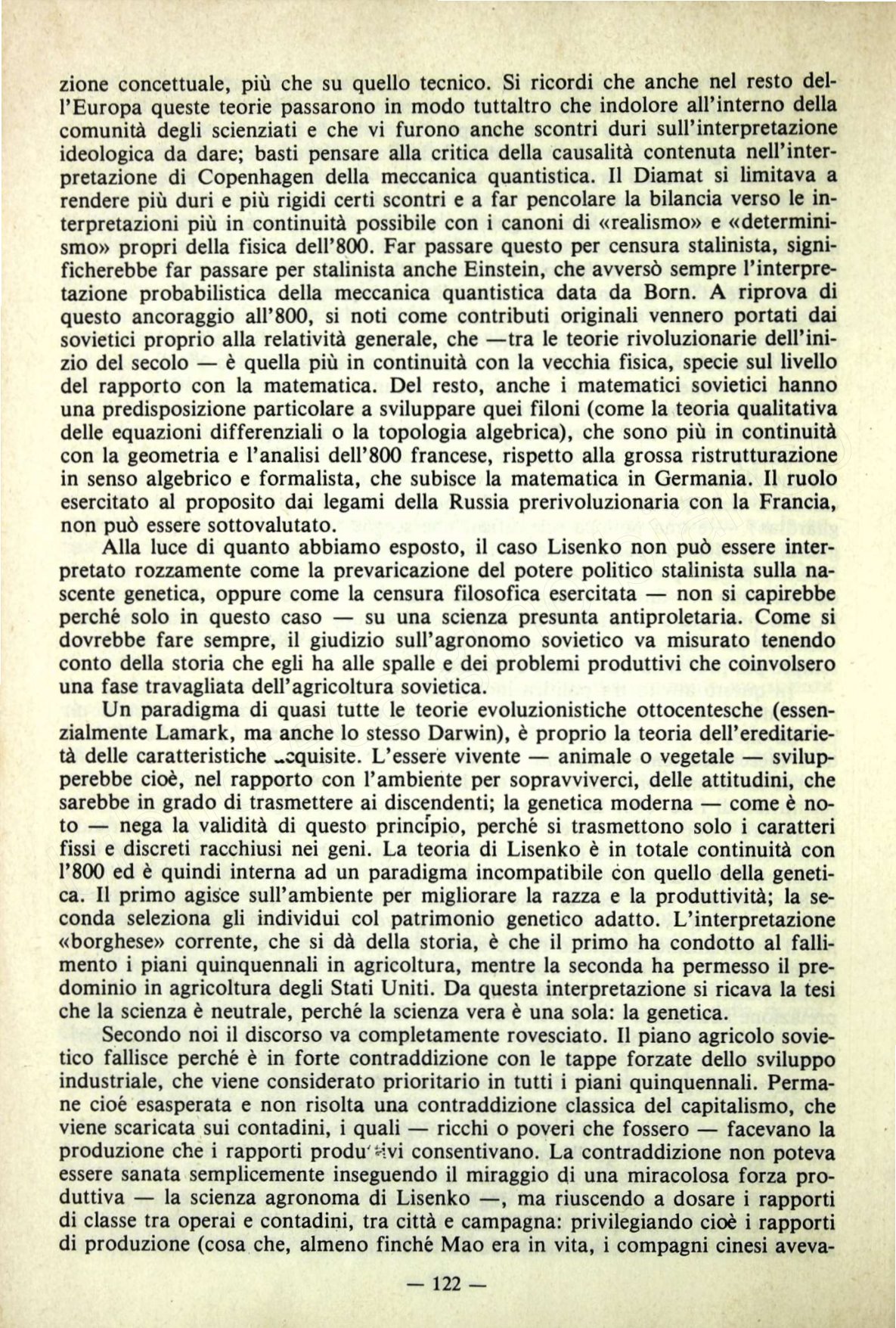
zione concettuale, più che su quello tecnico. Si ricordi che anche nel resto del-
l'Europa queste teorie passarono in modo tuttaltro che indolore all'interno della
comunità degli scienziati e che vi furono anche scontri duri sull'interpretazione
ideologica da dare; basti pensare alla critica della causalità contenuta nell'inter-
pretazione di Copenhagen della meccanica quantistica. I l Diamat si limitava a
rendere più duri e più rigidi certi scontri e a far pencolare la bilancia verso le in-
terpretazioni più in continuità possibile con i canoni di «realismo» e «determini-
smo»propri della fisica dell'800. Far passarequesto per censura stalinista, signi-
ficherebbe far passare per stalinista anche Einstein, che avversòsempre l'interpre-
tazione probabilistica della meccanica quantistica data da Born. A riprova di
questoancoraggio all'800, si noti come contributi originali vennero portati dai
sovietici proprio alla relatività generale, che —tra le teorie rivoluzionarie dell'ini-
zio del secolo — è quella più in continuità con la vecchia fisica, specie sul livello
del rapporto con la matematica. Del resto, anche i matematici sovietici hanno
unapredisposizione particolare a sviluppare quei filoni (come la teoria qualitativa
delle equazioni differenziali o la topologia algebrica), che sono più in continuità
con la geometria e l'analisi dell'800 francese, rispetto alla grossa ristrutturazione
insensoalgebrico e formalista, che subisce la matematica in Germania. I l ruolo
esercitato al proposito dai legami della Russia prerivoluzionaria con la Francia,
nonpuòesseresottovalutato.
Alla luce di quanto abbiamo esposto, il caso Lisenko non può essere inter-
pretato rozzamente come la prevaricazione del potere politico stalinista sulla na-
scentegenetica, oppure come la censura filosofica esercitata — non si capirebbe
perché solo in questo caso — su una scienza presunta antiproletaria. Come si
dovrebbe fare sempre, i l giudizio sull'agronomo sovietico va misurato tenendo
conto della storia che egli ha alle spalle e dei problemi produttivi che coinvolsero
una fase travagliata dell'agricoltura sovietica.
Un paradigma di quasi tutte le teorie evoluzionistiche ottocentesche (essen-
zialmente Lamark, ma anche lo stessoDarwin), è proprio la teoria dell'ereditarie-
tà delle caratteristiche .cquisite. L'essere vivente — animale o vegetale — svilup-
perebbecioè, nel rapporto con l'ambiente per sopravviverci, delle attitudini, che
sarebbe in grado di trasmettere ai discendenti; la geneticamoderna — come è no-
to — nega la validità di questo principio, perché si trasmettono solo i caratteri
fissi e discreti racchiusi nei geni. La teoria di Lisenko è in totale continuità con
1'800 ed è quindi interna ad un paradigma incompatibile éon quello della geneti-
ca. I l primo agiste sull'ambiente per migliorare la razza e la produttività; la se-
condaseleziona gli individui col patrimonio genetico adatto. L'interpretazione
«borghese» corrente, che si dà della storia, è che il primo ha condotto al falli-
mento i piani quinquennali in agricoltura, mentre la seconda ha permesso il pre-
dominio in agricoltura degli Stati Uniti. Da questa interpretazione si ricava la tesi
che la scienzaè neutrale, perché la scienza vera è una sola: la genetica.
Secondonoi il discorso va completamente rovesciato. Il piano agricolo sovie-
tico fallisce perché è in forte contraddizione con le tappe forzate dello sviluppo
industriale, che viene considerato prioritario in tutti i piani quinquennali. Perma-
necioè esasperata e non risolta una contraddizione classica del capitalismo, che
vienescaricata sui contadini, i quali — ricchi o poveri che fossero — facevano la
produzione che i rapporti produiJeiviconsentivano. La contraddizione non poteva
esseresanatasemplicemente inseguendo il miraggio di una miracolosa forza pro-
duttiva — la scienza agronoma di Lisenko —, ma riuscendo a dosare i rapporti
di classe tra operai e contadini, tra città e campagna: privilegiando cioè i rapporti
di produzione (cosa che, almeno finché Mao era in vita, i compagni cinesi aveva-
















