
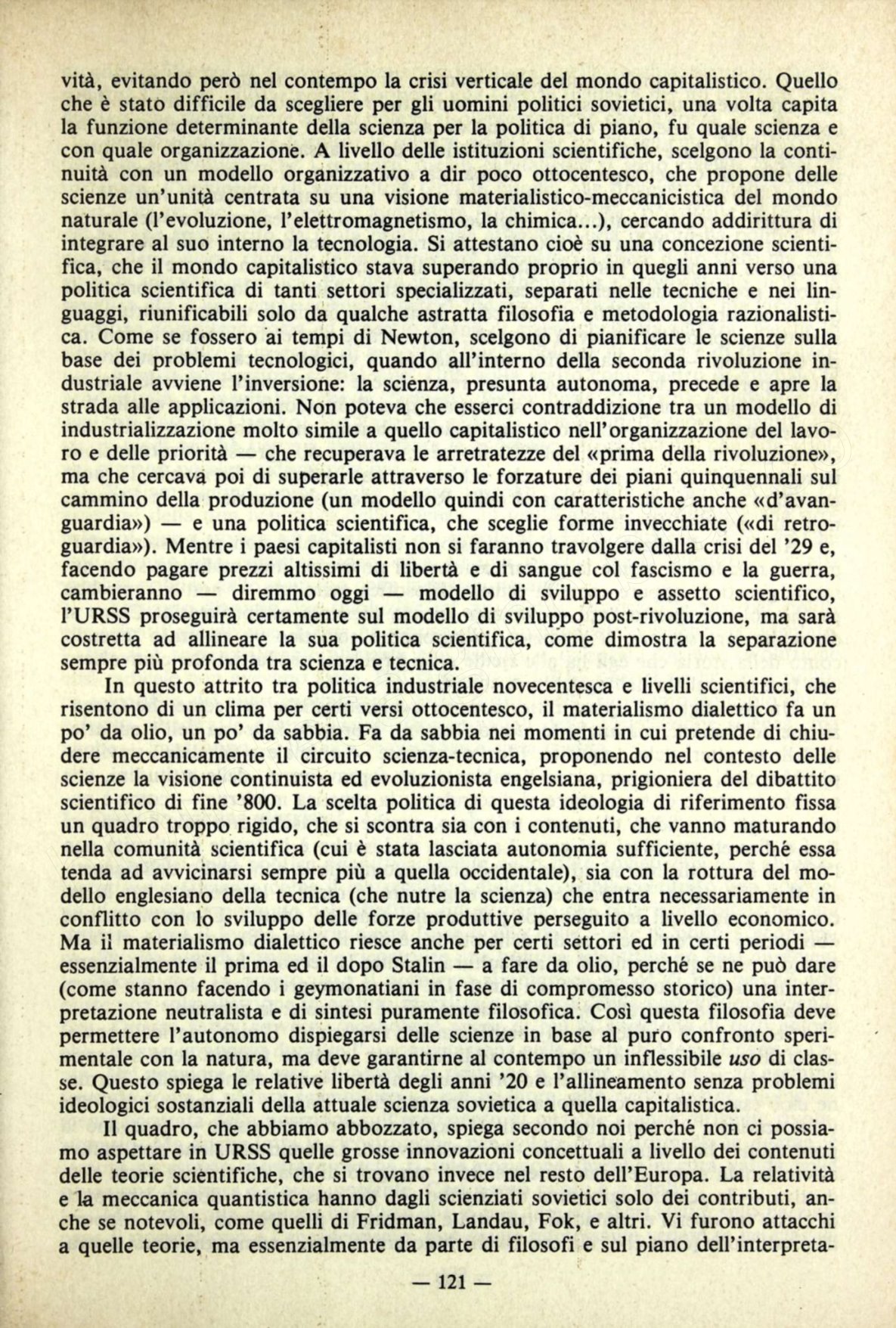
vità, evitando però nel contempo la crisi verticale del mondo capitalistico. Quello
cheè stato difficile da scegliere per gli uomini politici sovietici, una volta capita
la funzione determinante della scienza per la politica di piano, fu quale scienza e
conquale organizzazione. A livello delle istituzioni scientifiche, scelgono la conti-
nuità con un modello organizzativo a dir poco ottocentesco, che propone delle
scienze un'unità centrata su una visionematerialistico-meccanicistica del mondo
naturale (l'evoluzione, l'elettromagnetismo, la chimica...), cercando addirittura di
integrare al suo interno la tecnologia. Si attestano cioè su una concezione scienti-
fica, che il mondo capitalistico stava superando proprio in quegli anni verso una
politica scientifica di tanti settori specializzati, separati nelle tecniche e nei lin-
guaggi, riunificabili solo da qualche astratta filosofia e metodologia razionalisti-
ca. Come se fossero 'ai tempi di Newton, scelgono di pianificare le scienze sulla
base dei problemi tecnologici, quando all'interno della seconda rivoluzione in-
dustriale avviene l'inversione: la scienza, presunta autonoma, precede e apre la
strada alle applicazioni. Non poteva cheesserci contraddizione tra un modello di
industrializzazione molto simile a quello capitalistico nell'organizzazione del lavo-
ro e delle priorità — che recuperava le arretratezze del «prima della rivoluzione»,
mache cercava poi di superarle attraverso le forzature dei piani quinquennali sul
cammino della produzione (un modello quindi con caratteristiche anche «d'avan-
guardia») — e una politica scientifica, che sceglie forme invecchiate («di retro-
guardia»). Mentre i paesi capitalisti non si faranno travolgere dalla crisi del '29 e,
facendopagare prezzi altissimi di libertà e di sangue col fascismo e la guerra,
cambieranno — diremmo oggi — modello di sviluppo e assetto scientifico,
l'URSS proseguirà certamente sul modello di sviluppo post-rivoluzione, ma sarà
costretta ad allineare la sua politica scientifica, córne dimostra la separazione
semprepiù profonda tra scienza e tecnica.
In questo attrito tra politica industrialenovecentesca e livelli scientifici, che
risentono di un clima per certi versi ottocentesco, il materialismo dialettico fa un
po' da olio, un po' da sabbia. Fa da sabbia nei momenti in cui pretende di chiu-
deremeccanicamente i l circuito scienza-tecnica, proponendo nel contesto delle
scienze la visione continuista ed evoluzionista engelsiana, prigioniera del dibattito
scientifico di fine '800. La scelta politica di questa ideologia di riferimento fissa
unquadro troppo rigido, che si scontra sia con i contenuti, che vannomaturando
nella comunità scientifica (cui è stata lasciata autonomia sufficiente, perchéessa
tenda ad avvicinarsi sempre più a quella occidentale), sia con la rottura del mo-
delloenglesiano della tecnica (che nutre la scienza) che entra necessariamente in
conflitto con lo sviluppo delle forze produttive perseguito a livello economico.
Ma il materialismo dialettico riesce anche per certi settori ed in certi periodi
essenzialmente il prima ed il dopo Stalin — a fare da olio, perchése ne può dare
(comestanno facendo i geymonatiani in fase di compromessostorico) una inter-
pretazione neutralista e di sintesi puramente filosofica. Così questa filosofia deve
permettere l'autonomo dispiegarsi delle scienze in base al puro confronto speri-
mentale con la natura, ma deve garantirne al contempo un inflessibile
uso
di clas-
se.Questo spiega le relative libertà degli anni '20 e l'allineamento senza problemi
ideologici sostanziali della attuale scienzasovietica a quella capitalistica.
Il quadro, che abbiamo abbozzato, spiegasecondo noi perché non ci possia-
moaspettare in URSS quellegrosse innovazioni concettuali a livello dei contenuti
delle teorie scientifiche, che si trovano invece nel resto dell'Europa. La relatività
ela meccanica quantistica hanno dagli scienziati sovietici solo dei contributi, an-
chese notevoli, come quelli di Fridman, Landau, Fok, e altri. Vi furono attacchi
aquelle teorie, ma essenzialmente da parte di filosofi e sul piano dell'interpreta-
- 121—
















