
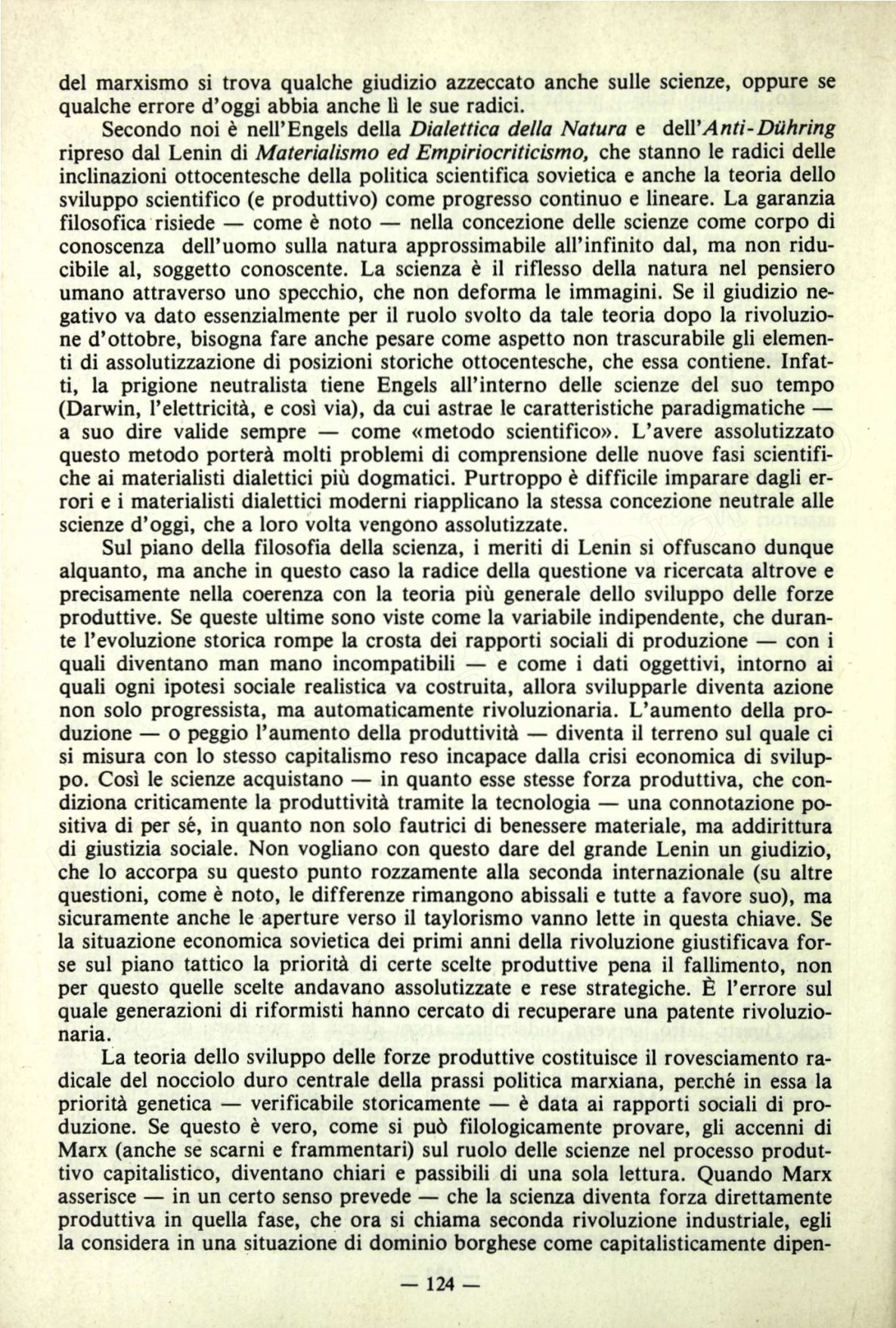
delmarxismo si trova qualche giudizio azzeccato anche sulle scienze, oppure se
qualche errore d'oggi abbia anche lì le sue radici.
Secondonoi è nell'Engels della Dialettica della Natura e dell'Anti-DiThring
ripreso dal Lenin di
Materialismo ed Empiriocriticismo,
che stanno le radici delle
inclinazioni ottocentesche della politica scientifica sovietica e anche la teoria dello
svilupposcientifico (e produttivo) comeprogressocontinuo e lineare. La garanzia
filosofica risiede — come è noto — nella concezione delle scienzecome corpo di
conoscenza dell'uomo sulla natura approssimabile all'infinito dal, ma non ridu-
cibile al, soggettoconoscente. La scienza è il riflesso della natura nel pensiero
umanoattraverso uno specchio, che non deforma le immagini. Se il giudizio ne-
gativo va dato essenzialmente per il ruolo svolto da tale teoria dopo la rivoluzio-
ned'ottobre, bisogna fare anchepesarecomeaspetto non trascurabile gli elemen-
ti di assolutizzazione di posizioni storicheottocentesche, cheessacontiene. Infat-
ti, la prigione neutralista tiene Engels all'interno delle scienze del suo tempo
(Darwin, l'elettricità, e così via), da cui astrae le caratteristiche paradigmatiche —
asuo dire valide sempre — come «metodo scientifico». L'avere assolutizzato
questometodo porterà molti problemi di comprensione delle nuove fasi scientifi-
cheai materialisti dialettici più dogmatici. Purtroppo è difficile imparare dagli er-
rori e i materialisti dialettici moderni riapplicano la stessaconcezioneneutrale alle
scienzed'oggi, che a loro volta vengonoassolutizzate.
Sul piano della filosofia della scienza, i meriti di Lenin si offuscano dunque
alquanto, ma anche in questocaso la radice della questione va ricercata altrove e
precisamente nella coerenza con la teoria più generale dello sviluppo delle forze
produttive. Se queste ultime sonovistecome la variabile indipendente, che duran-
te l'evoluzione storica rompe la crosta dei rapporti sociali di produzione — con i
quali diventano man mano incompatibili — e come i dati oggettivi, intorno ai
quali ogni ipotesi sociale realistica va costruita, allora svilupparle diventa azione
nonsolo progressista, ma automaticamente rivoluzionaria. L'aumento della pro-
duzione— o peggio l'aumento della produttività — diventa il terreno sul quale ci
simisura con lo stessocapitalismo reso incapace dalla crisi economica di svilup-
po. Così le scienzeacquistano— in quantoessestesse forza produttiva, che con-
diziona criticamente la produttività tramite la tecnologia — una connotazione po-
sitiva di per sé, in quanto non solo fautrici di benesseremateriale, ma addirittura
di giustizia sociale. Non vogliano con questo dare del grande Lenin un giudizio,
che lo accorpa su questo punto rozzamente alla seconda internazionale (su altre
questioni, come è noto, le differenze rimangono abissali e tutte a favore suo), ma
sicuramenteanche le aperture verso il taylorismo vanno lette in questa chiave. Se
la situazione economicasovietica dei primi anni della rivoluzione giustificava for-
sesul piano tattico la priorità di certe scelte produttive pena il fallimento, non
per questo quelle scelte andavano assolutizzate e rese strategiche. È l'errore sul
qualegenerazioni di riformisti hanno cercato di recuperare una patente rivoluzio-
naria.
La teoria dello sviluppo delle forze produttive costituisce il rovesciamento ra-
dicale del nocciolo duro centrale della prassi politica marxiana, perché in essa la
priorità genetica — verificabile storicamente — è data ai rapporti sociali di pro-
duzione. Se questo è vero, come si può filologicamente provare, gli accenni di
Marx (anchesescarni e frammentari) sul ruolo delle scienze nel processoprodut-
tivo capitalistico, diventano chiari e passibili di una sola lettura. Quando Marx
asserisce— in un certosensoprevede—che la scienza diventa forza direttamente
produttiva in quella fase, che ora si chiama seconda rivoluzione industriale, egli
laconsidera in una situazione di dominioborghesecomecapitalisticamente dipen-
- 124
















