
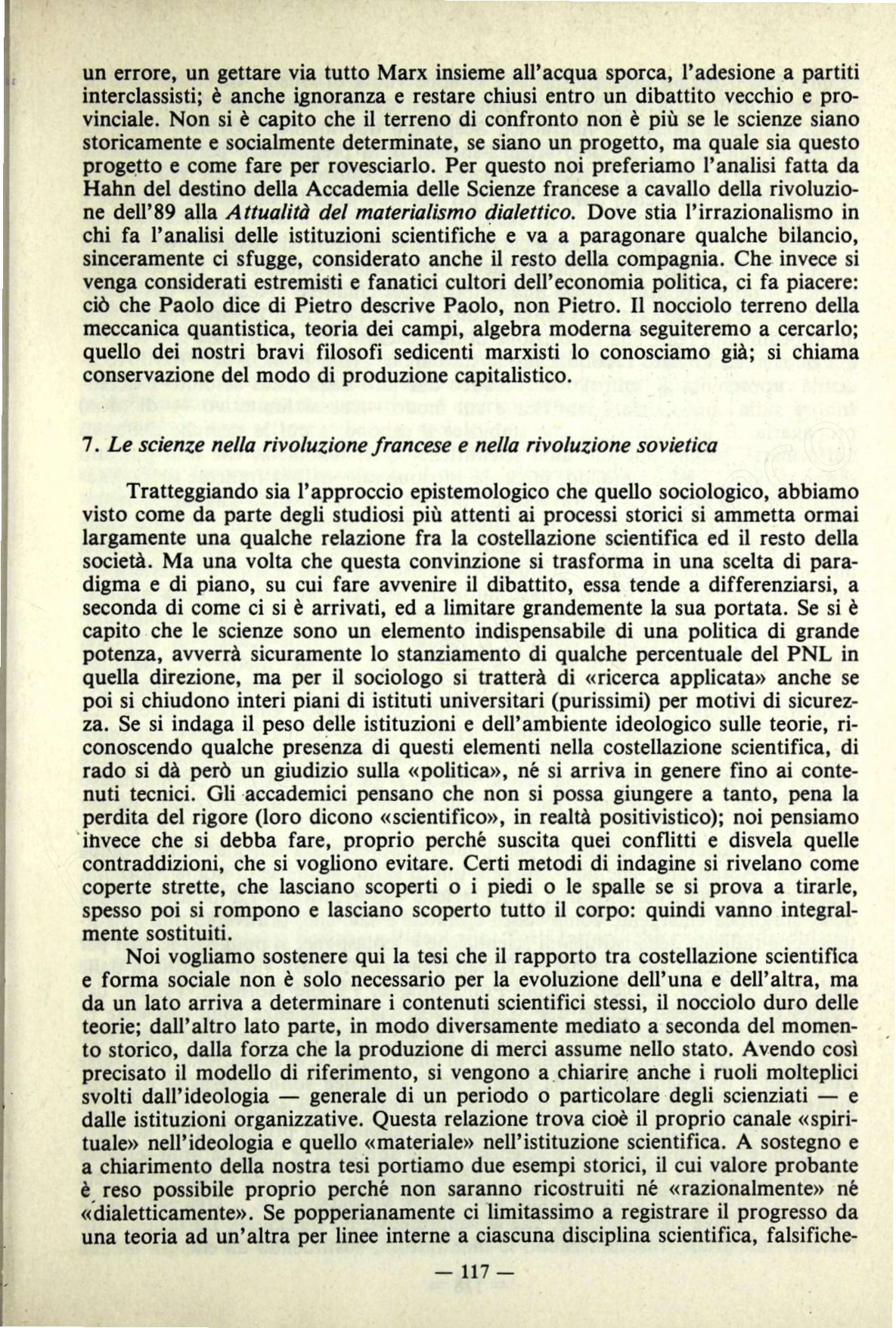
unerrore, un gettare via tutto Marx insieme all'acqua sporca, l'adesione a partiti
interclassisti; è anche ignoranza e restare chiusi entro un dibattito vecchio e pro-
vinciale. Non si è capito che il terreno di confronto non è più se le scienze siano
storicamente e socialmente determinate, se siano un progetto, ma quale sia questo
progetto e come fare per rovesciarlo. Per questo noi preferiamo l'analisi fatta da
Hahn del destino dellaAccademia delleScienze francese a cavallo della rivoluzio-
nedell'89 alla
Attualità del materialismo dialettico.
Dove stia l'irrazionalismo in
chi fa l'analisi delle istituzioni scientifiche e va a paragonare qualche bilancio,
sinceramente ci sfugge, considerato anche il resto della compagnia. Che invece si
vengaconsiderati estremisti e fanatici cultori dell'economia politica, ci fa piacere:
ciòche Paolo dice di Pietro descrive Paolo, non Pietro. I l nocciolo terreno della
meccanicaquantistica, teoria dei campi, algebramoderna seguiteremo a cercarlo;
quello dei nostri bravi filosofi sedicenti marxisti lo conosciamo già; si chiama
conservazionedel modo di produzione capitalistico.
7. Le scienze nella rivoluzione francese e nella rivoluzione sovietica
Tratteggiando sia l'approccio epistemologicoche quello sociologico, abbiamo
vistocome da parte degli studiosi più attenti ai processi storici si ammetta ormai
largamente una qualche relazione fra la costellazione scientifica ed il resto della
società. Ma una volta che questa convinzione si trasforma in una scelta di para-
digma e di piano, su cui fare avvenire il dibattito, essa tende a differenziarsi, a
seconda di come ci si è arrivati, ed a limitare grandemente la sua portata. Se si è
capito che le scienze sono un elemento indispensabile di una politica di grande
potenza, avverrà sicuramente lo stanziamento di qualche percentuale del PNL in
quella direzione, ma per il sociologo si tratterà di «ricerca applicata» anche se
poi si chiudono interi piani di istituti universitari (purissimi) per motivi di sicurez-
za. Se si indaga il peso delle istituzioni e dell'ambiente ideologico sulle teorie, ri-
conoscendoqualche presenza di questi elementi nella costellazione scientifica, di
rado si dà però un giudizio sulla «politica», né si arriva in genere fino ai conte-
nuti tecnici. Gli accademici pensano che non si possagiungere a tanto, pena la
perdita del rigore (loro dicono «scientifico», in realtà positivistico); noi pensiamo
invece che si debba fare, proprio perché suscita quei conflitti e disvela quelle
contraddizioni, che si vogliono evitare. Certi metodi di indagine si rivelano come
coperte strette, che lasciano scoperti o i piedi o le spalle se si prova a tirarle,
spessopoi si rompono e lasciano scoperto tutto il corpo: quindi vanno integral-
mente sostituiti.
Noi vogliamosostenere qui la tesi che il rapporto tra costellazione scientifica
eforma sociale non è solonecessario per la evoluzione dell'una e dell'altra, ma
da un lato arriva a determinare i contenuti scientifici stessi, il nocciolo duro delle
teorie; dall'altro lato parte, in mododiversamentemediato a secondadel momen-
to storico, dalla forza che la produzione di merci assumenello stato. Avendo così
precisato il modello di riferimento, si vengono a chiarire anche i ruoli molteplici
svolti dall'ideologia — generale di un periodo o particolare degli scienziati — e
dalle istituzioni organizzative. Questa relazione trova cioè il proprio canale «spiri-
tuale» nell'ideologia e quello «materiale» nell'istituzione scientifica. A sostegno e
achiarimento della nostra tesi portiamo dueesempi storici, il cui valore probante
èreso possibile proprio perché non saranno ricostruiti né «razionalmente» né
«dialetticamente». Se popperianamente ci limitassimo a registrare il progresso da
una teoria ad un'altra per linee interne a ciascunadisciplina scientifica, falsifiche-
117
















