
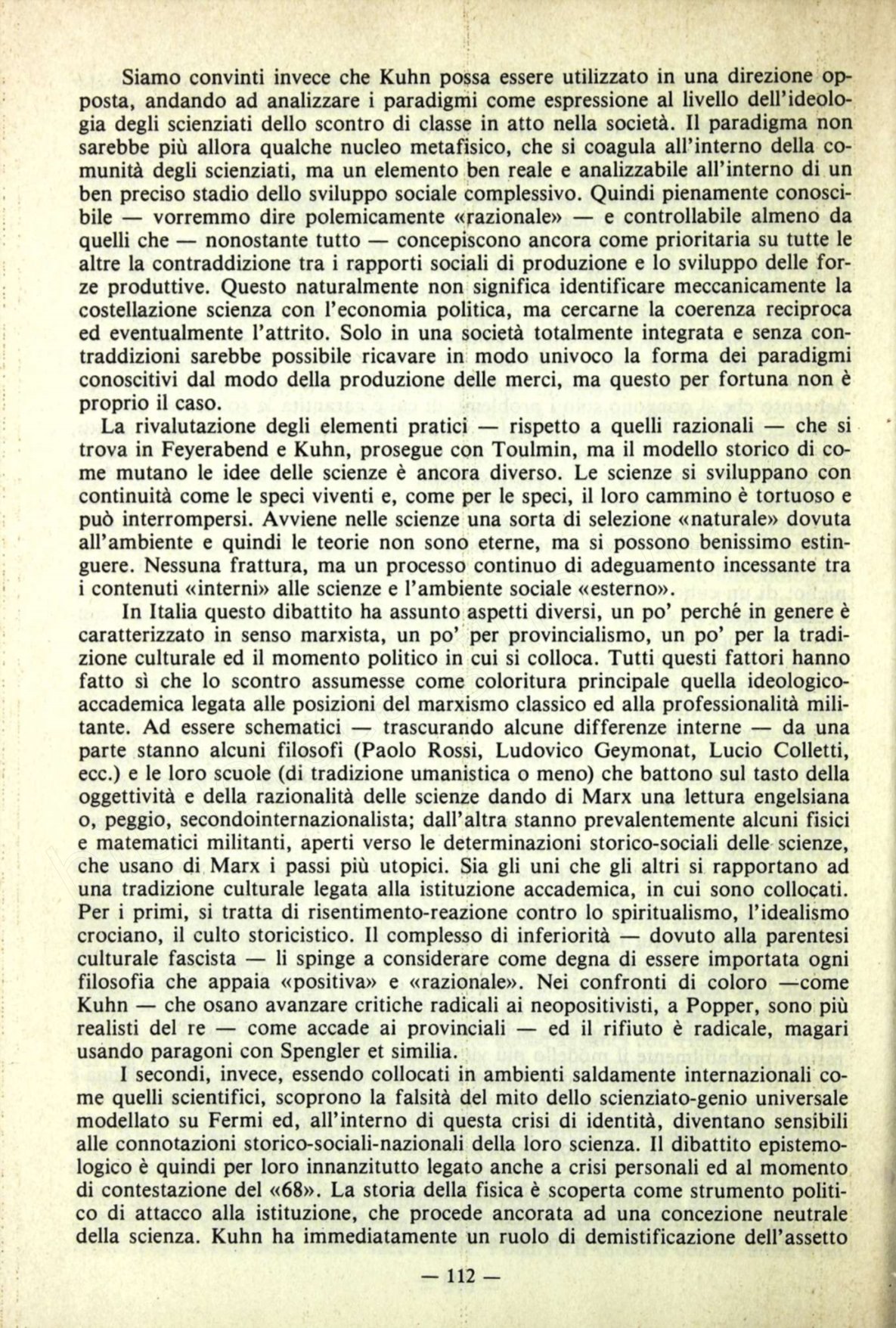
Siamo convinti invece che Kuhn possaessere utilizzato in una direzione op-
posta, andando ad analizzare i paradigmi come espressione al livello dell'ideolo-
gia degli scienziati dello scontro di classe in atto nella società. I l paradigma non
sarebbe più allora qualche nucleo metafisico, che si coagula all'interno della co-
munità degli scienziati, ma un elemento ben reale e analizzabile all'interno di un
benpreciso stadio dello sviluppo sociale complessivo. Quindi pienamente conosci-
bile — vorremmo dire polemicamente «razionale» — e controllabile almeno da
quelli che — nonostante tutto — concepiscono ancora come prioritaria su tutte le
altre la contraddizione tra i rapporti sociali di produzione e lo sviluppo delle for-
ze produttive. Questo naturalmente non significa identificare meccanicamente la
costellazione scienza con l'economia politica, ma cercarne la coerenza reciproca
edeventualmente l'attrito. Solo in una società totalmente integrata e senza con-
traddizioni sarebbe possibile ricavare in modo univoco la forma dei paradigmi
conoscitivi dal modo della produzione delle merci, ma questo per fortuna non è
proprio il caso.
La rivalutazione degli elementi pratici — rispetto a quelli razionali c h e si
trova in Feyerabend e Kuhn, prosegue con Toulmin, ma il modello storico di co-
memutano le idee delle scienze è ancora diverso. Le scienze si sviluppano con
continuità come le speci viventi e, come per le speci, il loro cammino è tortuoso e
può interrompersi. Avviene nelle scienze una sorta di selezione «naturale» dovuta
all'ambiente e quindi le teorie non sono eterne, ma si possono benissimo estin-
guere. Nessuna frattura, ma un processo continuo di adeguamento incessante tra
i contenuti «interni» alle scienze e l'ambiente sociale «esterno».
In Italia questo dibattito ha assunto aspetti diversi, un po' perché in genere è
caratterizzato in sensomarxista, un po' per provincialismo, un po' per la tradi-
zione culturale ed il momento politico in cui si colloca. Tutti questi fattori hanno
fatto sì che lo scontro assumesse come coloritura principale quella ideologico-
accademica legata alle posizioni del marxismo classico ed alla professionalità mili-
tante. Ad essere schematici — trascurando alcune differenze interne — da una
parte stanno alcuni filosofi (Paolo Rossi, Ludovico Geymonat, Lucio Colletti,
ecc.) e le loro scuole (di tradizione umanistica o meno) che battono sul tasto della
oggettività e della razionalità delle scienze dando di Marx una lettura engelsiana
o, peggio, secondointernazionalista; dall'altra stanno prevalentemente alcuni fisici
ematematici militanti, aperti verso le determinazioni storico-sociali delle scienze,
cheusano di Marx i passi più utopici. Sia gli uni che gli altri si rapportano ad
una tradizione culturale legata alla istituzione accademica, in cui sono collocati.
Per i primi, si tratta di risentimento-reazione contro lo spiritualismo, l'idealismo
crociano, il culto storicistico. I l complesso di inferiorità — dovuto alla parentesi
culturale fascista — li spinge a considerare come degna di essere importata ogni
filosofia che appaia «positiva» e «razionale». Nei confronti di coloro —come
Kuhn — che osano avanzare critiche radicali ai neopositivisti, a Popper, sono più
realisti del re — come accade ai provinciali — ed il rifiuto è radicale, magari
usandoparagoni con Spengler et similia.
I secondi, invece, essendo collocati in ambienti saldamente internazionali co-
me quelli scientifici, scoprono la falsità del mito dello scienziato-genio universale
modellato su Fermi ed, all'interno di questa crisi di identità, diventano sensibili
alle connotazioni storico-sociali-nazionali della loro scienza. I l dibattito epistemo-
logico è quindi per loro innanzitutto legato anche a crisi personali ed al momento
di contestazione del «68». La storia della fisica è scoperta come strumento politi-
co di attacco alla istituzione, che procede ancorata ad una concezione neutrale
della scienza. Kuhn ha immediatamente un ruolo di demistificazione dell'assetto
112
















