
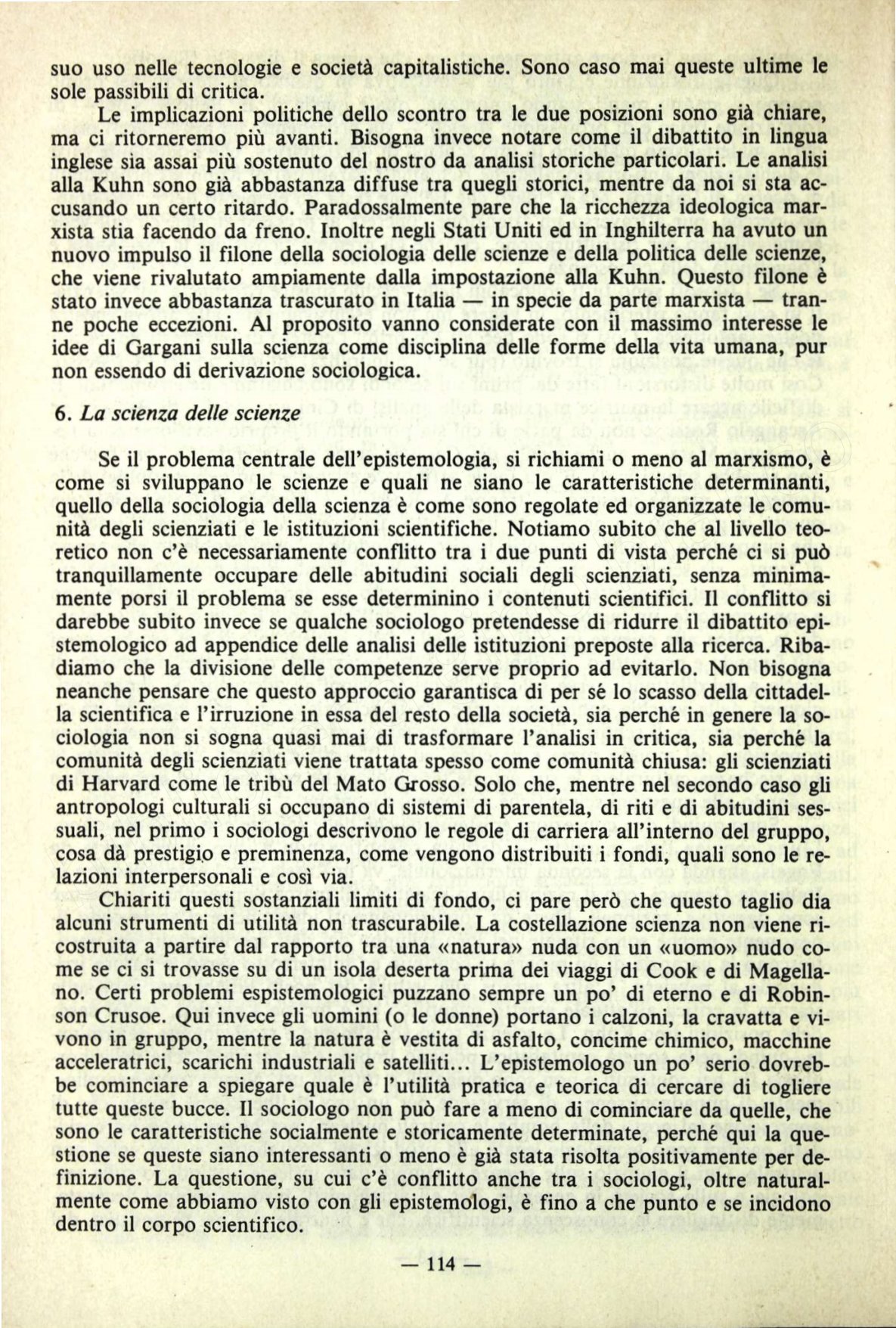
suouso nelle tecnologie e società capitalistiche. Sono caso mai queste ultime le
solepassibili di critica.
Le implicazioni politiche dello scontro tra le due posizioni sono già chiare,
ma ci ritorneremo più avanti. Bisogna invece notare come il dibattito in lingua
inglesesia assai più sostenuto del nostro da analisi storiche particolari. Le analisi
alla Kuhn sono già abbastanza diffuse tra quegli storici, mentre da noi si sta ac-
cusandoun certo ritardo. Paradossalmente pare che la ricchezza ideologica mar-
xista stia facendo da freno. Inoltre negli Stati Uniti ed in Inghilterra ha avuto un
nuovo impulso il filone della sociologia delle scienze e della politica delle scienze,
cheviene rivalutato ampiamente dalla impostazione alla Kuhn. Questo filone è
stato inveceabbastanza trascurato in Italia — in specie da parte marxista — tran-
nepoche eccezioni. Al proposito vanno considerate con il massimo interesse le
idee di Gargani sulla scienza come disciplina delle forme della vita umana, pur
nonessendo di derivazione sociologica.
6. La scienzadelle scienze
Se il problema centrale dell'epistemologia, si richiami o meno al marxismo, è
come si sviluppano le scienze e quali ne siano le caratteristiche determinanti,
quello della sociologia della scienza è come sono regolate ed organizzate le comu-
nità degli scienziati e le istituzioni scientifiche. Notiamo subito che al livello teo-
retico non c'è necessariamente conflitto tra i due punti di vista perché ci si può
tranquillamente occupare delle abitudini sociali degli scienziati, senza minima-
menteporsi il problema seessedeterminino i contenuti scientifici. I l conflitto si
darebbesubito invecesequalche sociologopretendesse di ridurre il dibattito epi-
stemologico ad appendice delle analisi delle istituzioni preposte alla ricerca. Riba-
diamo che la divisione delle competenze serve proprio ad evitarlo. Non bisogna
neanchepensarechequestoapprocciogarantisca di per sé lo scassodella cittadel-
la scientifica e l'irruzione in essadel resto della società, sia perché in genere la sa
ciologia non si sogna quasi mai di trasformare l'analisi in critica, sia perché la
comunitàdegli scienziati viene trattataspessocome comunità chiusa: gli scienziati
di Harvard come le tribù del Mato Grosso. Solo che, mentre nel secondocaso gli
antropologi culturali si occupano di sistemi di parentela, di riti e di abitudini ses-
suali, nel primo i sociologi descrivono le regole di carriera all'interno del gruppo,
cosadà prestigio e preminenza, comevengono distribuiti i fondi, quali sono le re-
lazioni interpersonali e così via.
Chiariti questi sostanziali limiti di fondo, ci pare però che questo taglio dia
alcuni strumenti di utilità non trascurabile. La costellazione scienza non viene ri-
costruita a partire dal rapporto tra una «natura» nuda con un «uomo» nudo co-
mese ci si trovassesu di un isola deserta prima dei viaggi di Cook e di Magella-
no. Certi problemi espistemologici puzzano sempre un po' di eterno e di Robin-
sonCrusoe. Qui invece gli uomini (o le donne) portano i calzoni, la cravatta e vi-
vono in gruppo, mentre la natura è vestita di asfalto, concime chimico, macchine
acceleratrici, scarichi industriali e satelliti... L'epistemologo un po' serio dovreb-
becominciare a spiegare quale è l'utilità pratica e teorica di cercare di togliere
tuttequestebucce. Il sociologo non può fare a meno di cominciare da quelle, che
sono le caratteristiche socialmente e storicamente determinate, perché qui la que-
stionesequestesiano interessanti o meno è già stata risolta positivamente per de-
finizione. La questione, su cui c'è conflitto anche tra i sociologi, oltre natural-
mentecome abbiamo visto con gli epistemologi, è fino a che punto e se incidono
dentro il corpo scientifico.
11 4 -
















