
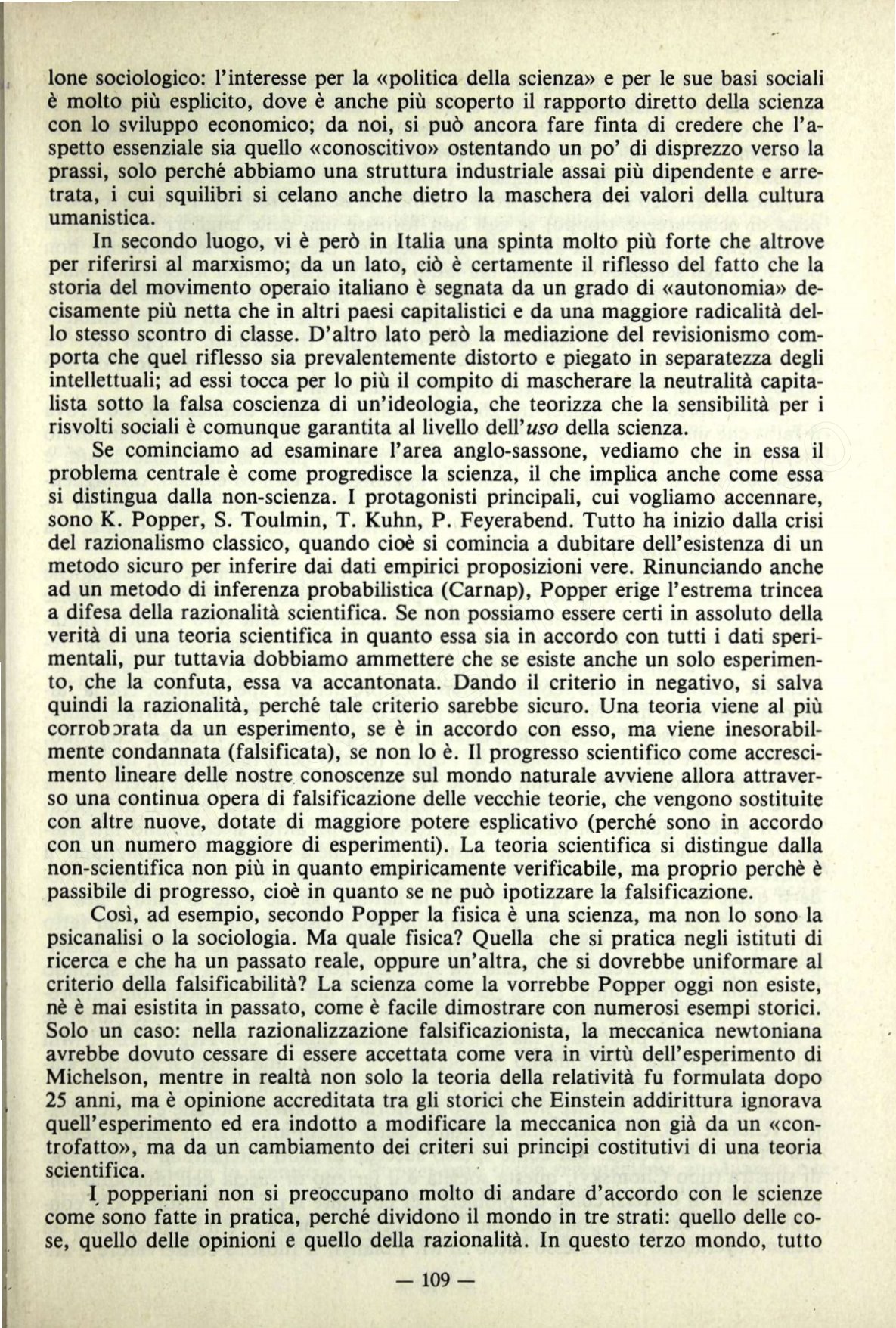
lonesociologico: l'interesse per la «politica della scienza» e per le suebasi sociali
èmolto più esplicito, dove è anche più scoperto il rapporto diretto della scienza
con lo sviluppo economico; da noi, si può ancora fare finta di credere che l'a-
spettoessenziale sia quello «conoscitivo» ostentando un po' di disprezzoverso la
prassi, solo perché abbiamo una struttura industriale assai più dipendente e arre-
trata, i cui squilibri si celano anche dietro la maschera dei valori della cultura
umanistica.
In secondo luogo, vi è però in Italia una spinta molto più forte che altrove
per riferirsi al marxismo; da un lato, ciò è certamente il riflesso del fatto che la
storia del movimento operaio italiano è segnata da un grado di «autonomia» de-
cisamentepiù netta che in altri paesi capitalistici e da unamaggiore radicalità del-
lostessoscontro di classe. D'altro lato però la mediazione del revisionismo com-
porta che quel riflesso sia prevalentemente distorto e piegato in separatezza degli
intellettuali; ad essi tocca per lo più il compito di mascherare la neutralità capita-
lista sotto la falsa coscienza di un'ideologia, che teorizza che la sensibilità per i
risvolti sociali è comunque garantita al livello
dell'uso
della scienza.
Secominciamo ad esaminare l'area anglo-sassone, vediamo che in essa i l
problema centrale è come progredisce la scienza, il che implica anche comeessa
sidistingua dalla non-scienza. I protagonisti principali, cui vogliamo accennare,
sonoK. Popper, S. Toulmin, T. Kuhn, P. Feyerabend. Tutto ha inizio dalla crisi
del razionalismo classico, quando cioè si comincia a dubitare dell'esistenza di un
metodosicuro per inferire dai dati empirici proposizioni vere. Rinunciando anche
adun metodo di inferenza probabilistica (Carnap), Popper erige l'estrema trincea
adifesa della razionalità scientifica. Se nonpossiamoesserecerti in assoluto della
verità di una teoria scientifica in quantoessasia in accordo con tutti i dati speri-
mentali, pur tuttavia dobbiamo ammettere cheseesisteanche un soloesperimen-
to, che la confuta, essa va accantonata. Dando il criterio in negativo, si salva
quindi la razionalità, perché tale criterio sarebbe sicuro. Una teoria viene al più
corrobDrata da un esperimento, se è in accordo con esso, ma viene inesorabil-
mentecondannata (falsificata), se non lo è. Il progressoscientificocomeaccresci-
mento lineare delle nostreconoscenzesul mondo naturale avviene allora attraver-
souna continua opera di falsificazione dellevecchie teorie, che vengonosostituite
con altre nuove, dotate di maggiore potere esplicativo (perché sono in accordo
con un numeromaggiore di esperimenti). La teoria scientifica si distingue dalla
non-scientifica non più in quanto empiricamente verificabile, ma proprio perché è
passibile di progresso, cioè in quantosene può ipotizzare la falsificazione.
Così, ad esempio, secondoPopper la fisica è una scienza, ma non lo sono la
psicanalisi o la sociologia. Ma quale fisica? Quella che si pratica negli istituti di
ricerca e che ha un passato reale, oppure un'altra, che si dovrebbe uniformare al
criterio della falsificabilità? La scienzacome la vorrebbe Popper oggi non esiste,
nèè mai esistita in passato, come è facile dimostrare connumerosi esempi storici.
Solo un caso: nella razionalizzazione falsificazionista, la meccanica newtoniana
avrebbe dovutocessare di essereaccettata come vera in virtù dell'esperimento di
Michelson, mentre in realtà non solo la teoria della relatività fu formulata dopo
25anni, ma è opinione accreditata tra gli storici che Einstein addirittura ignorava
quell'esperimento ed era indotto a modificare la meccanica non già da un «con-
trofatto», ma da un cambiamento dei criteri sui principi costitutivi di una teoria
scientifica.
popperiani non si preoccupano molto di andare d'accordo con le scienze
comesono fatte in pratica, perché dividono il mondo in tre strati: quello delle co-
se, quello delle opinioni e quello della razionalità. In questo terzo mondo, tutto
109—
















