
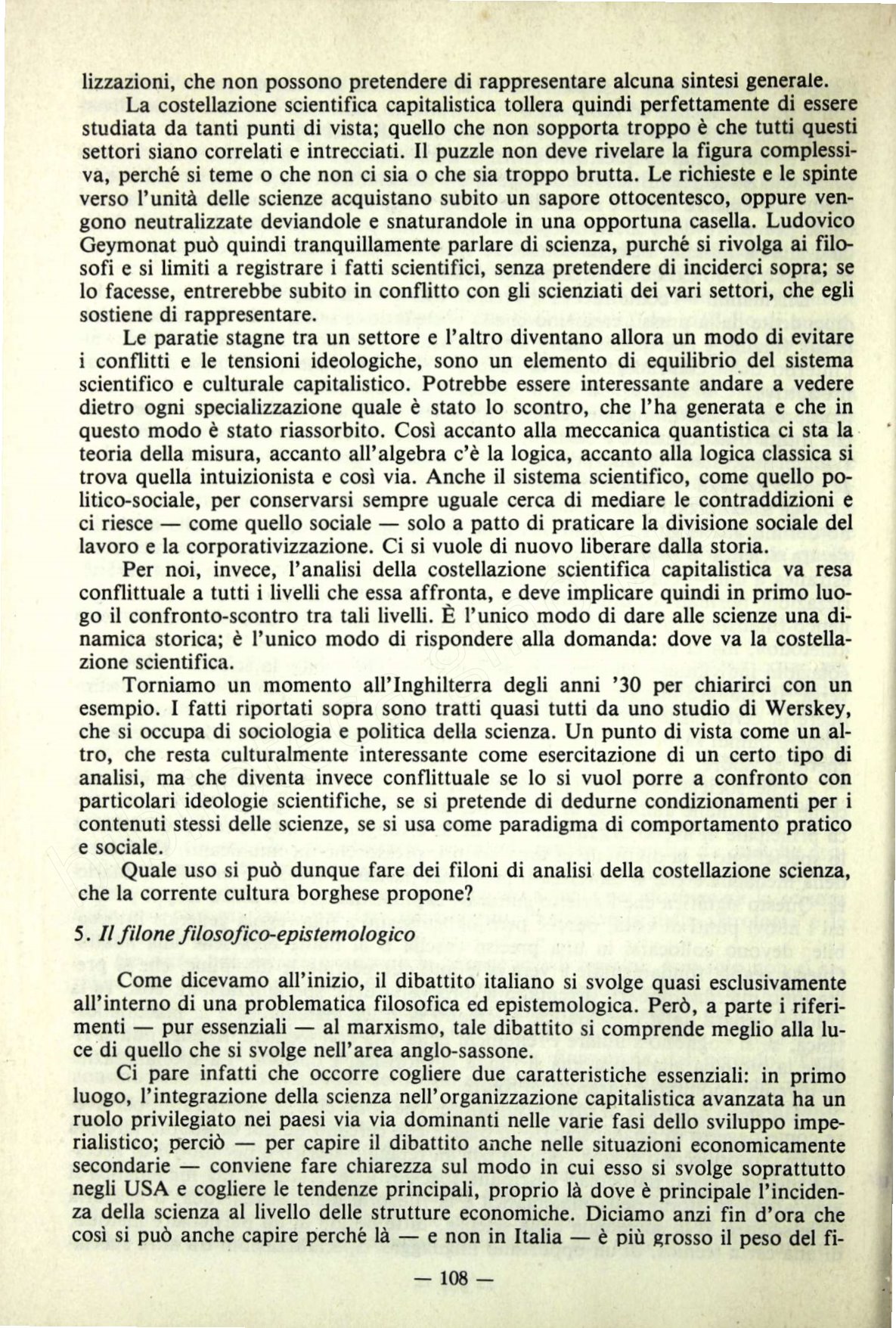
lizzazioni, che nonpossonopretendere di rappresentare alcuna sintesi generale.
La costellazione scientifica capitalistica tollera quindi perfettamente di essere
studiata da tanti punti di vista; quello che non sopporta troppo è che tutti questi
settori siano correlati e intrecciati. Il puzzle non deve rivelare la figura complessi-
va, perché si teme o che non ci sia o chesia troppo brutta. Le richieste e le spinte
verso l'unità delle scienzeacquistano subito un saporeottocentesco, oppure ven-
gononeutralizzate deviandole e snaturandole in una opportuna casella. Ludovico
Geymonat può quindi tranquillamente parlare di scienza, purché si rivolga ai filo-
sofi e si limiti a registrare i fatti scientifici, senzapretendere di inciderci sopra; se
lo facesse, entrerebbe subito in conflitto con gli scienziati dei vari settori, che egli
sostiene di rappresentare.
Le paratie stagne tra un settore e l'altro diventano allora un modo di evitare
i conflitti e le tensioni ideologiche, sono un elemento di equilibrio del sistema
scientifico e culturale capitalistico. Potrebbe essere interessante andare a vedere
dietro ogni specializzazione quale è stato lo scontro, che l'ha generata e che in
questomodo è stato riassorbito. Così accanto allameccanicaquantistica ci sta la
teoria dellamisura, accanto all'algebra c'è la logica, accanto alla logicaclassica si
trova quella intuizionista e così via. Anche il sistema scientifico, come quello po-
litico-sociale, per conservarsi sempre uguale cerca di mediare le contraddizioni e
ci riesce—come quello sociale — solo a patto di praticare la divisione sociale del
lavoro e la corporativizzazione. Ci si vuole di nuovo liberare dalla storia.
Per noi, invece, l'analisi della costellazione scientifica capitalistica va resa
conflittuale a tutti i livelli cheessa affronta, e deve implicare quindi in primo luo-
go il confronto-scontro tra tali livelli. È l'unico modo di dare alle scienze una di-
namica storica; è l'unico modo di rispondere alla domanda: dove va la costella-
zione scientifica.
Torniamo un momento all'Inghilterra degli anni '30 per chiarirci con un
esempio. I fatti riportati sopra sono tratti quasi tutti da uno studio di Werskey,
chesi occupa di sociologia e politica della scienza. Un punto di vista come un al-
tro, che resta culturalmente interessante come esercitazione di un certo tipo di
analisi, ma che diventa invece conflittuale se lo si vuol porre a confronto con
particolari ideologie scientifiche, se si pretende di dedurne condizionamenti per i
contenuti stessi delle scienze, se si usacomeparadigma di comportamento pratico
esociale.
Qualeuso si può dunque fare dei filoni di analisi della costellazione scienza,
che la corrente culturaborghesepropone?
5. I l filone filosofico-epistemologico
Comedicevamo all'inizio, il dibattito italiano si svolge quasi esclusivamente
all'interno di una problematica filosoficaedepistemologica. Però, a parte i riferi-
menti — pur essenziali — al marxismo, tale dibattito si comprendemeglio alla lu-
cedi quello che si svolge nell'area anglo-sassone.
Ci pare infatti che occorre cogliere due caratteristiche essenziali: in primo
luogo, l'integrazione della scienzanell'organizzazione capitalistica avanzata ha un
ruolo privilegiato nei paesi via via dominanti nelle varie fasi dello sviluppo impe-
rialistico; perciò — per capire il dibattito anche nelle situazioni economicamente
secondarie — conviene fare chiarezza sul modo in cui esso si svolge soprattutto
negli USA e cogliere le tendenze principali, proprio là dove è principale l'inciden-
za della scienza al livello delle strutture economiche. Diciamo anzi fin d'ora che
così si può anche capire perché là e non in Italia è più grosso il pesodel fi-
108
















