
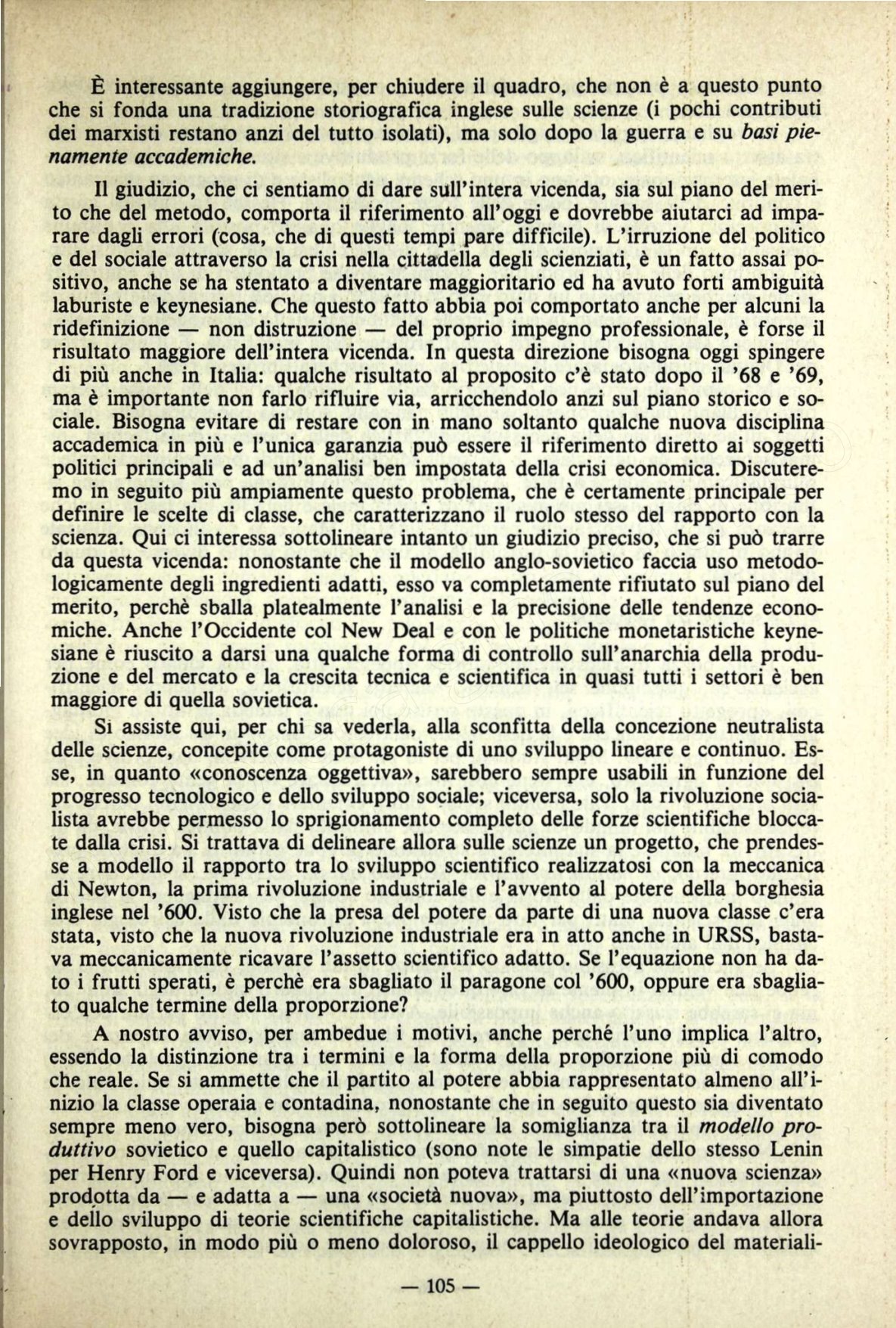
È interessanteaggiungere, per chiudere il quadro, che non è a questo punto
chesi fonda una tradizione storiografica inglese sulle scienze (i pochi contributi
dei marxisti restano anzi del tutto isolati), ma solo dopo la guerra e su
basi pie-
namenteaccademiche.
Il giudizio, che ci sentiamo di dare sull'intera vicenda, sia sul piano del meri-
to che del metodo, comporta il riferimento all'oggi e dovrebbe aiutarci ad impa-
rare dagli errori (cosa, che di questi tempi pare difficile). L'irruzione del politico
edel sociale attraverso la crisi nella cittadella degli scienziati, è un fatto assai po-
sitivo, anchese ha stentato a diventaremaggioritario ed ha avuto forti ambiguità
laburiste e keynesiane. Che questo fatto abbia poi comportato anche per alcuni la
ridefinizione — non distruzione — del proprio impegno professionale, è forse il
risultatomaggiore dell'intera vicenda. In questa direzione bisogna oggi spingere
di più anche in Italia: qualche risultato al proposito c'è stato dopo il '68 e '69,
maè importante non farlo rifluire via, arricchendolo anzi sul piano storico e so-
ciale. Bisogna evitare di restare con in mano soltanto qualche nuova disciplina
accademica in più e l'unica garanzia può essere il riferimento diretto ai soggetti
politici principali e ad un'analisi ben impostata della crisi economica. Discutere-
mo in seguito più ampiamente questo problema, che è certamente principale per
definire le scelte di classe, che caratterizzano il ruolo stesso del rapporto con la
scienza. Qui ci interessa sottolineare intanto un giudizio preciso, che si può trarre
daquesta vicenda: nonostante che il modello anglo-sovietico faccia usometodo-
logicamentedegli ingredienti adatti, esso va completamente rifiutato sul piano del
merito, perché sballa platealmente l'analisi e la precisione delle tendenze econo-
miche. Anche l'Occidente col New Deal e con le politichemonetaristiche keyne-
sianeè riuscito a darsi una qualche forma di controllo sull'anarchia della produ-
zione e del mercato e la crescita tecnica e scientifica in quasi tutti i settori è ben
maggiore di quella sovietica.
Siassiste qui, per chi sa vederla, alla sconfitta della concezione neutralista
dellescienze, concepitecomeprotagoniste di uno sviluppo lineare e continuo. Es-
se, in quanto «conoscenza oggettiva», sarebbero sempre usabili in funzione del
progressotecnologico e dello svilupposociale; viceversa, solo la rivoluzione socia-
lista avrebbepermesso lo sprigionamento completo delle forze scientificheblocca-
tedalla crisi. Si trattava di delineare allora sullescienze un progetto, cheprendes-
sea modello il rapporto tra lo sviluppo scientifico realizzatosi con la meccanica
di Newton, la prima rivoluzione industriale e l'avvento al potere della borghesia
inglese nel '600. Visto che la presa del potere da parte di una nuovaclasse c'era
stata, visto che la nuova rivoluzione industriale era in atto anche in URSS, basta-
vameccanicamente ricavare l'assetto scientifico adatto. Se l'equazione non ha da-
to i frutti sperati, è perché era sbagliato il paragone col '600, oppure era sbaglia-
toqualche termine della proporzione?
A nostro avviso, per ambedue i motivi, anche perché l'uno implica l'altro,
essendo la distinzione tra i termini e la forma della proporzione più di comodo
chereale. Se si ammette che il partito al potere abbia rappresentato almeno all'i-
nizio la classeoperaia e contadina, nonostante che in seguitoquesto sia diventato
sempremeno vero, bisogna però sottolineare la somiglianza tra il
modello pro-
duttivo
sovietico e quello capitalistico (sono note le simpatie dello stesso Lenin
per Henry Ford e viceversa). Quindi non poteva trattarsi di una «nuova scienza»
prodotta da — e adatta a — una «società nuova», ma piuttosto dell'importazione
edello sviluppo di teorie scientifiche capitalistiche. Ma alle teorie andava allora
sovrapposto, in modo più o meno doloroso, il cappello ideologico del materiali-
-105
















