
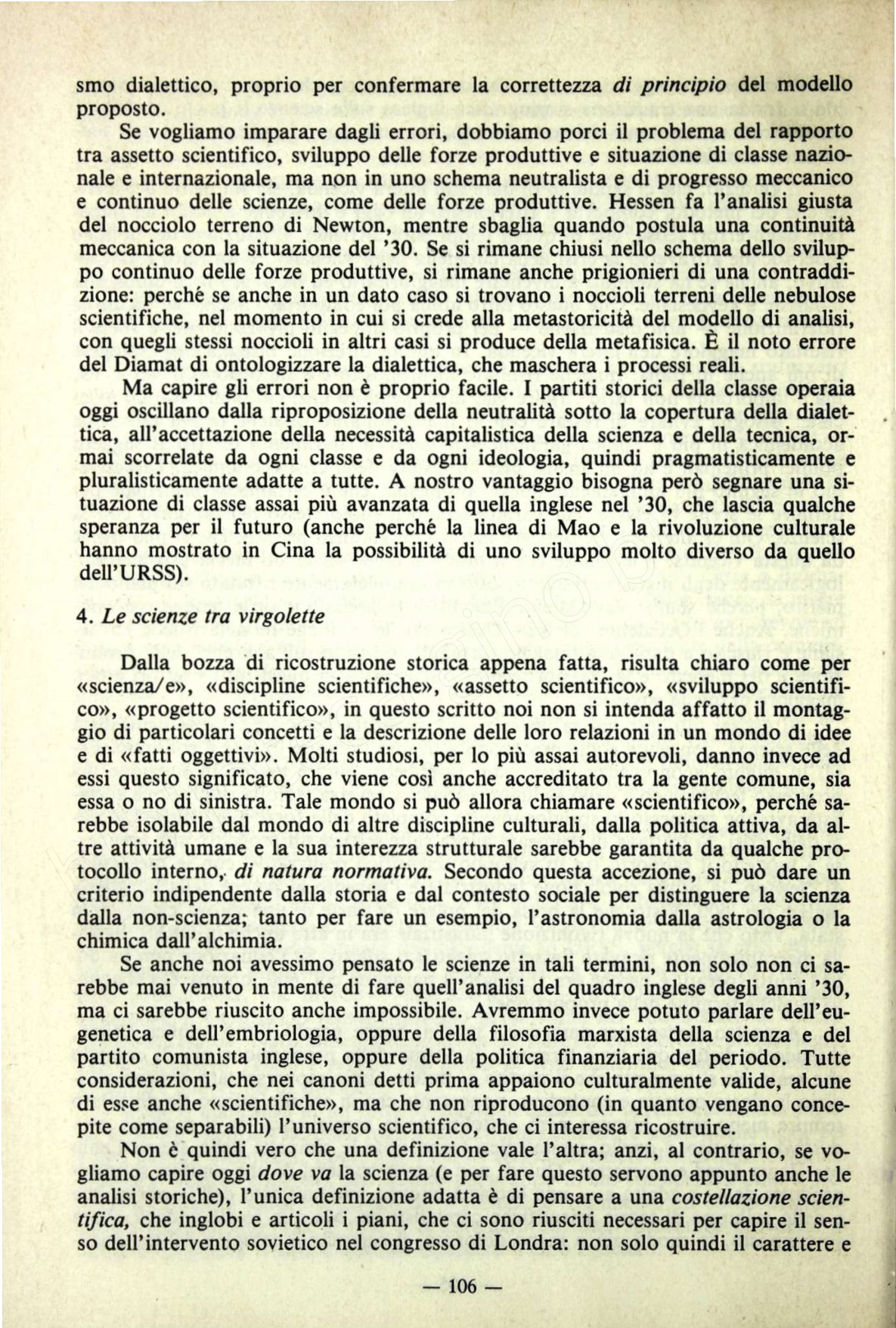
smodialettico, proprio per confermare la correttezza
di principio
del modello
proposto.
Sevogliamo imparare dagli errori, dobbiamo porci il problema del rapporto
tra assetto scientifico, sviluppo delle forze produttive e situazione di classe nazio-
nale e internazionale, ma non in unoschemaneutralista e di progressomeccanico
econtinuo delle scienze, come delle forze produttive. Hessen fa l'analisi giusta
del nocciolo terreno di Newton, mentre sbaglia quando postula una continuità
meccanicacon la situazione del '30. Se si rimane chiusi nello schema dello svilup-
pocontinuo delle forze produttive, si rimane anche prigionieri di una contraddi-
zione: perché seanche in un dato caso si trovano i noccioli terreni delle nebulose
scientifiche, nel momento in cui si crede alla metastoricità del modello di analisi,
conquegli stessi noccioli in altri casi si produce della metafisica. È il noto errore
del Diamat di ontologizzare la dialettica, chemaschera i processi reali.
Ma capire gli errori non è proprio facile. I partiti storici della classe operaia
oggioscillano dalla riproposizione della neutralità sotto la copertura della dialet-
tica, all'accettazione della necessità capitalistica della scienza e della tecnica, or-
mai scorrelate da ogni classe e da ogni ideologia, quindi pragmatisticamente e
pluralisticamente adatte a tutte. A nostro vantaggiobisogna però segnare una si-
tuazione di classeassai più avanzata di quella inglese nel '30, che lascia qualche
speranza per il futuro (anche perché la linea di Mao e la rivoluzione culturale
hannomostrato in Cina la possibilità di uno sviluppo molto diverso da quello
dell'URSS).
4. Le scienze tra virgolette
Dalla bozza di ricostruzione storica appena fatta, risulta chiaro come per
«scienza/e», «discipline scientifiche», «assetto scientifico», «sviluppo scientifi-
co», «progetto scientifico», in questo scritto noi non si intenda affatto il montag-
gio di particolari concetti e la descrizione delle loro relazioni in unmondo di idee
edi «fatti oggettivi». Molti studiosi, per lo più assai autorevoli, danno invece ad
essiquesto significato, che viene così anche accreditato tra la gente comune, sia
essao no di sinistra. Tale mondo si può allora chiamare «scientifico», perché sa-
rebbe isolabile dal mondo di altre discipline culturali, dalla politica attiva, da al-
tre attività umane e la sua interezza strutturale sarebbe garantita da qualche pro-
tocollo interno,.
di natura normativa.
Secondo questa accezione, si può dare un
criterio indipendente dalla storia e dal contesto sociale per distinguere la scienza
dalla non-scienza; tanto per fare un esempio, l'astronomia dalla astrologia o la
chimica dall'alchimia.
Seanche noi avessimopensato le scienze in tali termini, non solo non ci sa-
rebbemai venuto in mente di fare quell'analisi del quadro inglese degli anni '30,
ma ci sarebbe riuscito anche impossibile. Avremmo invece potuto parlare dell'eu-
genetica e dell'embriologia, oppure della filosofia marxista della scienza e del
partito comunista inglese, oppure della politica finanziaria del periodo. Tutte
considerazioni, che nei canoni detti prima appaiono culturalmente valide, alcune
diesseanche «scientifiche», ma che non riproducono (in quanto venganoconce-
pitecome separabili) l'universo scientifico, che ci interessa ricostruire.
Non è quindi vero che una definizione vale l'altra; anzi, al contrario, se vo-
gliamo capire oggi
dove va
la scienza (e per fare questoservono appunto anche le
analisi storiche), l'unica definizione adatta è di pensare a una
costellazionescien-
tifica,
che inglobi e articoli i piani, che ci sono riusciti necessari per capire il sen-
sodell'intervento sovietico nel congresso di Londra: non solo quindi il carattere e
1 0 6 -
















