
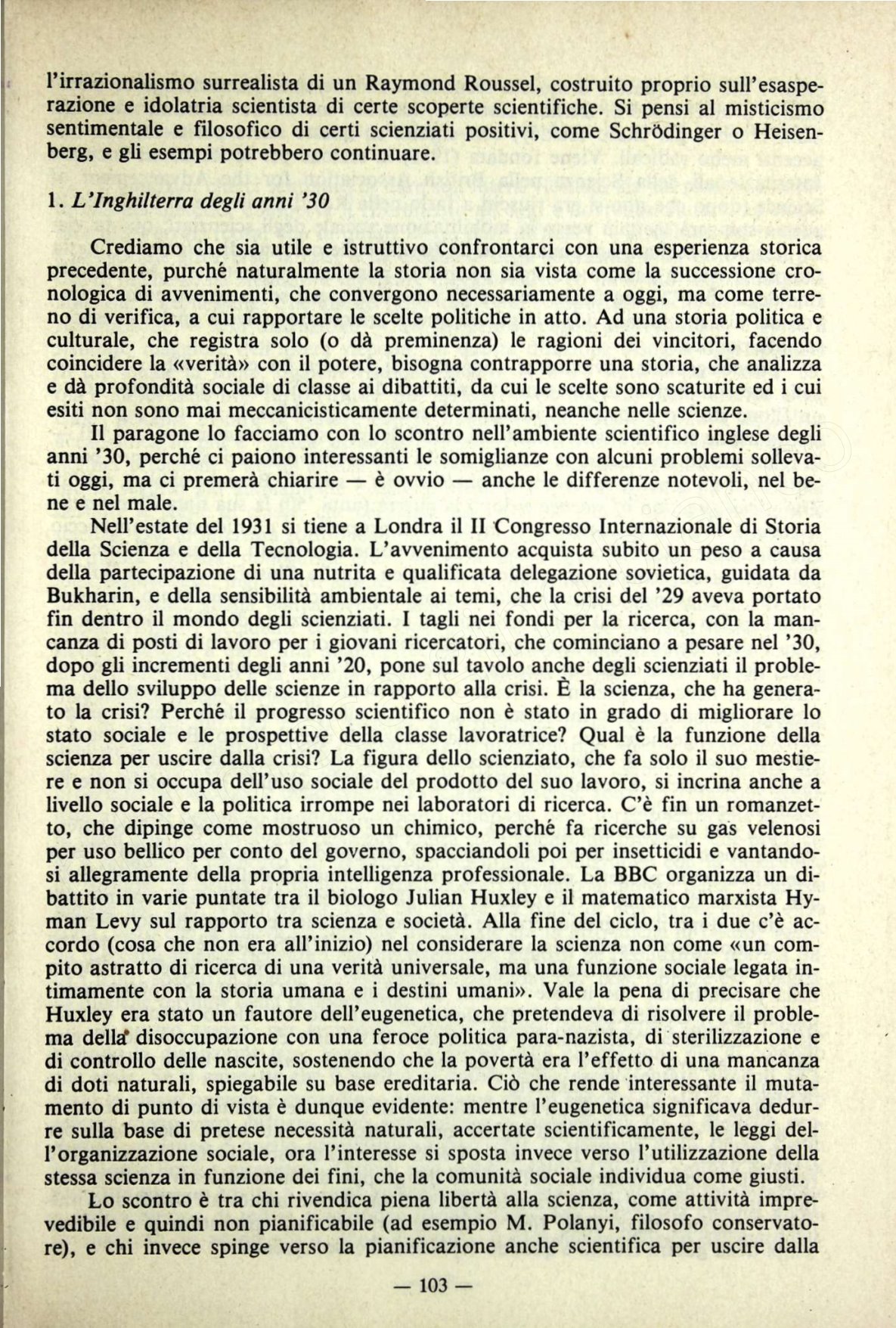
4l'irrazionalismo surrealista di un Raymond Roussel, costruito proprio sull'esaspe-
razione e idolatria scientista di certe scoperte scientifiche. Si pensi al misticismo
sentimentale e filosofico di certi scienziati positivi, come Schrodinger o Heisen-
berg, e gli esempi potrebbero continuare.
1. L'Inghilterra degli anni '30
Crediamo che sia utile e istruttivo confrontarci con una esperienza storica
precedente, purché naturalmente la storia non sia vista come la successione cro-
nologica di avvenimenti, che convergono necessariamente a oggi, ma come terre-
no di verifica, a cui rapportare le scelte politiche in atto. Ad una storia politica e
culturale, che registra solo (o dà preminenza) le ragioni dei vincitori, facendo
coincidere la «verità» con il potere, bisogna contrapporre una storia, che analizza
edà profondità sociale di classe ai dibattiti, da cui le scelte sono scaturite ed i cui
esiti non sono mai meccanicisticamente determinati, neanche nelle scienze.
Il paragone lo facciamo con lo scontro nell'ambiente scientifico inglese degli
anni '30, perché ci paiono interessanti le somiglianze con alcuni problemi solleva-
ti oggi, ma ci premerà chiarire — è ovvio — anche le differenze notevoli, nel be-
ne e nel male.
Nell'estate del 1931 si tiene a Londra il I I Congresso Internazionale di Storia
della Scienza e della Tecnologia. L'avvenimento acquista subito un peso a causa
della partecipazione di una nutrita e qualificata delegazione sovietica, guidata da
Bukharin, e della sensibilità ambientale ai temi, che la crisi del '29 aveva portato
fin dentro il mondo degli scienziati. I tagli nei fondi per la ricerca, con la man-
canza di posti di lavoro per i giovani ricercatori, che cominciano a pesare nel '30,
dopo gli incrementi degli anni '20, pone sul tavolo anche degli scienziati il proble-
ma dello sviluppo delle scienze in rapporto alla crisi. È la scienza, che ha genera-
to la crisi? Perché il progresso scientifico non è stato in grado di migliorare lo
stato sociale e le prospettive della classe lavoratrice? Qual è la funzione della
scienza per uscire dalla crisi? La figura dello scienziato, che fa solo il suomestie-
re e non si occupa dell'uso sociale del prodotto del suo lavoro, si incrina anche a
livello sociale e la politica irrompe nei laboratori di ricerca. C'è fin un romanzet-
to, che dipinge come mostruoso un chimico, perché fa ricerche su gas velenosi
per uso bellico per conto del governo, spacciandoli poi per insetticidi e vantando-
si allegramente della propria intelligenza professionale. La BBC organizza un di-
battito in varie puntate tra il biologo Julian Huxley e il matematico marxista Hy-
man Levy sul rapporto tra scienza e società. Alla fine del ciclo, tra i due c'è ac-
cordo (cosa che non era all'inizio) nel considerare la scienza non come «un com-
pito astratto di ricerca di una verità universale, ma una funzione sociale legata in-
timamente con la storia umana e i destini umani». Vale la pena di precisare che
Huxley era stato un fautore dell'eugenetica, che pretendeva di risolvere il proble-
ma della' disoccupazione con una feroce politica para-nazista, di sterilizzazione e
di controllo delle nascite, sostenendo che la povertà era l'effetto di una mancanza
di doti naturali, spiegabile su base ereditaria. Ciò che rende interessante il muta-
mento di punto di vista è dunque evidente: mentre l'eugenetica significava dedur-
re sulla base di pretese necessità naturali, accertate scientificamente, le leggi del-
l'organizzazione sociale, ora l'interesse si sposta invece verso l'utilizzazione della
stessascienza in funzione dei fini, che la comunità sociale individua come giusti.
Lo scontro è tra chi rivendica piena libertà alla scienza, come attività impre-
vedibile e quindi non pianificabile (ad esempio M. Polanyi, filosofo conservato-
re), e chi invece spinge verso la pianificazione anche scientifica per uscire dalla
103
















