
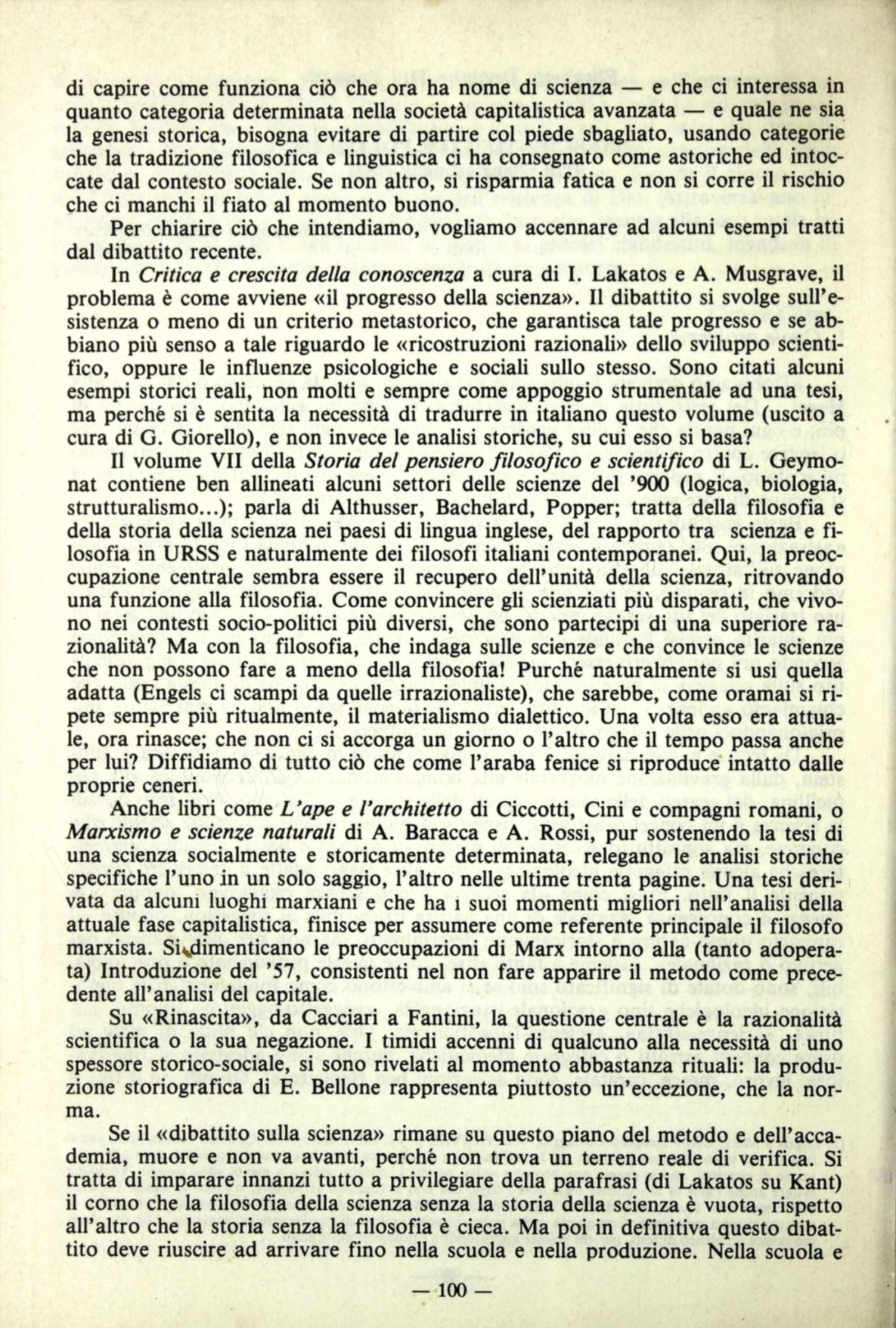
di capire come funziona ciò che ora ha nome di scienza e che ci interessa in
quanto categoria determinata nella società capitalistica avanzata — e quale ne sia
lagenesi storica, bisogna evitare di partire col piede sbagliato, usando categorie
che la tradizione filosofica e linguistica ci ha consegnatocome astoriche ed intoc-
cate dal contestosociale. Se non altro, si risparmia fatica e non si corre il rischio
checi manchi il fiato al momento buono.
Per chiarire ciò che intendiamo, vogliamo accennare ad alcuni esempi tratti
dal dibattito recente.
In
Critica
e
crescita della conoscenza
a cura di ! . Lakatos e A. Musgrave, il
problema è come avviene «il progresso della scienza». I l dibattito si svolge sull'e-
sistenza o meno di un criterio metastorico, che garantisca tale progresso e se ab-
biano più senso a tale riguardo le «ricostruzioni razionali» dello sviluppo scienti-
fico, oppure le influenze psicologiche e sociali sullo stesso. Sono citati alcuni
esempi storici reali, non molti e sempre come appoggio strumentale ad una tesi,
maperché si è sentita la necessità di tradurre in italiano questo volume (uscito a
cura di G. Giorello), e non invece le analisi storiche, su cui essosi basa?
Il volume VI I della Storia del pensiero filosofico e scientifico di L. Geymo-
nat contiene ben allineati alcuni settori delle scienze del '900 (logica, biologia,
strutturalismo...); parla di Althusser, Bachelard, Popper; tratta della filosofia e
della storia della scienza nei paesi di lingua inglese, del rapporto tra scienza e fi-
losofia in URSS e naturalmente dei filosofi italiani contemporanei. Qui, la preoc-
cupazione centrale sembraessere il recupero dell'unità della scienza, ritrovando
una funzione alla filosofia. Come convincere gli scienziati più disparati, che vivo-
nonei contesti socio-politici più diversi, che sono partecipi di una superiore ra-
zionalità? Ma con la filosofia, che indaga sulle scienze e che convince le scienze
chenon possono fare a meno della filosofia! Purché naturalmente si usi quella
adatta (Engels ci scampi da quelle irrazionaliste), che sarebbe, come oramai si ri-
petesempre più ritualmente, il materialismo dialettico. Una volta esso era attua-
le, ora rinasce; che non ci si accorga un giorno o l'altro che il tempopassaanche
per lui? Diffidiamo di tutto ciò che come l'araba fenice si riproduce intatto dalle
proprie ceneri.
Anche libri come
L'ape
e
l'architetto
di Ciccotti, Cini e compagni romani, o
Marxismo
e
scienze naturali
di A. Baracca e A. Rossi, pur sostenendo la tesi di
unascienza socialmente e storicamente determinata, relegano le analisi storiche
specifiche l'uno in un solosaggio, l'altro nelle ultime trenta pagine. Una tesi deri-
vata da alcuni luoghi marxiani e che ha i suoi momenti migliori nell'analisi della
attuale fase capitalistica, finisce per assumerecome referente principale il filosofo
marxista. Sikdimenticano le preoccupazioni di Marx intorno alla (tanto adopera-
ta) Introduzione del '57, consistenti nel non fare apparire il metodo come prece-
dente all'analisi del capitale.
Su«Rinascita», da Cacciari a Fantini, la questione centrale è la razionalità
scientifica o la sua negazione. I timidi accenni di qualcuno alla necessità di uno
spessorestorico-sociale, si sono rivelati al momento abbastanza rituali: la produ-
zione storiografica di E. Bellone rappresenta piuttosto un'eccezione, che la nor-
ma.
Se il «dibattito sulla scienza» rimane suquesto piano del metodo e dell'acca-
demia, muore e non va avanti, perché non trova un terreno reale di verifica. Si
tratta di imparare innanzi tutto a privilegiare della parafrasi (di Lakatos su Kant)
il corno che la filosofia della scienzasenza la storia della scienza è vuota, rispetto
all'altro che la storia senza la filosofia è cieca. Ma poi in definitiva questo dibat-
tito deve riuscire ad arrivare fino nella scuola e nella produzione. Nella scuola e
—100
















