
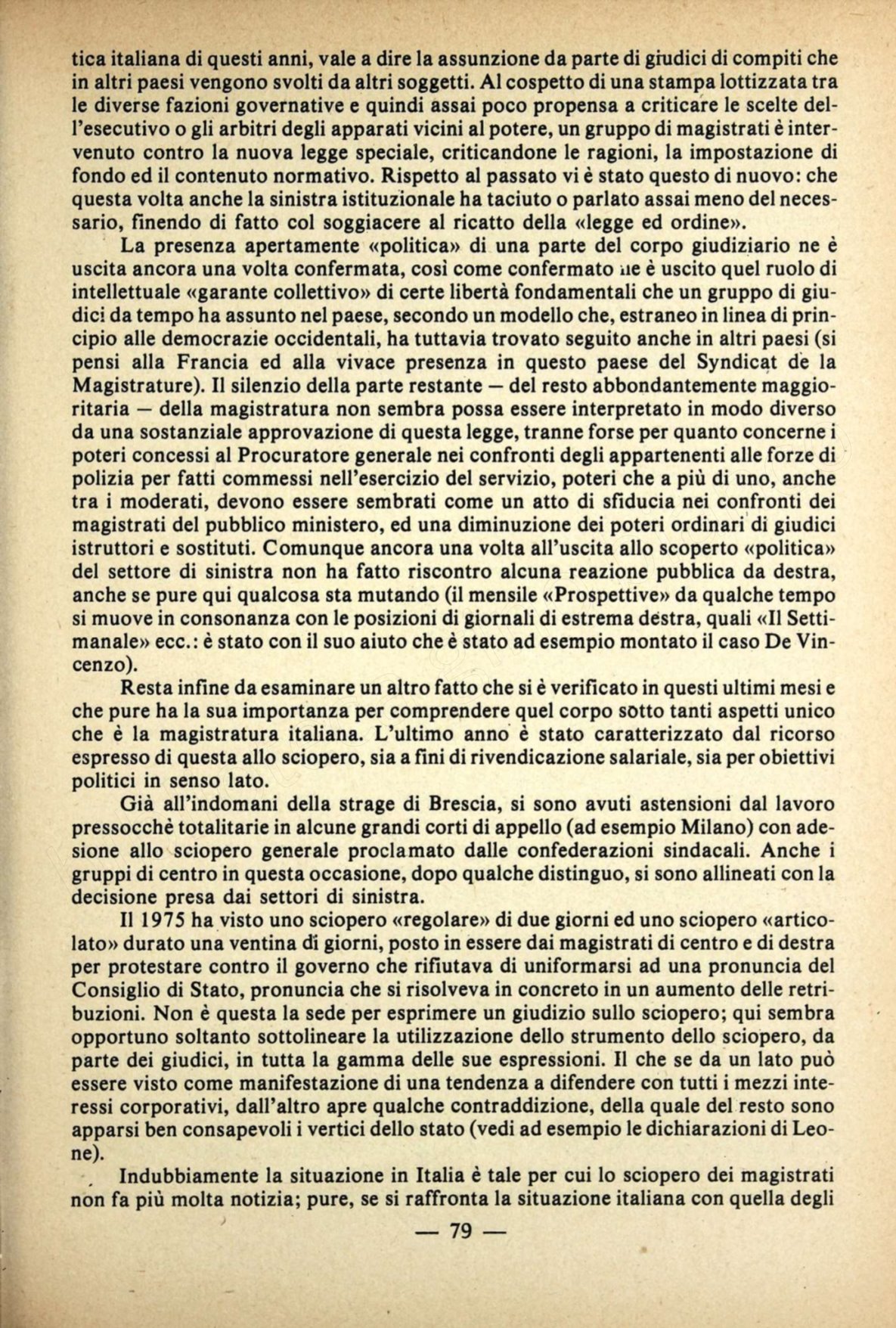
tica italiana di questi anni, vale a dire la assunzione da parte di giudici di compiti che
in altri paesi vengono svolti da altri soggetti. Al cospetto di una stampa lottizzata tra
le diverse fazioni governative e quindi assai poco propensa a criticare le scelte del-
l'esecutivo o gli arbitri degli apparati vicini al potere, un gruppo di magistrati è inter-
venuto contro la nuova legge speciale, criticandone le ragioni, la impostazione di
fondo ed il contenuto normativo. Rispetto al passato vi è stato questo di nuovo: che
questa volta anche la sinistra istituzionale ha taciuto o parlato assai meno del neces-
sario, finendo di fatto col soggiacere al ricatto della «legge ed ordine».
La presenza apertamente «politica» di una parte del corpo giudiziario ne è
uscita ancora una volta confermata, così come confermato ile è uscito quel ruolo di
intellettuale «garante collettivo» di certe libertà fondamentali che un gruppo di giu-
dici da tempo ha assunto nel paese, secondounmodello che, estraneo in linea di prin-
cipio alle democrazie occidentali, ha tuttavia trovato seguito anche in altri paesi (si
pensi alla Francia ed alla vivace presenza in questo paese del Syndicat de la
Magistrature). Il silenzio della parte restante—del resto abbondantemente maggio-
ritaria—della magistratura non sembra possa essere interpretato in modo diverso
da una sostanziale approvazione di questa legge, tranne forse per quanto concerne i
poteri concessi al Procuratore generale nei confronti degli appartenenti alle forze di
polizia per fatti commessi nell'esercizio del servizio, poteri che a più di uno, anche
tra i moderati, devono essere sembrati come un atto di sfiducia nei confronti dei
magistrati del pubblico ministero, ed una diminuzione dei poteri ordinari di giudici
istruttori e sostituti. Comunque ancora una volta all'uscita allo scoperto «politica»
del settore di sinistra non ha fatto riscontro alcuna reazione pubblica da destra,
anchese pure qui qualcosa sta mutando (il mensile «Prospettive» da qualche tempo
simuove in consonanza con le posizioni di giornali di estrema destra, quali «Il Setti-
manale» ecc.: è stato con il suo aiuto cheè stato ad esempio montato il caso De Vin-
cenzo).
Resta infine da esaminare un altro fatto chesi è verificato in questi ultimi mesi e
che pure ha la sua importanza per comprendere quel corpo sotto tanti aspetti unico
che è la magistratura italiana. L'ultimo anno è stato caratterizzato dal ricorso
espresso di questa allo sciopero, sia a fini di rivendicazione salariale, sia per obiettivi
politici in senso lato.
Già all'indomani della strage di Brescia, si sono avuti astensioni dal lavoro
pressocchè totalitarie in alcune grandi corti di appello (ad esempio Milano) con ade-
sione allo sciopero generale proclamato dalle confederazioni sindacali. Anche i
gruppi di centro in questa occasione, dopo qualche distinguo, si sono allineati con la
decisione presa dai settori di sinistra.
Il 1975 ha visto uno sciopero «regolare» di due giorni ed uno sciopero «artico-
lato» durato una ventina di giorni, posto in essere dai magistrati di centro e di destra
per protestare contro il governo che rifiutava di uniformarsi ad una pronuncia del
Consiglio di Stato, pronuncia che si risolveva in concreto in un aumento delle retri-
buzioni. Non è questa la sede per esprimere un giudizio sullo sciopero; qui sembra
opportuno soltanto sottolineare la utilizzazione dello strumento dello sciopero, da
parte dei giudici, in tutta la gamma delle sue espressioni. I l che se da un lato può
essere visto come manifestazione di una tendenza a difendere con tutti i mezzi inte-
ressi corporativi, dall'altro apre qualche contraddizione, della quale del resto sono
apparsi ben consapevoli i vertici dello stato (vedi ad esempio le dichiarazioni di Leo-
ne).
, Indubbiamente la situazione in Italia è tale per cui lo sciopero dei magistrati
non fa più molta notizia; pure, se si raffronta la situazione italiana con quella degli
— 79
















