
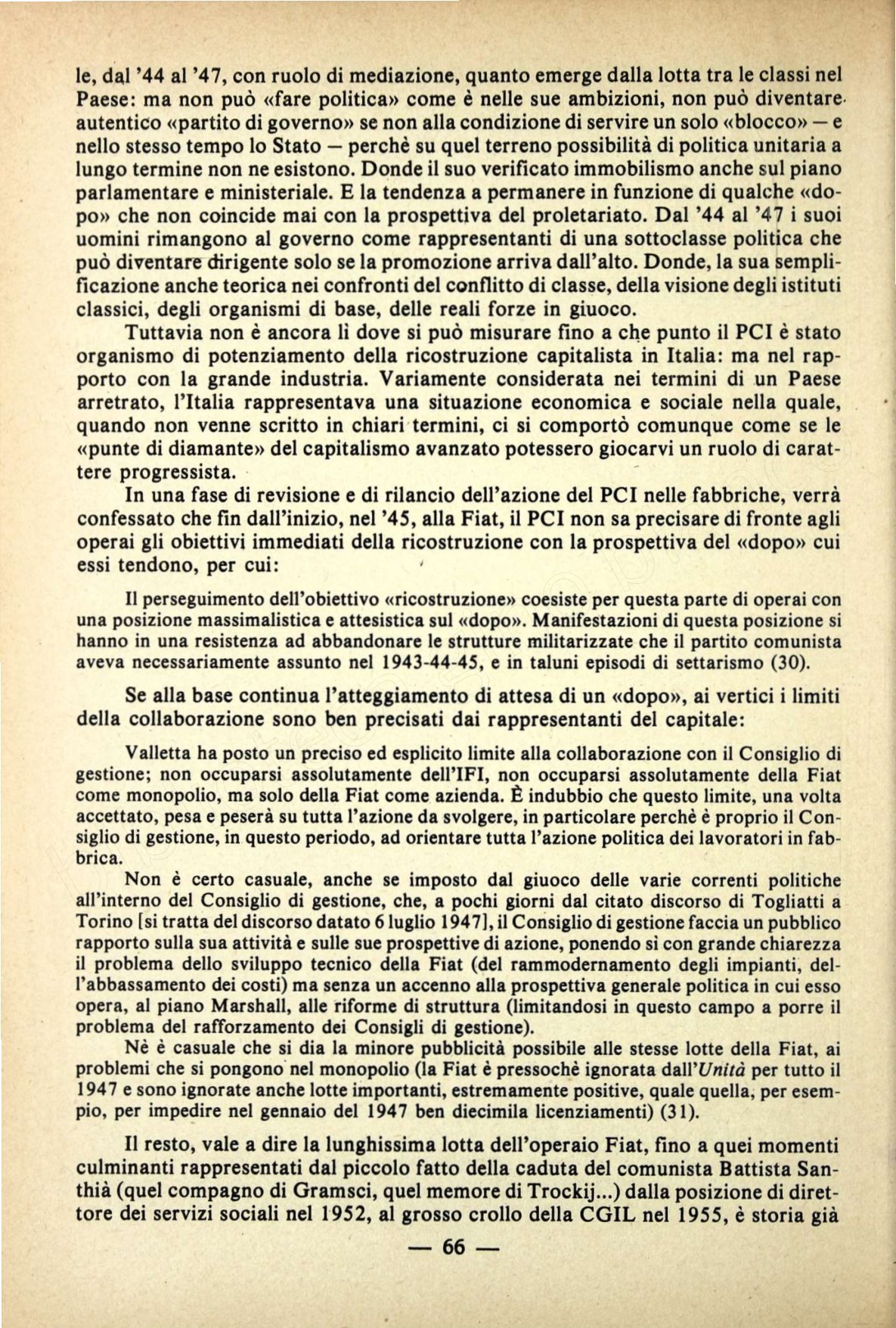
le, dal '44 al '47, con ruolo di mediazione, quanto emerge dalla lotta tra le classi nel
Paese: ma non può «fare politica» come è nelle sue ambizioni, non può diventare.
autentico «partito di governo» se non alla condizione di servire un solo «blocco»—e
nello stesso tempo lo Stato—perché su quel terreno possibilità di politica unitaria a
lungo termine non ne esistono. Donde il suo verificato immobilismo anche sul piano
parlamentare e ministeriale. E la tendenza a permanere in funzione di qualche «do-
po» che non coincide mai con la prospettiva del proletariato. Dal '44 al '47 i suoi
uomini rimangono al governo come rappresentanti di una sottoclasse politica che
può diventare dirigente solose la promozione arriva dall'alto. Donde, la sua sempli-
ficazione anche teorica nei confronti del conflitto di classe, della visione degli istituti
classici, degli organismi di base, delle reali forze in giuoco.
Tuttavia non è ancora li dove si può misurare fino a che punto il PCI è stato
organismo di potenziamento della ricostruzione capitalista in Italia: ma nel rap-
porto con la grande industria. Variamente considerata nei termini di un Paese
arretrato, l'Italia rappresentava una situazione economica e sociale nella quale,
quando non venne scritto in chiari termini, ci si comportò comunque come se le
«punte di diamante» del capitalismo avanzato potessero giocarvi un ruolo di carat-
tere progressista.
In una fase di revisione e di rilancio dell'azione del PCI nelle fabbriche, verrà
confessato che fin dall'inizio, nel '45, alla Fiat, il PCI non sa precisare di fronte agli
operai gli obiettivi immediati della ricostruzione con la prospettiva del «dopo» cui
essi tendono, per cui:
Il perseguimento dell'obiettivo «ricostruzione» coesiste per questa parte di operai con
una posizione massimalistica e attesistica sul «dopo». Manifestazioni di questa posizione si
hanno in una resistenza ad abbandonare le strutture militarizzate che il partito comunista
aveva necessariamente assunto nel 1943-44-45, e in taluni episodi di settarismo (30).
Se alla base continua l'atteggiamento di attesa di un «dopo», ai vertici i limiti
della collaborazione sono ben precisati dai rappresentanti del capitale:
Valletta ha posto un preciso ed esplicito limite alla collaborazione con il Consiglio di
gestione; non occuparsi assolutamente dell'IFI, non occuparsi assolutamente della Fiat
comemonopolio, ma solo della Fiat come azienda. È indubbio che questo limite, una volta
accettato, pesa e peserà su tutta l'azione da svolgere, in particolare perché è proprio il Con-
siglio di gestione, in questo periodo, ad orientare tutta l'azione politica dei lavoratori in fab-
brica.
Non è certo casuale, anche se imposto dal giuoco delle varie correnti politiche
all'interno del Consiglio di gestione, che, a pochi giorni dal citato discorso di Togliatti a
Torino [si tratta del discorso datato 6 luglio 1947], il Consiglio di gestione faccia un pubblico
rapporto sulla sua attività e sulle sue prospettive di azione, ponendo sì con grande chiarezza
il problema dello sviluppo tecnico della Fiat (del rammodernamento degli impianti, del-
l'abbassamento dei costi) ma senza un accenno alla prospettiva generale politica in cui esso
opera, al piano Marshall, alle riforme di struttura (limitandosi in questo campo a porre il
problema del rafforzamento dei Consigli di gestione).
Nè è casuale che si dia la minore pubblicità possibile alle stesse lotte della Fiat, ai
problemi che si pongono nel monopolio (la Fiat è pressochè ignorata
dall'Unità
per tutto il
1947 e sono ignorate anche lotte importanti, estremamente positive, quale quella, per esem-
pio, per impedire nel gennaio del 1947 ben diecimila licenziamenti) (31).
Il resto, vale a dire la lunghissima lotta dell'operaio Fiat, fino a quei momenti
culminanti rappresentati dal piccolo fatto della caduta del comunista Battista San-
thià (quel compagno di Gramsci, quel memore di Trockij...) dalla posizione di diret-
tore dei servizi sociali nel 1952, al grosso crollo della CGIL nel 1955, è storia già
66
















