
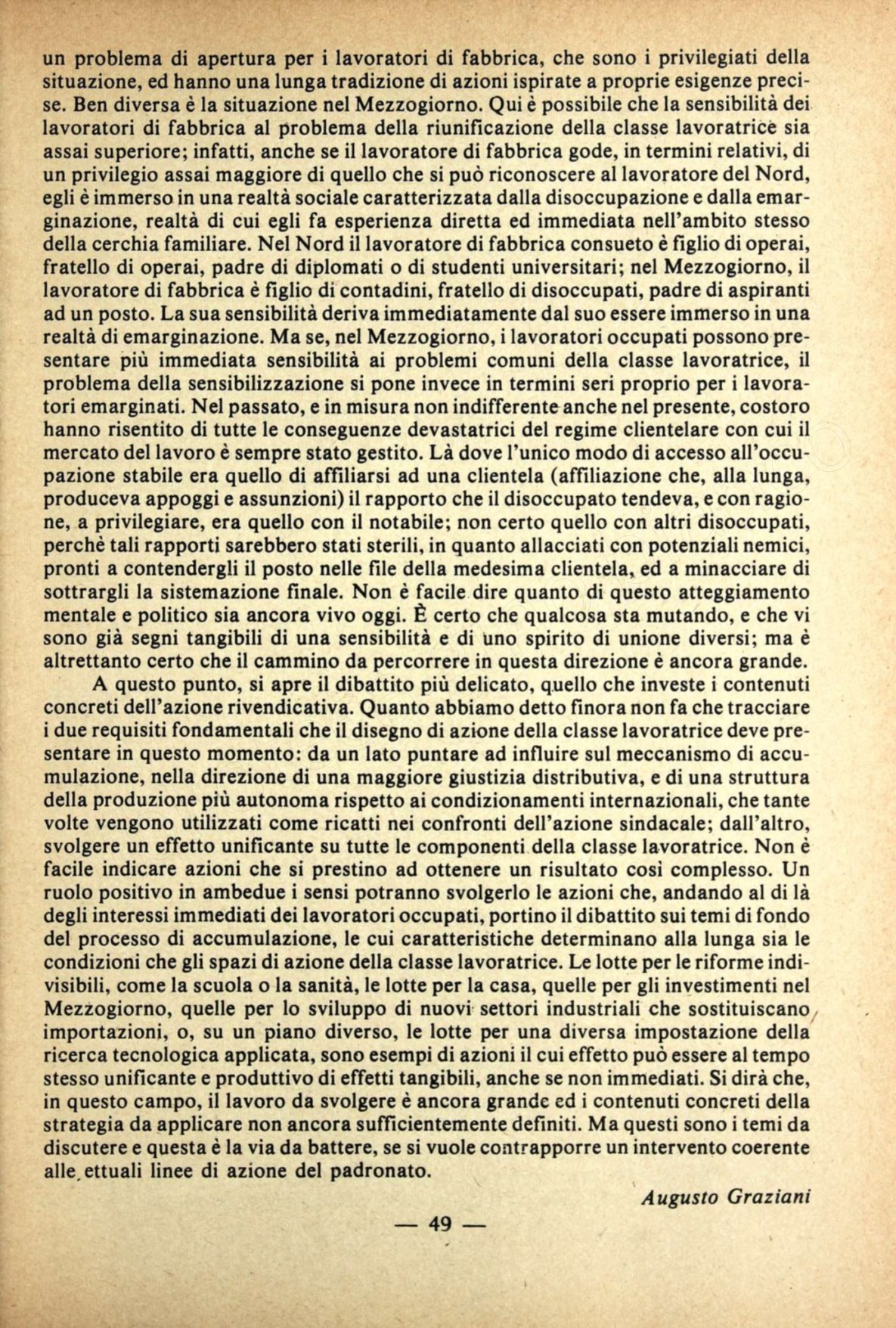
un problema di apertura per i lavoratori di fabbrica, che sono i privilegiati della
situazione, ed hanno una lunga tradizione di azioni ispirate a proprie esigenze preci-
se. Ben diversa è la situazione nel Mezzogiorno. Qui è possibile che la sensibilità dei
lavoratori di fabbrica al problema della riunificazione della classe lavoratrice sia
assai superiore; infatti, anche se il lavoratore di fabbrica gode, in termini relativi, di
un privilegio assai maggiore di quello che si può riconoscere al lavoratore del Nord,
egli è immerso in una realtà sociale caratterizzata dalla disoccupazione e dalla emar-
ginazione, realtà di cui egli fa esperienza diretta ed immediata nell'ambito stesso
della cerchia familiare. Nel Nord il lavoratore di fabbrica consueto è figlio di operai,
fratello di operai, padre di diplomati o di studenti universitari; nel Mezzogiorno, il
lavoratore di fabbrica è figlio di contadini, fratello di disoccupati, padre di aspiranti
ad un posto. La sua sensibilità deriva immediatamente dal suo essere immerso in una
realtà di emarginazione. Ma se, nel Mezzogiorno, i lavoratori occupati possono pre-
sentare più immediata sensibilità ai problemi comuni della classe lavoratrice, i l
problema della sensibilizzazione si pone invece in termini seri proprio per i lavora-
tori emarginati. Nel passato, e in misura non indifferente anche nel presente, costoro
hanno risentito di tutte le conseguenze devastatrici del regime clientelare con cui il
mercato del lavoro è sempre stato gestito. Là dove l'unico modo di accesso all'occu-
pazione stabile era quello di affiliarsi ad una clientela (affiliazione che, alla lunga,
produceva appoggi e assunzioni) il rapporto che il disoccupato tendeva, e con ragio-
ne, a privilegiare, era quello con il notabile; non certo quello con altri disoccupati,
perchè tali rapporti sarebbero stati sterili, in quanto allacciati con potenziali nemici,
pronti a contendergli il posto nelle file della medesima clientela, ed a minacciare di
sottrargli la sistemazione finale. Non è facile dire quanto di questo atteggiamento
mentale e politico sia ancora vivo oggi. È certo che qualcosa sta mutando, e che vi
sono già segni tangibili di una sensibilità e di uno spirito di unione diversi; ma è
altrettanto certo che il cammino da percorrere in questa direzione è ancora grande.
A questo punto, si apre il dibattito più delicato, quello che investe i contenuti
concreti dell'azione rivendicativa. Quanto abbiamo detto finora non fa che tracciare
i due requisiti fondamentali che il disegno di azione della classe lavoratrice deve pre-
sentare in questo momento: da un lato puntare ad influire sul meccanismo di accu-
mulazione, nella direzione di una maggiore giustizia distributiva, e di una struttura
della produzione più autonoma rispetto ai condizionamenti internazionali, che tante
volte vengono utilizzati come ricatti nei confronti dell'azione sindacale; dall'altro,
svolgere un effetto unificante su tutte le componenti della classe lavoratrice. Non è
facile indicare azioni che si prestino ad ottenere un risultato così complesso. Un
ruolo positivo in ambedue i sensi potranno svolgerlo le azioni che, andando al di là
degli interessi immediati dei lavoratori occupati, portino il dibattito sui temi di fondo
del processo di accumulazione, le cui caratteristiche determinano alla lunga sia le
condizioni che gli spazi di azione della classe lavoratrice. Le lotte per le riforme indi-
visibili, come la scuola o la sanità, le lotte per la casa, quelle per gli investimenti nel
Mezzogiorno, quelle per lo sviluppo di nuovi settori industriali che sostituiscano
importazioni, o, su un piano diverso, le lotte per una diversa impostazione della
ricerca tecnologica applicata, sono esempi di azioni il cui effetto può essere al tempo
stesso unificante e produttivo di effetti tangibili, anche se non immediati. Si dirà che,
in questo campo, il lavoro da svolgere è ancora grande ed i contenuti concreti della
strategia da applicare non ancora sufficientemente definiti. Ma questi sono i temi da
discutere e questa è la via da battere, se si vuole contrapporre un intervento coerente
alle, ettuali linee di azione del padronato.
49
Augusto Graziani
















