
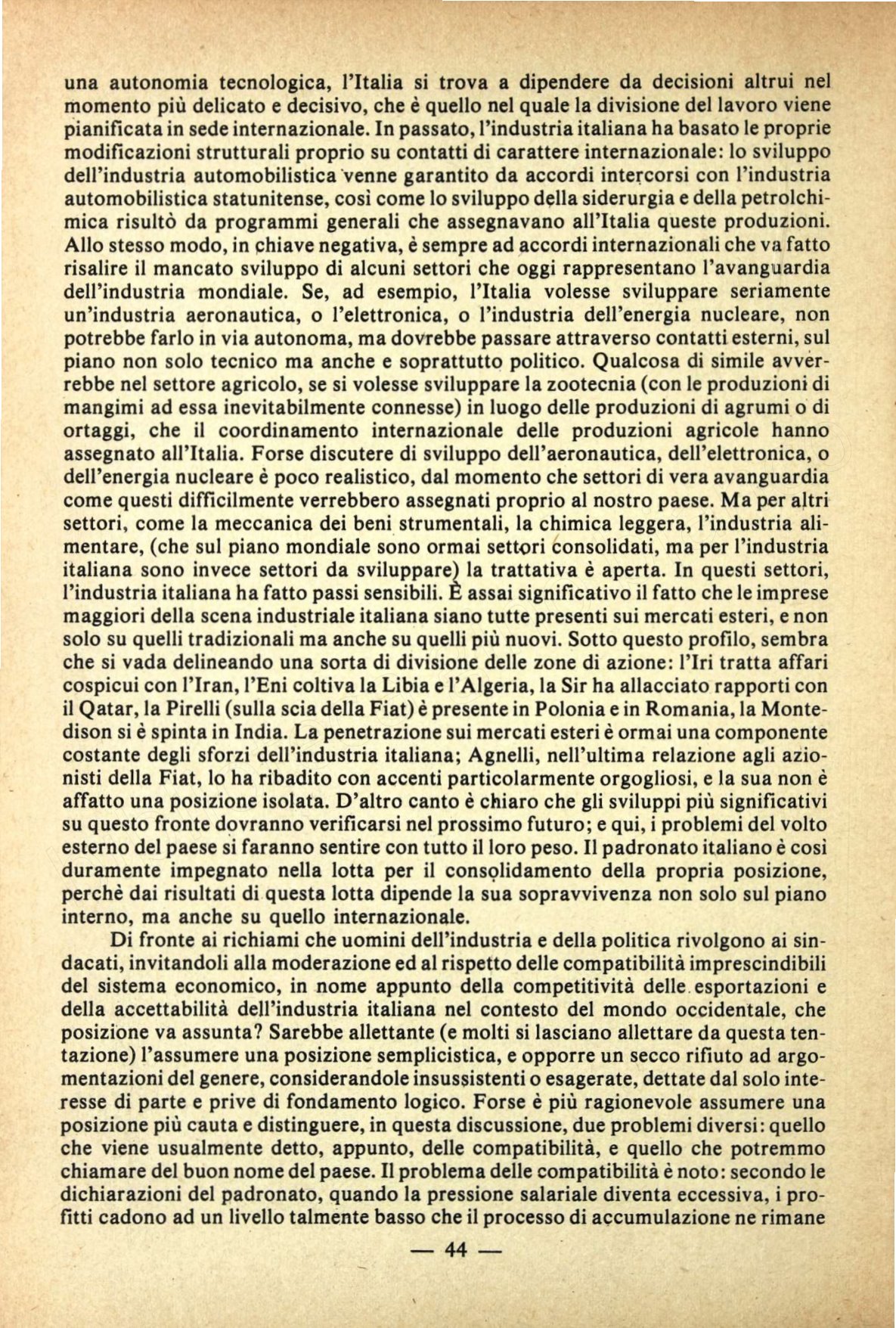
una autonomia tecnologica, l ' I tal ia si trova a dipendere da decisioni al trui nel
momento più delicato e decisivo, che è quello nel quale la divisione del lavoro viene
pianificata in sede internazionale. In passato, l'industria italiana ha basato le proprie
modificazioni strutturali proprio su contatti di carattere internazionale: lo sviluppo
dell'industria automobilistica venne garantito da accordi intercorsi con l'industria
automobilistica statunitense, così come lo sviluppo della siderurgia e della petrolchi-
mica risultò da programmi generali che assegnavano all'Italia queste produzioni.
Allo stesso modo, in chiave negativa, è sempre ad accordi internazionali che va fatto
risalire il mancato sviluppo di alcuni settori che oggi rappresentano l'avanguardia
dell'industria mondiale. Se, ad esempio, l ' I tal ia volesse sviluppare seriamente
un'industria aeronautica, o l'elettronica, o l'industria dell'energia nucleare, non
potrebbe farlo in via autonoma, ma dovrebbe passare attraverso contatti esterni, sul
piano non solo tecnico ma anche e soprattutto politico. Qualcosa di simile avver-
rebbe nel settore agricolo, se si volesse sviluppare la zootecnia (con le produzioni di
mangimi ad essa inevitabilmente connesse) in luogo delle produzioni di agrumi o di
ortaggi, che i l coordinamento internazionale delle produzioni agricole hanno
assegnato all'Italia. Forse discutere di sviluppo dell'aeronautica, dell'elettronica, o
dell'energia nucleare è poco realistico, dal momento che settori di vera avanguardia
come questi difficilmente verrebbero assegnati proprio al nostro paese. Ma per altri
settori, come la meccanica dei beni strumentali, la chimica leggera, l'industria ali-
mentare, (che sul piano mondiale sono ormai settori consolidati, ma per l'industria
italiana sono invece settori da sviluppare) la trattativa è aperta. In questi settori,
l'industria italiana ha fatto passi sensibili. E assai significativo il fatto che le imprese
maggiori della scena industriale italiana siano tutte presenti sui mercati esteri, e non
solo su quelli tradizionali ma anche su quelli più nuovi. Sotto questo profilo, sembra
che si vada delineando una sorta di divisione delle zone di azione: l ' Ir i tratta affari
cospicui con l'Iran, l'Eni coltiva la Libia e l'Algeria, la Sir ha allacciato rapporti con
il Qatar, la Pirelli (sulla scia della Fiat) è presente in Polonia e in Romania, la Monte-
dison si è spinta in India. La penetrazione sui mercati esteri è ormai una componente
costante degli sforzi dell'industria italiana; Agnelli, nell'ultima relazione agli azio-
nisti della Fiat, lo ha ribadito con accenti particolarmente orgogliosi, e la sua non è
affatto una posizione isolata. D'altro canto è chiaro che gli sviluppi più significativi
su questo fronte dovranno verificarsi nel prossimo futuro; e qui, i problemi del volto
esterno del paese si faranno sentire con tutto il loro peso. Il padronato italiano è così
duramente impegnato nella lotta per i l consolidamento della propria posizione,
perchè dai risultati di questa lotta dipende la sua sopravvivenza non solo sul piano
interno, ma anche su quello internazionale.
Di fronte ai richiami che uomini dell'industria e della politica rivolgono ai sin-
dacati, invitandoli alla moderazione ed al rispetto delle compatibilità imprescindibili
del sistema economico, in nome appunto della competitività delle esportazioni e
della accettabilità dell'industria italiana nel contesto del mondo occidentale, che
posizione va assunta? Sarebbe allettante (e molti si lasciano allettare da questa ten-
tazione) l'assumere una posizione semplicistica, e opporre un secco rifiuto ad argo-
mentazioni del genere, considerandole insussistenti o esagerate, dettate dal solo inte-
resse di parte e prive di fondamento logico. Forse è più ragionevole assumere una
posizione più cauta e distinguere, in questa discussione, due problemi diversi: quello
che viene usualmente detto, appunto, delle compatibilità, e quello che potremmo
chiamare del buon nome del paese. Il problema delle compatibilità è noto: secondo le
dichiarazioni del padronato, quando la pressione salariale diventa eccessiva, i pro-
fitti cadono ad un livello talmente basso che il processo di accumulazione ne rimane
44
















