
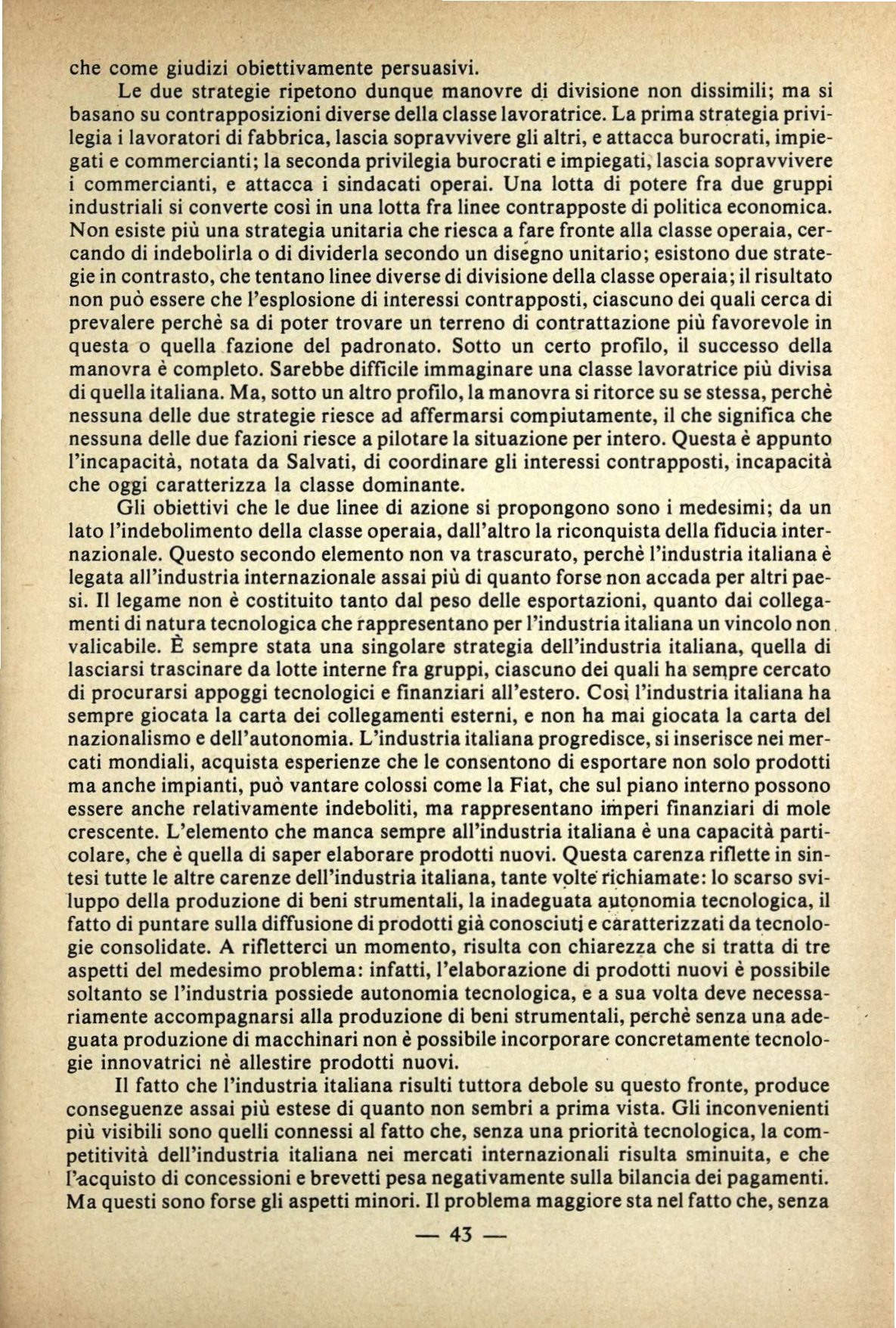
che come giudizi obiettivamente persuasivi.
Le due strategie ripetono dunque manovre di divisione non dissimili; ma si
basano su contrapposizioni diverse della classe lavoratrice. La prima strategia privi-
legia i lavoratori di fabbrica, lascia sopravvivere gli altri, e attacca burocrati, impie-
gati e commercianti; la seconda privilegia burocrati e impiegati, lascia sopravvivere
i commercianti, e attacca i sindacati operai. Una lotta di potere fra due gruppi
industriali si converte così in una lotta fra linee contrapposte di politica economica.
Non esiste più una strategia unitaria che riesca a fare fronte alla classe operaia, cer-
cando di indebolirla o di dividerla secondo un disegno unitario; esistono due strate-
gie in contrasto, che tentano linee diverse di divisione della classe operaia; il risultato
non può essere che l'esplosione di interessi contrapposti, ciascuno dei quali cerca di
prevalere perché sa di poter trovare un terreno di contrattazione più favorevole in
questa o quella fazione del padronato. Sotto un certo profilo, i l successo della
manovra è completo. Sarebbe difficile immaginare una classe lavoratrice più divisa
di quella italiana. Ma, sotto un altro profilo, la manovra si ritorce su se stessa, perché
nessuna delle due strategie riesce ad affermarsi compiutamente, il che significa che
nessuna delle due fazioni riesce a pilotare la situazione per intero. Questa è appunto
l'incapacità, notata da Salvati, di coordinare gli interessi contrapposti, incapacità
che oggi caratterizza la classe dominante.
Gli obiettivi che le due linee di azione si propongono sono i medesimi; da un
lato l'indebolimento della classe operaia, dall'altro la riconquista della fiducia inter-
nazionale. Questo secondo elemento non va trascurato, perché l'industria italiana è
legata all'industria internazionale assai più di quanto forse non accada per altri pae-
si. I l legame non è costituito tanto dal peso delle esportazioni, quanto dai collega-
menti di natura tecnologica che rappresentano per l'industria italiana un vincolo non
valicabile. È sempre stata una singolare strategia dell'industria italiana, quella di
lasciarsi trascinare da lotte interne fra gruppi, ciascuno dei quali ha sempre cercato
di procurarsi appoggi tecnologici e finanziari all'estero. Così l'industria italiana ha
sempre giocata la carta dei collegamenti esterni, e non ha mai giocata la carta del
nazionalismo e dell'autonomia. L'industria italiana progredisce, si inserisce nei mer-
cati mondiali, acquista esperienze che le consentono di esportare non solo prodotti
ma anche impianti, può vantare colossi come la Fiat, che sul piano interno possono
essere anche relativamente indeboliti, ma rappresentano imperi finanziari di mole
crescente. L'elemento che manca sempre all'industria italiana è una capacità parti-
colare, che è quella di saper elaborare prodotti nuovi. Questa carenza riflette in sin-
tesi tutte le altre carenze dell'industria italiana, tante volte richiamate: lo scarso svi-
luppo della produzione di beni strumentali, la inadeguata autonomia tecnologica, il
fatto di puntare sulla diffusione di prodotti già conosciuti e caratterizzati da tecnolo-
gie consolidate. A rifletterci un momento, risulta con chiarezza che si tratta di tre
aspetti del medesimo problema: infatti, l'elaborazione di prodotti nuovi è possibile
soltanto se l'industria possiede autonomia tecnologica, e a sua volta deve necessa-
riamente accompagnarsi alla produzione di beni strumentali, perché senza una ade-
guata produzione di macchinari non è possibile incorporare concretamente tecnolo-
gie innovatrici nè allestire prodotti nuovi.
Il fatto che l'industria italiana risulti tuttora debole su questo fronte, produce
conseguenze assai più estese di quanto non sembri a prima vista. Gli inconvenienti
più visibili sono quelli connessi al fatto che, senza una priorità tecnologica, la com-
petitività dell'industria italiana nei mercati internazionali risulta sminuita, e che
P-acquisto di concessioni e brevetti pesa negativamente sulla bilancia dei pagamenti.
Ma questi sono forse gli aspetti minori. Il problema maggiore sta nel fatto che, senza
43
















