
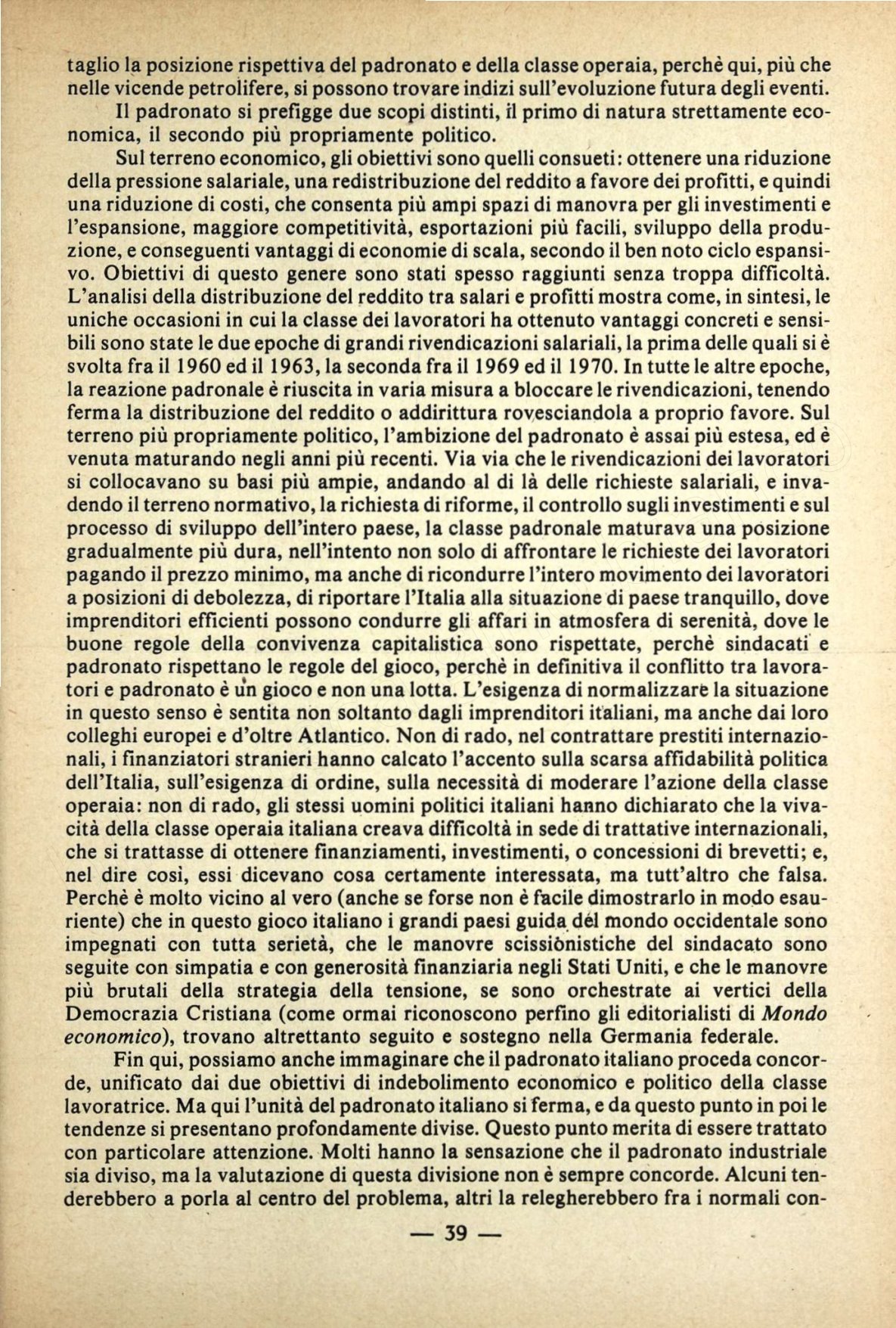
taglio la posizione rispettiva del padronato e della classe operaia, perché qui, più che
nelle vicende petrolifere, si possono trovare indizi sull'evoluzione futura degli eventi.
Il padronato si prefigge due scopi distinti, il primo di natura strettamente eco-
nomica, i l secondo più propriamente politico.
Sul terreno economico, gli obiettivi sono quelli consueti: ottenere una riduzione
della pressione salariale, una redistribuzione del reddito a favore dei profitti, e quindi
una riduzione di costi, che consenta più ampi spazi di manovra per gli investimenti e
l'espansione, maggiore competitività, esportazioni più facili, sviluppo della produ-
zione, e conseguenti vantaggi di economie di scala, secondo il ben noto ciclo espansi-
vo. Obiettivi di questo genere sono stati spesso raggiunti senza troppa difficoltà.
L'analisi della distribuzione del reddito tra salari e profitti mostra come, in sintesi, le
uniche occasioni in cui la classe dei lavoratori ha ottenuto vantaggi concreti e sensi-
bili sono state le due epoche di grandi rivendicazioni salariali, la prima delle quali si è
svolta fra il 1960 ed il 1963, la seconda fra il 1969 ed il 1970. In tutte le altre epoche,
la reazione padronale è riuscita in varia misura a bloccare le rivendicazioni, tenendo
ferma la distribuzione del reddito o addirittura rovesciandola a proprio favore. Sul
terreno più propriamente politico, l'ambizione del padronato è assai più estesa, ed è
venuta maturando negli anni più recenti. Via via che le rivendicazioni dei lavoratori
si collocavano su basi più ampie, andando al di là delle richieste salariali, e inva-
dendo il terreno normativo, la richiesta di riforme, il controllo sugli investimenti e sul
processo di sviluppo dell'intero paese, la classe padronale maturava una posizione
gradualmente più dura, nell'intento non solo di affrontare le richieste dei lavoratori
pagando il prezzo minimo, ma anche di ricondurre l'intero movimento dei lavoratori
a posizioni di debolezza, di riportare l'Italia alla situazione di paese tranquillo, dove
imprenditori efficienti possono condurre gli affari in atmosfera di serenità, dove le
buone regole della convivenza capitalistica sono rispettate, perché sindacati e
padronato rispettano le regole del gioco, perchè in definitiva il conflitto tra lavora-
tori e padronato è tin gioco e non una lotta. L'esigenza di normalizzare la situazione
in questo senso è sentita non soltanto dagli imprenditori italiani, ma anche dai loro
colleghi europei e d'oltre Atlantico. Non di rado, nel contrattare prestiti internazio-
nali, i finanziatori stranieri hanno calcato l'accento sulla scarsa affidabilità politica
dell'Italia, sull'esigenza di ordine, sulla necessità di moderare l'azione della classe
operaia: non di rado, gli stessi uomini politici italiani hanno dichiarato che la viva-
cità della classe operaia italiana creava difficoltà in sede di trattative internazionali,
che si trattasse di ottenere finanziamenti, investimenti, o concessioni di brevetti; e,
nel dire così, essi dicevano cosa certamente interessata, ma tutt'altro che falsa.
Perchè è molto vicino al vero (anche se forse non è facile dimostrarlo in modo esau-
riente) che in questo gioco italiano i grandi paesi guida dei mondo occidentale sono
impegnati con tut ta serietà, che le manovre scissiónistiche del sindacato sono
seguite con simpatia e con generosità finanziaria negli Stati Uniti, e che le manovre
più brutal i della strategia della tensione, se sono orchestrate a i vert ici del la
Democrazia Cristiana (come ormai riconoscono perfino gli editorialisti di
Mondo
economico),
trovano altrettanto seguito e sostegno nella Germania federale.
Fin qui, possiamo anche immaginare che il padronato italiano proceda concor-
de, unificato dai due obiettivi di indebolimento economico e politico della classe
lavoratrice. Ma qui l'unità del padronato italiano si ferma, e da questo punto in poi le
tendenze si presentano profondamente divise. Questo punto merita di essere trattato
con particolare attenzione. Mol t i hanno la sensazione che il padronato industriale
sia diviso, ma la valutazione di questa divisione non è sempre concorde. Alcuni ten-
derebbero a porla al centro del problema, altri la relegherebbero fra i normali con-
39
















